Le considerazioni del paragrafo precedente cominciano a delineare differenze importanti fra le figure professionali presenti nel database Miur-Cineca, che finora abbiamo distinto soltanto come docenti/ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato. Il titolo di questo paragrafo si riferisce, invece, alla distinzione fra personale docente di ruolo , o strutturato (professori ordinari, professori associati e ricercatori a tempo indeterminato) e il personale non strutturato (ricercatori a tempo determinato e titolari di assegni di ricerca).
In questa sezione, oltre che entrare maggiormente nel dettaglio delle differenze fra alcune di queste figure, getteremo anche uno sguardo sulle altre figure della docenza e della ricerca che popolano e animano l’università italiana: i docenti a contratto e i collaboratori in attività di ricerca. In breve: oltre che distinguere fra docenti/ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato, preciseremo anche le caratteristiche di alcune figure “a tempo indeterminato” e di quelle che lavorano in maniera temporanea.
La docenza universitaria è concettualmente costruita come una “piramide”, al cui vertice sono i professori ordinari e la cui base è costituita da forze giovani e ancora non perfettamente mature. La numerosità dei docenti e delle fasce non ha sempre rispecchiato questa organizzazione. Ad esempio, tra il 1999 e il 2006 la quota degli ordinari era cresciuta tanto da conferire una forma a clessidra alla distribuzione del corpo docente (Cfr. Rapporto ANVUR 2016 : 360), ancora visibile nel 2008.
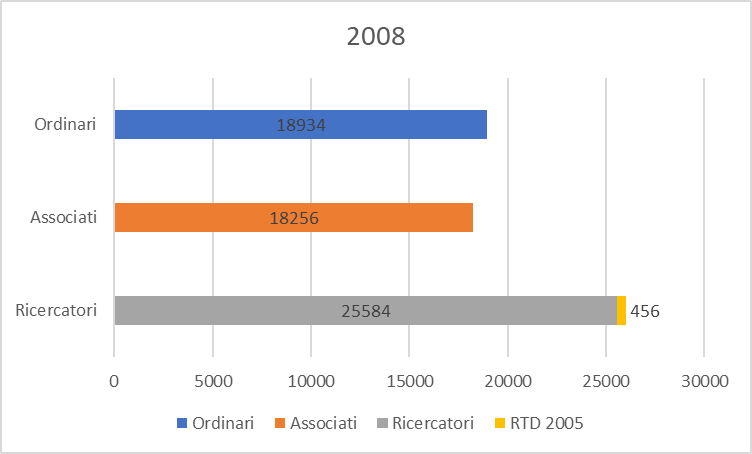
Figura 93 . Numerosità dei docenti/ricercatori. Valori assoluti. Anno 2008. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
Nella figura precedente è appena visibile, nella fascia dei ricercatori, la numerosità dei ricercatori a tempo determinato, figura introdotta, come più volte ripetuto, dalla legge 230/2005 .
Dopo la legge 240/2010 , si è ripristinata una configurazione piramidale, con «una larga base di ricercatori, una quota lievemente minore di professori associati nella fascia centrale e, infine, una piccola quota di ordinari al vertice» ( Rapporto ANVUR 2018 : 264).
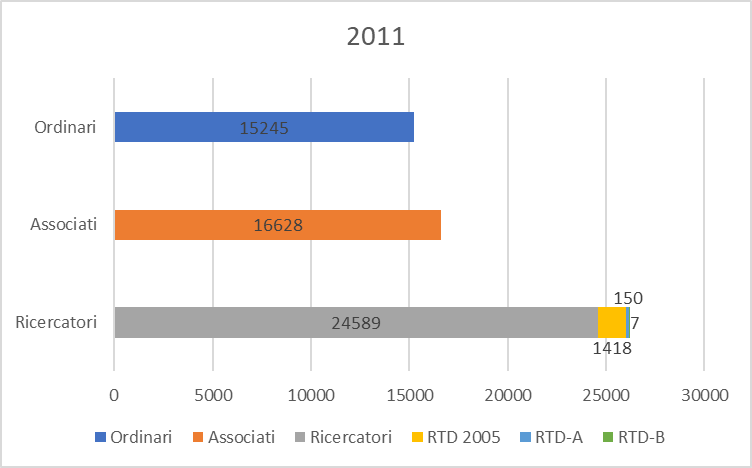
Figura 94 . Numerosità dei docenti/ricercatori. Valori assoluti. Anno 2011. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
Nella figura precedente, nella fascia dei ricercatori sono comprese ben quattro tipologie differenti di ricercatore: i ricercatori a tempo indeterminato, i ricercatori a tempo determinato legge 230/2005 e i ricercatori a tempo determinato legge 240/2010 di tipo A e di tipo B (questi ultimi, all’epoca, in tutto 7 e dunque poco visibili nel grafico).
Anche nel 2014, la figura disegnata dalla distribuzione dei docenti/ricercatori è piramidale.
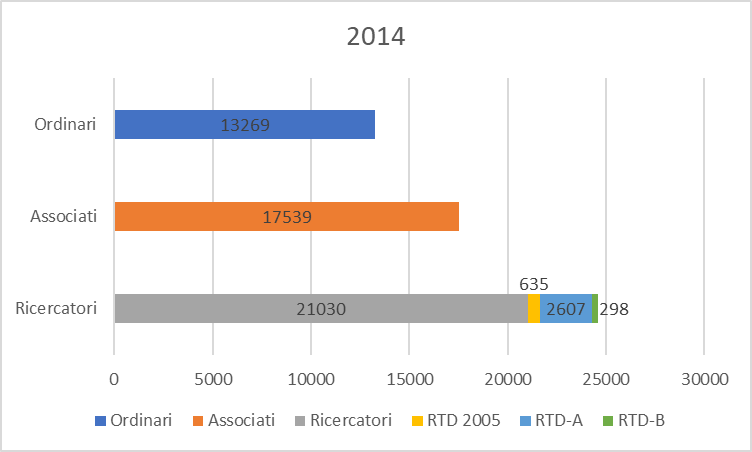
Figura 95 . Numerosità dei docenti/ricercatori. Valori assoluti. Anno 2014. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
Nella figura precedente, nella fascia dei ricercatori le quattro tipologie di ricercatore sono tutte visibili.
Nel 2017 – che, come abbiamo detto più volte, è l’anno del picco negativo nella numerosità dei docenti/ricercatori – comincia a farsi evidente il restringimento della base della piramide.
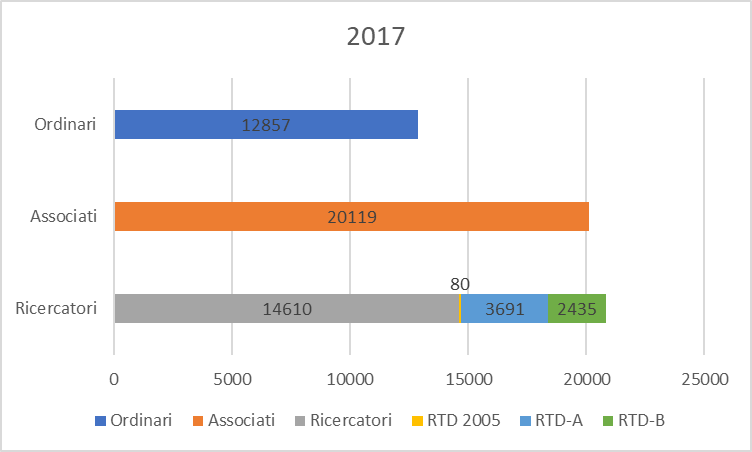
Figura 96 . Numerosità dei docenti/ricercatori. Valori assoluti. Anno 2017. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
Nella figura precedente la fascia dei ricercatori comprende ancora una maggioranza di ricercatori a tempo indeterminato; gli RTD legge 230/2005 sono quasi scomparsi, mentre gli RTD-A e gli RTD-B legge 240/2010 sono ormai ben presenti.
Nel 2020, la piramide presenta un netto squilibrio: la fascia dei ricercatori non solo comprende categorie fra loro molto differenti, ma si è anche ridotta quantitativamente, ed è ben al di sotto del numero degli associati.
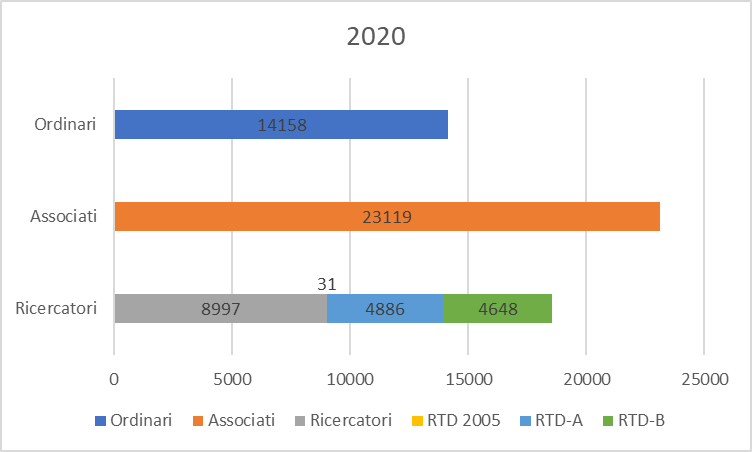
Figura 97 . Numerosità dei docenti/ricercatori. Valori assoluti. Anno 2020. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
Nella figura precedente si evince come, nella fascia dei ricercatori, si sia compiuto il sorpasso numerico dei ricercatori a tempo determinato sui ricercatori a tempo indeterminato.
Per “riequilibrare” questa piramide fornendole una “base” abbiamo provato a inserire nella fascia dei ricercatori anche il numero degli assegnisti di ricerca.
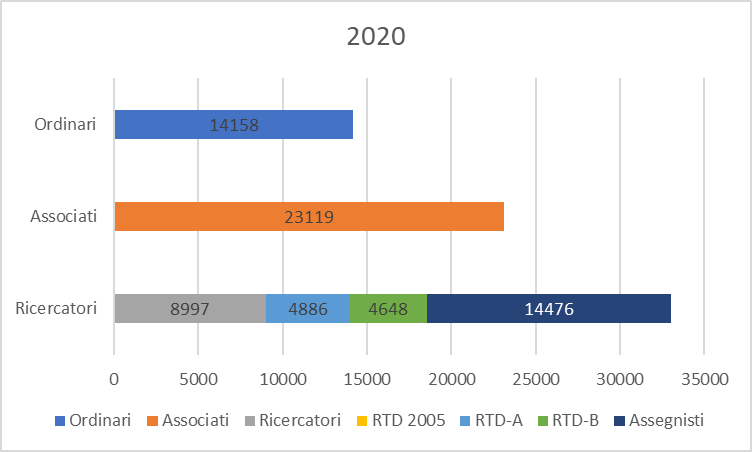
Figura 98 . Numerosità dei docenti/ricercatori e degli assegnisti. Valori assoluti. Anno 2020. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
Bisogna a questo punto fare alcune considerazioni sull’eterogeneità dei componenti della “base frammentata” che abbiamo composto. Innanzitutto va problematizzata la piena appartenenza di alcune figure alla categoria dei “ricercatori”. Con la parziale eccezione degli assegnisti di ricerca, che possono o meno assumere incarichi di insegnamento secondo le differenti normative dei regolamenti di ateneo, la base della piramide è più propriamente costituita da docenti/ricercatori . Gli RTD-A e gli RTD-B lo sono perché così è previsto dalla legge che li istituisce. I ricercatori a tempo indeterminato, come meglio vedremo in seguito, lo sono per necessità di copertura degli insegnamenti, per concessione legislativa e per prassi consolidate.
Inoltre, queste figure sono molto differenti tra loro:
– Ricercatori a tempo indeterminato – ormai in esaurimento da 10 anni e per oltre un terzo abilitati (in valori assoluti: 455 abilitati alla prima fascia; 3224 alla seconda fascia), sono destinati a sparire entro qualche anno, per passaggio a una fascia più alta o per pensionamento;
– RTD-B – potremmo considerarli esclusi dalla categoria degli “a tempo determinato” e iniziare a pensarli come associati in pectore . Il contratto di RTD-B è attualmente l’unica porta per la stabilizzazione e sempre più sovente coloro che vengono assunti sono già abilitati, in modo da poter più sicuramente passare nella fascia degli associati;
– RTD-A e Assegnisti sono invece tra loro “diversamente precari”, i primi con un contratto di tre anni, i secondi con un contratto da uno a tre anni. Comuni sono i destini possibili: un contratto da RTD-B (prima del compimento del nono anno di “precariato”) o – compiuti i 12 anni di contratti di diversi tipo – l’espulsione.
Nella figura seguente, proviamo a distinguere le figure a tempo indeterminato – Professori ordinari, associati e ricercatori – da quella a “tempo indeterminato in pectore ” degli RTD-B, e da quelle effettivamente a tempo determinato. Da queste ultime abbiamo escluso gli RTD 2005 per la loro estrema esiguità (31 in valori assoluti nel 2020).
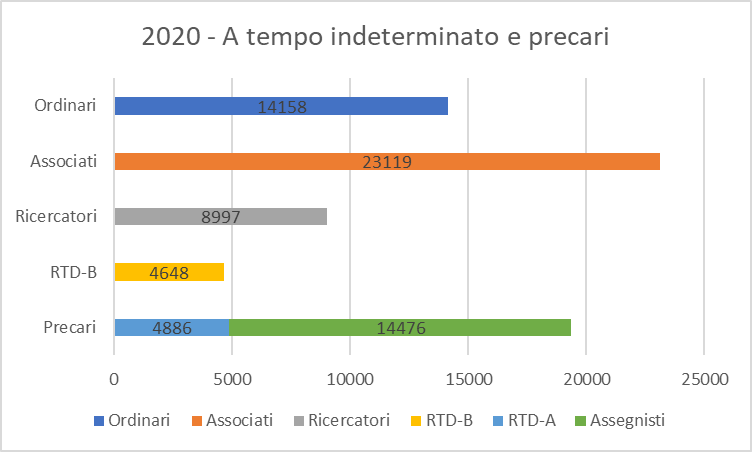
Figura 99 . Numerosità dei docenti/ricercatori e degli assegnisti. Valori assoluti. Anno 2020. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
In questa figura i ricercatori a tempo indeterminato e gli RTD-B sono, come abbiamo detto, accomunati dal destino di diventare professori associati se abilitati [69] o di “uscire”: i primi per pensionamento, i secondi dall’alveo del “tempo indeterminato”.
Ma anche i “precari” hanno sicuramente un punto in comune: competono tutti per diventare RTD-B e l’alternativa a questo esito è l’uscita dal sistema della ricerca (quanto meno della ricerca universitaria).
In breve, ferma restando la legislazione, la linea dei ricercatori a tempo indeterminato è destinata a scomparire, la linea degli RTD-B sarà come sempre legata alle disposizioni sul turnover e a eventuali futuri “piani straordinari”, e la base di questa figura geometrica – che potremmo definire come una piramide con una strozzatura appena sopra la base – sarà definitivamente costituita soltanto da “precari” con prospettive di stabilizzazione piuttosto incerte.
Iniziamo con l’identificare la numerosità degli strutturati.
Tabella 182 . Numerosità dei docenti/ricercatori a tempo indeterminato per genere. Anni 2008-2020. Valori assoluti, variazioni percentuali e percentuali sul totale. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca .
|
Anno |
Professori Ordinari |
Professori Associati |
Ricercatori Universitari |
Totale |
Totale |
% sul totale generale |
||||
|
Donne |
Uomini |
Donne |
Uomini |
Donne |
Uomini |
Donne |
Uomini |
|||
|
2008 |
3568 |
15366 |
6177 |
12079 |
11546 |
14038 |
21291 |
41483 |
62774 |
98,50% |
|
2009 |
3422 |
14458 |
5985 |
11580 |
11502 |
13933 |
20909 |
39971 |
60880 |
98,42% |
|
2010 |
3185 |
12669 |
5816 |
11142 |
11289 |
13647 |
20290 |
37458 |
57748 |
97,67% |
|
2011 |
3148 |
12097 |
5760 |
10868 |
11131 |
13458 |
20039 |
36423 |
56462 |
97,00% |
|
2012 |
3031 |
11492 |
5629 |
10517 |
11029 |
13233 |
19689 |
35242 |
54931 |
95,61% |
|
2013 |
2934 |
10958 |
5529 |
10277 |
10822 |
12918 |
19285 |
34153 |
53438 |
94,40% |
|
2014 |
2832 |
10437 |
6238 |
11301 |
9757 |
11273 |
18827 |
33011 |
51838 |
93,22% |
|
2015 |
2777 |
10106 |
7308 |
12728 |
8288 |
9144 |
18373 |
31978 |
50351 |
91,94% |
|
2016 |
2880 |
10096 |
7410 |
12514 |
7650 |
8332 |
17940 |
30942 |
48882 |
89,61% |
|
2017 |
2958 |
9899 |
7546 |
12573 |
7055 |
7555 |
17559 |
30027 |
47586 |
87,87% |
|
2018 |
3130 |
10054 |
7982 |
12801 |
6195 |
6406 |
17307 |
29261 |
46568 |
85,17% |
|
2019 |
3395 |
10293 |
8747 |
13535 |
5301 |
5400 |
17443 |
29228 |
46671 |
83,53% |
|
2020 |
3586 |
10572 |
9325 |
13794 |
4466 |
4531 |
17377 |
28897 |
46274 |
82,27% |
Nel 2008, per quanto fossero state già introdotte figure a tempo determinato dalla legge 230/2005 , la c.d. “Moratti”, la quasi totalità dei docenti/ricercatori contabilizzati dal sistema Miur-Cineca era di ruolo. Nei 12 anni intercorsi le cose sono significativamente cambiate per la radicale modifica del sistema di reclutamento già prefigurato dalla “Moratti” e definitivamente entrato in auge con la legge 240/2010 . Quest’ultima legge ha eliminato la figura di ricercatore a tempo indeterminato e ha introdotto le due figure di ricercatore a tempo determinato di tipo A e B delle quali si sono già brevemente delineate le caratteristiche. Tutti i nuovi reclutati a partire dal 2010 sono allora a tempo determinato, almeno formalmente, perché, come abbiamo visto, gli RTD-B abilitati sono “virtualmente a tempo indeterminato”.
Tabella 183 . Numerosità dei docenti e dei ricercatori a tempo determinato. Anni 2008-2020. Valori assoluti, variazioni percentuali e percentuali sul totale. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
|
Anno |
RTD 2005 |
RTD-A |
RTD-B |
Straordinari t.d. |
Totale |
Totale |
% sul totale generale |
|||||
|
Donne |
Uomini |
Donne |
Uomini |
Donne |
Uomini |
Donne |
Uomini |
Donne |
Uomini |
|||
|
2008 |
183 |
273 |
4 |
10 |
187 |
283 |
470 |
0,74% |
||||
|
2009 |
243 |
382 |
5 |
16 |
248 |
398 |
646 |
1,04% |
||||
|
2010 |
455 |
677 |
3 |
2 |
8 |
33 |
463 |
715 |
1178 |
1,99% |
||
|
2011 |
597 |
821 |
73 |
77 |
2 |
5 |
11 |
37 |
683 |
940 |
1623 |
2,79% |
|
2012 |
533 |
704 |
484 |
637 |
6 |
14 |
12 |
52 |
1035 |
1407 |
2442 |
4,25% |
|
2013 |
405 |
515 |
854 |
1117 |
49 |
65 |
27 |
90 |
1335 |
1787 |
3122 |
5,52% |
|
2014 |
291 |
344 |
1115 |
1492 |
116 |
182 |
35 |
161 |
1557 |
2179 |
3736 |
6,72% |
|
2015 |
205 |
236 |
1275 |
1682 |
268 |
432 |
48 |
249 |
1796 |
2599 |
4395 |
8,03% |
|
2016 |
102 |
108 |
1374 |
1873 |
758 |
1134 |
52 |
249 |
2286 |
3364 |
5650 |
10,36% |
|
2017 |
38 |
42 |
1601 |
2090 |
998 |
1437 |
54 |
295 |
2691 |
3864 |
6555 |
12,10% |
|
2018 |
25 |
30 |
1757 |
2236 |
1519 |
2146 |
66 |
319 |
3367 |
4731 |
8098 |
14,81% |
|
2019 |
25 |
26 |
2029 |
2405 |
1777 |
2503 |
80 |
348 |
3911 |
5282 |
9193 |
16,45% |
|
2020 |
16 |
15 |
2225 |
2661 |
1928 |
2720 |
83 |
319 |
4252 |
5715 |
9967 |
17,72% |
A partire dalla legge 240/2010 fra i docenti/ricercatori a tempo indeterminato c’è dunque un ruolo “in esaurimento”, quello dei ricercatori universitari (RU), del quale esamineremo ora brevemente le caratteristiche.
Benché la legge che istituiva il ruolo vietasse esplicitamente l’attribuzione di incarichi di docenza ai ricercatori universitari ( DPR 382/1980, art. 1 ), dal 1990 ( L. 341/90, art. 12 ) i ricercatori confermati – e dal 1995 anche i non confermati – possono dare il loro consenso all’attribuzione da parte delle strutture didattiche di affidamenti o supplenze di corsi o moduli. Da quel momento una parte progressivamente sempre più notevole dell’offerta didattica è sostenuta da ricercatori a tempo indeterminato. Nello stesso tempo la messa in esaurimento prevista a partire dal 2013 dalla legge 230/2005 (la c.d. “legge Moratti”) e anticipata al 2011 dalla legge 240/2010 (la c.d. “legge Gelmini”), e la istituzione, con questa stessa legge, della figura di RDT-B, mette i ricercatori a tempo indeterminato su una sorta di binario morto. Ripetute misure legislative e interventi finanziari sono stati diretti a favorire il passaggio dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale a professori associati. Già la legge 240/2010 aveva riservato a questo scopo apposite risorse per gli anni 2011 e seguenti, sulla base di un piano straordinario poi attuato con decreti ministeriali del 2011 e del 2012 e messo in atto a partire dal 2014, dopo i risultati della prima tornata di abilitazioni. Il passaggio dei ricercatori abilitati alla seconda fascia è proseguito con alterne vicende ma, come abbiamo visto, il 36,08% dei ricercatori in servizio nel 2010 è ancora “in esaurimento” e il 40,89% di essi è abilitato alla prima o alla seconda fascia. L’ultimo provvedimento in merito è un nuovo “piano straordinario” ( D.M. 84, 14 maggio 2020 ) per la progressione di carriera di circa 1.034 ricercatori a tempo indeterminato abilitati, che dovrebbero diventare professori associati entro il 2022.
In breve, a dieci anni dalla messa in esaurimento, i ricercatori a tempo indeterminato sono ancora il 16% dei docenti/ricercatori a tempo indeterminato e determinato (valore assoluto: 8.997): RTD-A e RTD-B sommati ne sono il 17% (valore assoluto 9.534).
Nel corso dell’esposizione ci siamo già soffermati su alcune caratteristiche di questa fascia, ma le dedicheremo qui ulteriore spazio per riassumere e completare alcune informazioni.
Come si evince dalle tabelle e dal grafico seguenti, la messa in esaurimento della figura di ricercatore a tempo indeterminato sta producendo effetti differenti fra ricercatori e ricercatrici.
Tabella 184 . Numerosità dei ricercatori a tempo indeterminato per genere. Anni 2008-2020. Valori assoluti e variazioni percentuali. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
|
Anno |
Ricercatrici |
Ricercatori |
Totale |
|
2008 |
11546 |
14038 |
25584 |
|
2009 |
11502 |
13933 |
25435 |
|
2010 |
11289 |
13647 |
24936 |
|
2011 |
11131 |
13458 |
24589 |
|
2012 |
11029 |
13233 |
24262 |
|
2013 |
10822 |
12918 |
23740 |
|
2014 |
9757 |
11273 |
21030 |
|
2015 |
8288 |
9144 |
17432 |
|
2016 |
7650 |
8332 |
15982 |
|
2017 |
7055 |
7555 |
14610 |
|
2018 |
6195 |
6406 |
12601 |
|
2019 |
5301 |
5400 |
10701 |
|
2020 |
4466 |
4531 |
8997 |
|
-61,32% |
-67,72% |
-64,83% |
I ricercatori a tempo indeterminato sono diminuiti del 67,72% e le ricercatrici del 61,32%, per un decremento del totale della fascia del 64,83%.
Tabella 185 . Ricercatori a tempo indeterminato per genere. Anni 2008-2020. Valori percentuali sul totale della fascia. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
|
Anno |
Ricercatrici |
Ricercatori |
|
2008 |
45,1% |
54,9% |
|
2009 |
45,2% |
54,8% |
|
2010 |
45,3% |
54,7% |
|
2011 |
45,3% |
54,7% |
|
2012 |
45,5% |
54,5% |
|
2013 |
45,6% |
54,4% |
|
2014 |
46,4% |
53,6% |
|
2015 |
47,5% |
52,5% |
|
2016 |
47,9% |
52,1% |
|
2017 |
48,3% |
51,7% |
|
2018 |
49,2% |
50,8% |
|
2019 |
49,5% |
50,5% |
|
2020 |
49,6% |
50,4% |
Ne deriva che la percentuale di ricercatrici sul totale della fascia cresce, pur non raggiungendo ancora – a livello nazionale – il 50%. Il grafico seguente (che ripropone in valori assoluti i contenuti della Figura 7 ) visualizza questa dinamica.
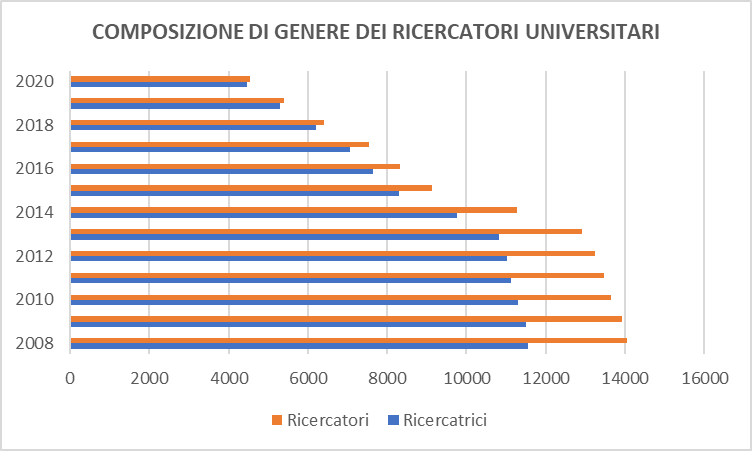
Figura 100 . Numerosità dei ricercatori a tempo indeterminato per genere. Anni 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020. Valori assoluti. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
Si è più volte ricordato, nelle precedenti sezioni, che le dinamiche dell’ esaurimento dei ricercatori a tempo indeterminato hanno volumi e velocità differenti nelle tre macro-aree del Paese, così che la variazione percentuale dal 2008 al 2020 è stata – rispetto alla già ricordata media nazionale del -64,83% – del -68,64% al Nord, del -63,74% al Centro e del -61,03% al Sud e nelle Isole.
Nella seguente tabella metteremo in evidenza la percentuale di ricercatrici e ricercatori a tempo indeterminato sul totale docenti/ricercatori nelle tre macro-aree del Paese.
Tabella 186 . Ricercatori a tempo indeterminato nelle tre macro-aree del Paese. Anni 2008-2020. Valori percentuali sul totale dei docenti/ricercatori dell’area. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
|
Anno |
Ricercatori Nord |
Ricercatori Centro |
Ricercatori Sud e Isole |
|
2008 |
39,36% |
38,78% |
42,29% |
|
2009 |
40,28% |
39,74% |
43,36% |
|
2010 |
40,84% |
41,54% |
44,48% |
|
2011 |
41,29% |
41,62% |
44,04% |
|
2012 |
41,15% |
41,38% |
44,38% |
|
2013 |
40,80% |
41,09% |
44,18% |
|
2014 |
34,83% |
38,47% |
41,40% |
|
2015 |
28,70% |
32,47% |
35,64% |
|
2016 |
26,03% |
30,03% |
33,27% |
|
2017 |
23,34% |
27,72% |
31,53% |
|
2018 |
19,38% |
23,75% |
27,78% |
|
2019 |
15,85% |
20,16% |
23,12% |
|
2020 |
13,01% |
17,05% |
19,55% |
Come si evince dalla tabella, la percentuale di ricercatrici e ricercatori a tempo indeterminato sul totale dei docenti/ricercatori dell’area è storicamente più alta al Sud e nelle Isole. Tuttavia, mentre tale differenza nel 2008 era di meno di 3 punti percentuali rispetto alle regioni del Nord e di circa 3,5 punti percentuali rispetto al Centro, nel 2020 tali differenze diventano di oltre 6 punti percentuali rispetto al Nord e di circa 2,5 punti rispetto al Centro. Ciò è evidenziato dal grafico seguente, che prende in considerazione gli anni dall’introduzione della legge “Gelmini” e dalla messa in esaurimento dei ricercatori a tempo indeterminato al 2020.
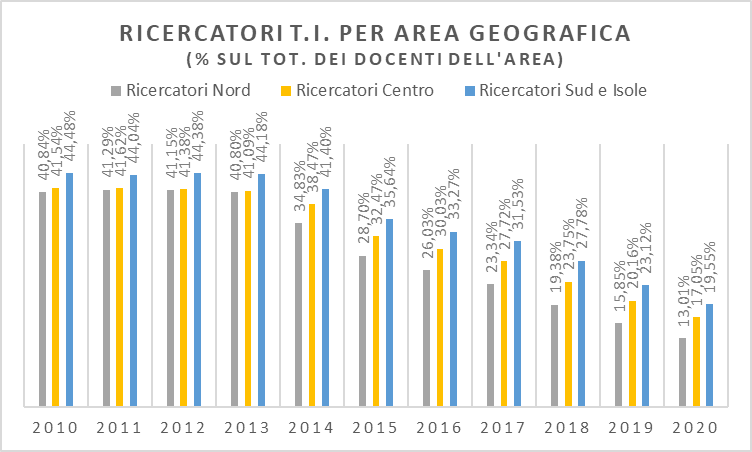
Figura 101 . Ricercatori a tempo indeterminato nelle tre macro-aree del Paese. Anni 2010-2020. Valori percentuali sul totale dell’area geografica. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
Nella tabella seguente presentiamo le percentuali di ricercatrici e ricercatori a tempo indeterminato delle tre macro-aree del Paese sul totale delle ricercatrici e dei ricercatori a tempo indeterminato italiani.
Tabella 187 . Distribuzione dei ricercatori a tempo indeterminato nelle tre macro-aree del Paese. Anni 2008-2020. Valori percentuali sul totale della fascia. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
|
Anno |
Ricercatori Nord |
Ricercatori Centro |
Ricercatori Sud e Isole |
|
2008 |
40,92% |
25,45% |
33,63% |
|
2009 |
40,87% |
25,56% |
33,56% |
|
2010 |
40,71% |
25,99% |
33,30% |
|
2011 |
41,47% |
25,66% |
32,86% |
|
2012 |
41,59% |
25,29% |
33,12% |
|
2013 |
41,68% |
25,13% |
33,18% |
|
2014 |
39,65% |
26,10% |
34,25% |
|
2015 |
38,99% |
26,04% |
34,97% |
|
2016 |
38,56% |
26,14% |
35,30% |
|
2017 |
37,86% |
26,11% |
36,03% |
|
2018 |
37,27% |
25,91% |
36,82% |
|
2019 |
36,75% |
26,27% |
36,98% |
|
2020 |
36,49% |
26,24% |
37,27% |
|
Variaz. punti perc. |
-4,43 |
+0,79 |
+3,64 |
Possiamo osservare che, come è evidente anche nel grafico seguente, le percentuali sul totale della fascia decrescono al Nord di oltre 4 punti percentuali (4,43) e viceversa crescono al Centro (meno di un punto percentuale: 0,79), e al Sud e nelle Isole di oltre 3 punti percentuali (3,64).
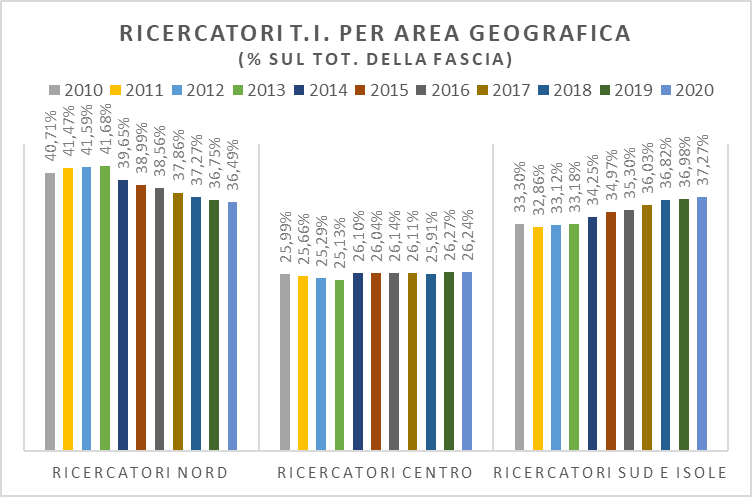
Figura 102 . Ricercatori a tempo indeterminato nelle tre macro-aree del Paese. Anni 2010-2020. Valori percentuali sul totale della fascia. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
Nel grafico seguente presenteremo, in valori percentuali, la consistenza della fascia sul totale generale dei docenti/ricercatori nelle tre macro-aree del Paese, evidenziando in tal modo le differenti dinamiche della decrescita.
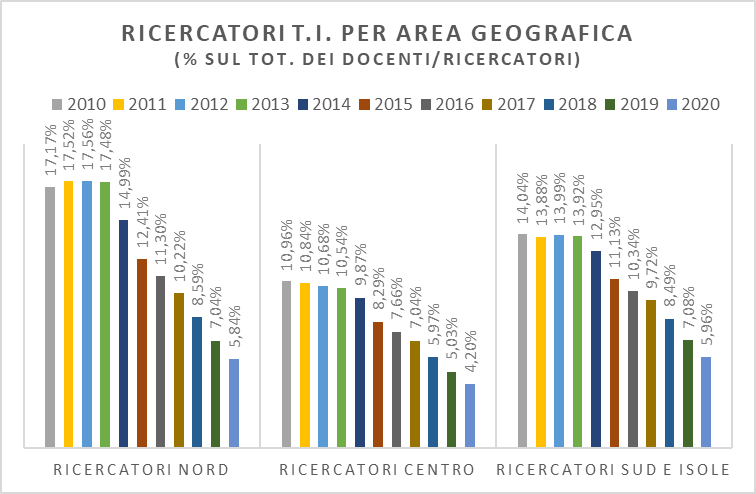
Figura 103 . Ricercatori a tempo indeterminato nelle tre macro-aree del Paese. Anni 2010-2020. Valori percentuali sui totali generali. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
Nella tabella e nel grafico seguenti si ribadisce, in valori percentuali sui totali dei docenti/ricercatori delle aree geografiche, quanto già evidenziato dai valori assoluti: una differente incidenza dei ricercatori a tempo indeterminato sul totale dei docenti/ricercatori nelle macro-aree e il passaggio da una situazione di maggiore numerosità della componente maschile della fascia si è passati a una quasi-parità.
Tabella 188 . Ricercatori a tempo indeterminato per genere nelle tre macro-aree del Paese. Anni 2008-2020. Valori percentuali sul totale dei docenti/ricercatori dell’area geografica. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
|
Anno |
NORD |
CENTRO |
SUD e ISOLE |
|||
|
Ricercatrici |
Ricercatori |
Ricercatrici |
Ricercatori |
Ricercatrici |
Ricercatori |
|
|
2008 |
17,66% |
21,70% |
17,71% |
21,08% |
19,06% |
23,24% |
|
2009 |
18,08% |
22,21% |
18,19% |
21,54% |
19,61% |
23,76% |
|
2010 |
18,36% |
22,48% |
19,03% |
22,51% |
20,12% |
24,36% |
|
2011 |
18,58% |
22,71% |
18,92% |
22,69% |
20,01% |
24,03% |
|
2012 |
18,59% |
22,56% |
18,90% |
22,48% |
20,26% |
24,12% |
|
2013 |
18,41% |
22,39% |
18,84% |
22,24% |
20,31% |
23,87% |
|
2014 |
16,06% |
18,77% |
17,88% |
20,59% |
19,32% |
22,08% |
|
2015 |
13,60% |
15,10% |
15,44% |
17,04% |
17,01% |
18,63% |
|
2016 |
12,43% |
13,60% |
14,32% |
15,71% |
16,02% |
17,25% |
|
2017 |
11,24% |
12,10% |
13,33% |
14,39% |
15,31% |
16,21% |
|
2018 |
9,53% |
9,85% |
11,51% |
12,24% |
13,79% |
13,99% |
|
2019 |
7,87% |
7,97% |
9,92% |
10,24% |
11,48% |
11,65% |
|
2020 |
6,46% |
6,55% |
8,35% |
8,69% |
9,79% |
9,76% |
Vediamo ora l’incidenza percentuale delle ricercatrici e dei ricercatori delle tre macro-aree sul totale nazionale negli anni 2010, 2015, 2020.
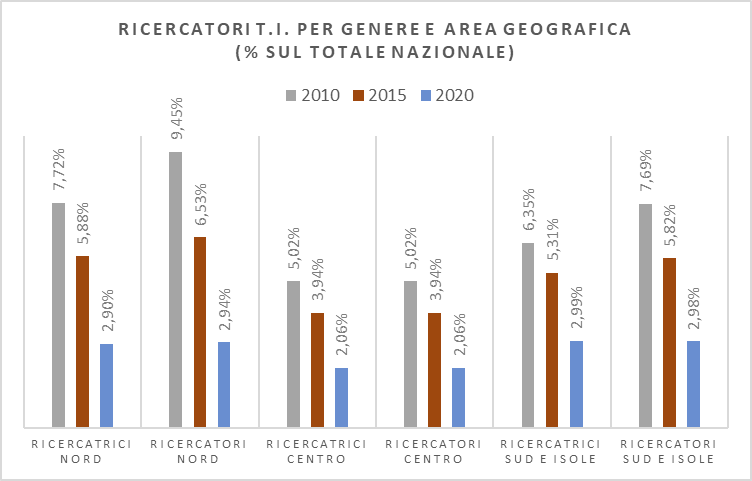
Figura 104 . Ricercatori a tempo indeterminato per genere nelle tre macro-aree del Paese. Anni 2010, 2015, 2020. Valori percentuali sul totale nazionale. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
Anticipiamo ora alcune osservazioni sulla numerosità delle ricercatrici e dei ricercatori a tempo indeterminato nelle 14 aree Concorsuali individuate dal Consiglio Universitario Nazionale, note come aree CUN.
Nella tabella seguente presentiamo la numerosità della fascia nelle aree CUN dal 2008 al 2020 in valori assoluti e le variazioni percentuali nel periodo preso in esame.
Tabella 189 . Numerosità dei ricercatori a tempo indeterminato nelle aree CUN. Anni 2008-2020. Valori assoluti e variazioni percentuali. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
|
Anno |
Area 01 |
Area 02 |
Area 03 |
Area 04 |
Area 05 |
Area 06 |
Area 07 |
Area 08 |
Area 09 |
Area 10 |
Area 11 |
Area 12 |
Area 13 |
Area 14 |
Totale |
|
2008 |
1279 |
888 |
1288 |
475 |
2342 |
5382 |
1324 |
1618 |
1926 |
2373 |
2106 |
2066 |
1762 |
755 |
25584 |
|
2009 |
1278 |
880 |
1293 |
466 |
2314 |
5257 |
1334 |
1585 |
1925 |
2364 |
2086 |
2098 |
1784 |
771 |
25435 |
|
2010 |
1257 |
864 |
1299 |
463 |
2281 |
5086 |
1320 |
1550 |
1942 |
2265 |
2037 |
2044 |
1762 |
766 |
24936 |
|
2011 |
1250 |
882 |
1310 |
458 |
2303 |
4940 |
1332 |
1511 |
1958 |
2207 |
1961 |
1994 |
1717 |
766 |
24589 |
|
2012 |
1252 |
869 |
1310 |
456 |
2280 |
4774 |
1330 |
1499 |
1931 |
2182 |
1932 |
1962 |
1724 |
761 |
24262 |
|
2013 |
1232 |
854 |
1302 |
455 |
2256 |
4596 |
1297 |
1475 |
1909 |
2122 |
1881 |
1915 |
1694 |
752 |
23740 |
|
2014 |
1100 |
715 |
1135 |
403 |
2075 |
4231 |
1182 |
1288 |
1565 |
1829 |
1645 |
1706 |
1498 |
658 |
21030 |
|
2015 |
891 |
543 |
935 |
338 |
1786 |
3646 |
1009 |
1027 |
1252 |
1433 |
1312 |
1482 |
1208 |
570 |
17432 |
|
2016 |
818 |
473 |
860 |
317 |
1666 |
3388 |
933 |
926 |
1128 |
1277 |
1196 |
1374 |
1101 |
525 |
15982 |
|
2017 |
755 |
407 |
789 |
279 |
1557 |
3119 |
858 |
850 |
1022 |
1145 |
1078 |
1269 |
999 |
483 |
14610 |
|
2018 |
645 |
345 |
683 |
243 |
1398 |
2687 |
765 |
713 |
828 |
959 |
895 |
1149 |
861 |
430 |
12601 |
|
2019 |
548 |
285 |
589 |
201 |
1212 |
2342 |
670 |
572 |
687 |
783 |
704 |
998 |
758 |
352 |
10701 |
|
2020 |
460 |
238 |
487 |
167 |
1045 |
2001 |
565 |
465 |
563 |
616 |
570 |
875 |
659 |
286 |
8997 |
|
Variaz. % |
-64,03 |
-73,20 |
-62,19 |
-64,84 |
-55,38 |
-62,82 |
-57,33 |
-71,26 |
-70,77 |
-74,04 |
-72,93 |
-57,65 |
-62,60 |
-62,12 |
-64,83 |
Osserviamo che anche in questo caso – rispetto alla decrescita complessiva del 64,83% – ci sono significativi scostamenti, come è evidente nel grafico seguente che fa riferimento al 2010 (anno della legge 240), a un anno intermedio (2015) e alla situazione attuale.
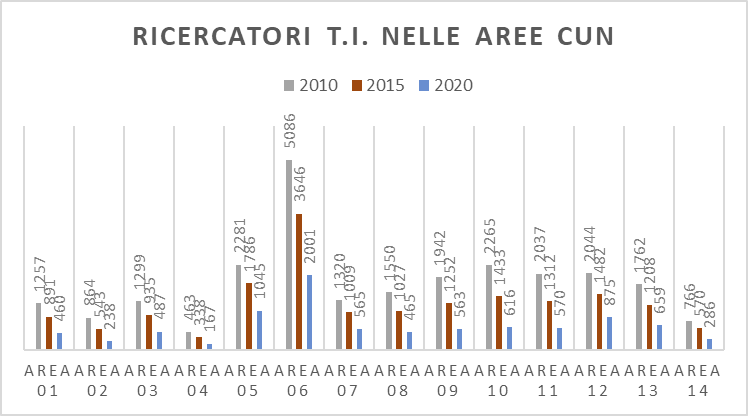
Figura 105 . Numerosità dei ricercatori a tempo indeterminato nelle aree CUN. Anni 2010, 2015,2020. Valori assoluti. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
Nella tabella e nel grafico seguenti la differenza fra le dinamiche di decrescita viene evidenziata attraverso l’uso delle percentuali sui totali della fascia dal 2008 al 2020.
Tabella 190 . Ricercatori a tempo indeterminato nelle aree CUN. Anni 2008-2020. Valori percentuali sui totali della fascia. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
|
Anno |
Area 01 |
Area 02 |
Area 03 |
Area 04 |
Area 05 |
Area 06 |
Area 07 |
Area 08 |
Area 09 |
Area 10 |
Area 11 |
Area 12 |
Area 13 |
Area 14 |
|
2008 |
5,00% |
3,47% |
5,03% |
1,86% |
9,15% |
21,04% |
5,18% |
6,32% |
7,53% |
9,28% |
8,23% |
8,08% |
6,89% |
2,95% |
|
2009 |
5,02% |
3,46% |
5,08% |
1,83% |
9,10% |
20,67% |
5,24% |
6,23% |
7,57% |
9,29% |
8,20% |
8,25% |
7,01% |
3,03% |
|
2010 |
5,04% |
3,46% |
5,21% |
1,86% |
9,15% |
20,40% |
5,29% |
6,22% |
7,79% |
9,08% |
8,17% |
8,20% |
7,07% |
3,07% |
|
2011 |
5,08% |
3,59% |
5,33% |
1,86% |
9,37% |
20,09% |
5,42% |
6,15% |
7,96% |
8,98% |
7,98% |
8,11% |
6,98% |
3,12% |
|
2012 |
5,16% |
3,58% |
5,40% |
1,88% |
9,40% |
19,68% |
5,48% |
6,18% |
7,96% |
8,99% |
7,96% |
8,09% |
7,11% |
3,14% |
|
2013 |
5,19% |
3,60% |
5,48% |
1,92% |
9,50% |
19,36% |
5,46% |
6,21% |
8,04% |
8,94% |
7,92% |
8,07% |
7,14% |
3,17% |
|
2014 |
5,23% |
3,40% |
5,40% |
1,92% |
9,87% |
20,12% |
5,62% |
6,12% |
7,44% |
8,70% |
7,82% |
8,11% |
7,12% |
3,13% |
|
2015 |
5,11% |
3,11% |
5,36% |
1,94% |
10,25% |
20,92% |
5,79% |
5,89% |
7,18% |
8,22% |
7,53% |
8,50% |
6,93% |
3,27% |
|
2016 |
5,12% |
2,96% |
5,38% |
1,98% |
10,42% |
21,20% |
5,84% |
5,79% |
7,06% |
7,99% |
7,48% |
8,60% |
6,89% |
3,28% |
|
2017 |
5,17% |
2,79% |
5,40% |
1,91% |
10,66% |
21,35% |
5,87% |
5,82% |
7,00% |
7,84% |
7,38% |
8,69% |
6,84% |
3,31% |
|
2018 |
5,12% |
2,74% |
5,42% |
1,93% |
11,09% |
21,32% |
6,07% |
5,66% |
6,57% |
7,61% |
7,10% |
9,12% |
6,83% |
3,41% |
|
2019 |
5,12% |
2,66% |
5,50% |
1,88% |
11,33% |
21,89% |
6,26% |
5,35% |
6,42% |
7,32% |
6,58% |
9,33% |
7,08% |
3,29% |
|
2020 |
5,11% |
2,65% |
5,41% |
1,86% |
11,61% |
22,24% |
6,28% |
5,17% |
6,26% |
6,85% |
6,34% |
9,73% |
7,32% |
3,18% |
|
Variaz. punti perc. |
+0,11 |
-0,82 |
+0,38 |
0,00 |
+2,46 |
+1,20 |
+1,10 |
-1,15 |
-1,27 |
-2,43 |
-1,89 |
+1,65 |
+0,43 |
+0,23 |
Vediamo che in molte aree l’incidenza percentuale dei ricercatori a tempo indeterminato sul totale della fascia sale, il che segnala che fra le 14 aree CUN alcune sono più veloci di altre nell’“esaurimento” di queste figure. Le aree in questione sono in particolare l’Area 10 – Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche e l’Area 11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, ma anche l’Area 08 – Ingegneria civile e Architettura, l’Area 09 – Ingegneria industriale e dell’informazione e, in misura minore, l’Area 02 – Scienze fisiche.
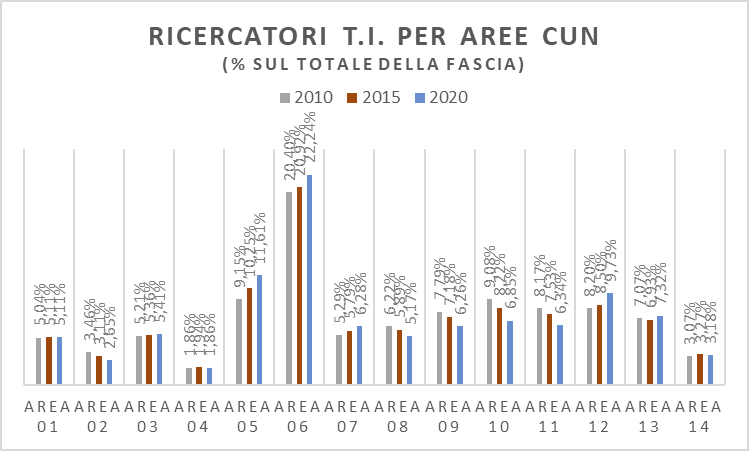
Figura 106 . Ricercatori a tempo indeterminato nelle aree CUN. Anni 2010, 2015, 2020. Valori percentuali sui totali della fascia. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
Concludiamo con un grafico in cui si visualizza l’incidenza dei ricercatori a tempo indeterminato delle 14 aree CUN sul totale dei docenti/ricercatori nelle aree CUN negli anni 2010, 2015 e 2020.
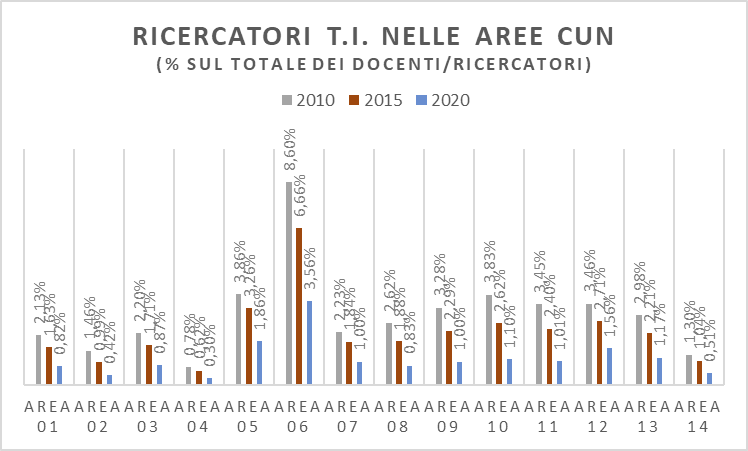
Figura 107 . Ricercatori a tempo indeterminato nelle aree CUN. Anni 2010, 2015, 2020. Valori percentuali sui totali generali. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
Nel campo dei docenti/ricercatori a tempo determinato (escludendo gli RTD 2005, ormai residuali) abbiamo posizioni molto diverse. Gli RTD-B sono assunti con una sorta di tenure track : scaduto il contratto triennale, a patto di aver superato l’ASN, diventano quasi automaticamente professori associati. Molto diversa è la situazione degli RTD-A, che non hanno certezze allo scadere del triennio. C’è poi una terza figura a tempo determinato, gli Straordinari a tempo determinato, introdotti dalla legge 230/2005 , sulla cui esistenza spesso si sorvola, vista la scarsa numerosità, ma che abbiamo visto ricoprire un certo ruolo nel sistema universitario privato, soprattutto nelle università telematiche.
Nei paragrafi seguenti ci occuperemo allora di coloro per i quali l’assunzione a tempo determinato è una tappa nel percorso di stabilizzazione – vale a dire i ricercatori a tempo determinato legge 240/2010 di tipo B – e di coloro che partecipano alla docenza in maniera temporanea ma nella fascia più alta.
I ricercatori a tempo determinato legge 240/2010 di tipo A verranno invece compresi nell’area del “precariato”, anche se il loro è un precariato un po’ più stabile di quello di altre figure di precari con contratti annuali o semestrali.
Come abbiamo più volte accennato, l’art. 24 della legge 240/2010 ha istituito due tipologie di contratto a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. Entrambe le figure sono scelte mediante procedure pubbliche disciplinate dai regolamenti delle università, e destinate ai dottori di ricerca (o ai possessori di specializzazione medica) e che prevedono la valutazione preliminare di titoli, curriculum e produzione scientifica, compresa la tesi di dottorato e una discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica.
La legge 240/2010 indica un minimo di ore di impegno didattico per gli RTD ma non si esprime riguardo alla loro articolazione interna (quante ore di lezione frontale e quante invece, ad esempio, di assistenza agli studenti). Anche questo aspetto è quindi regolato dai regolamenti di ateneo.
Quelli da ricercatore a tempo determinato di tipo B, sono contratti triennali riservati a candidati che hanno usufruito di contratti di RTD-A, o che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, o che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, o che hanno usufruito di assegni di ricerca o di borse post-dottorato, oppure di RTD 2005, o ancora di contratti, assegni o borse analoghi in università straniere per almeno 3 anni, anche non consecutivi.
Nel terzo anno di contratto, il titolare di contratto RTD-B che abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale è sottoposto alla valutazione della propria università, in conformità a standard qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo. Se la valutazione ha esito positivo, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, [70] è inquadrato come professore associato.
In questo paragrafo riassumeremo, raccogliendole e sistematizzandole, le caratteristiche degli RTD-B già emerse nel corso della trattazione.
Cominciamo, come di consueto, con i valori assoluti, declinati per genere.
Nel grafico e nella tabella qui di seguito riproponiamo in valori assoluti la numerosità delle donne e degli uomini nel periodo 2010-2020 già evidenziata nella Figura 10 .
Tabella 191 . Numerosità degli RTD-B per genere. Anni 2010-2020. Valori assoluti. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
|
Anno |
RTD-B Donne |
RTD-B Uomini |
Totale |
|
2010 |
2 |
2 |
|
|
2011 |
2 |
5 |
7 |
|
2012 |
6 |
14 |
20 |
|
2013 |
49 |
65 |
114 |
|
2014 |
116 |
182 |
298 |
|
2015 |
268 |
432 |
700 |
|
2016 |
758 |
1134 |
1892 |
|
2017 |
998 |
1437 |
2435 |
|
2018 |
1519 |
2146 |
3665 |
|
2019 |
1777 |
2503 |
4280 |
|
2020 |
1928 |
2720 |
4648 |
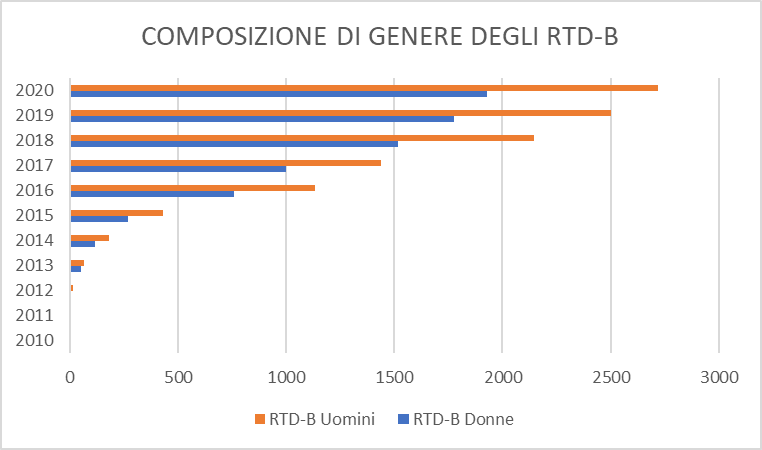
Figura 108 . Numerosità degli RTD-B per genere. Anni 2010-2020. Valori assoluti. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
Procediamo ora con le percentuali della composizione di genere della fascia di cui alla Figura 10 .
Tabella 192 . RTD-B per genere. Anni 2010-2020. Percentuali sui totali della fascia. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
|
Anno |
RTD-B Donne |
RTD-B Uomini |
|
2010 |
0% |
100,00% |
|
2011 |
28,57% |
71,43% |
|
2012 |
30,00% |
70,00% |
|
2013 |
42,98% |
57,02% |
|
2014 |
38,93% |
61,07% |
|
2015 |
38,29% |
61,71% |
|
2016 |
40,06% |
59,94% |
|
2017 |
40,99% |
59,01% |
|
2018 |
41,45% |
58,55% |
|
2019 |
41,52% |
58,48% |
|
2020 |
41,48% |
58,52% |
|
Media |
34,93% |
65,07% |
Osserviamo che la percentuale media di donne (34,93%) e uomini (65,07%) negli RTD-B è più sfavorevole alle donne di quella degli associati nello stesso arco di tempo. A questo risultato contribuisce in maniera significativa il fatto che nel 2010 i primi 2 RTD-B assunti in Lombardia erano uomini, fenomeno che si ripete con significativa frequenza negli anni successivi, ovunque si inauguri il reclutamento delle nuove figure. Ad esempio, come si vedrà meglio in seguito, 7 aree CUN su 14 – in anni che vanno dal 2010 al 2013 – inaugurano il reclutamento di RTD-B con un 100% di uomini. [71] E, in ogni caso, non si dà mai il caso contrario. Unica eccezione parziale è l’Area 14 – Scienze politiche e sociali, dove il reclutamento di RTD-B si inaugura nel 2013 con il 66,67% di donne (che nel 2020 sono però diventate il 45,14% della fascia).
Per fare un raffronto con le altre fasce o, meglio, con la fascia in cui gli RTD-B sono virtualmente assunti – gli associati – dal 2010 al 2020 la media di donne nel ruolo di associato è del 36,68% sul totale della fascia, contro un 63,32% di uomini. La media di donne RTD-B è poi molto più bassa di quella delle ricercatrici a tempo indeterminato nella loro fascia: dal 2008 al 2010 la media delle ricercatrici a tempo indeterminato sul totale era del 45,21% contro il 54,79% dei ricercatori; dalla messa in esaurimento, e dunque dal 2011 al 2020, la media è stata del 47,47% di donne e del 52,53% di uomini, il che confermerebbe che, come si è detto più volte, la fascia si svuota più velocemente di uomini che di donne.
Diamo ora uno sguardo al reclutamento degli RTD-B.
Tabella 193 . Numerosità e crescita degli RTD-B. Anni 2010-2020. Valori assoluti, differenza e percentuali rispetto all’anno precedente. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
|
Anno |
Tot. RTD-B |
Crescita in percentuale |
Crescita in valori Assoluti |
|
2010 |
2 |
||
|
2011 |
7 |
250,00% |
5 |
|
2012 |
20 |
185,71% |
13 |
|
2013 |
114 |
470,00% |
94 |
|
2014 |
298 |
161,40% |
184 |
|
2015 |
700 |
134,90% |
402 |
|
2016 |
1892 |
170,29% |
1192 |
|
2017 |
2435 |
28,70% |
543 |
|
2018 |
3665 |
50,51% |
1230 |
|
2019 |
4280 |
16,78% |
615 |
|
2020 |
4648 |
8,60% |
368 |
|
Media 2010-2020 |
147,69% |
464,6 |
|
|
Media 2016-2020 |
54,98% |
789,6 |
I dati a nostra disposizione riguardano la numerosità degli RTD-B ad una certa data. Questo ci presenta il quadro di una crescita storicamente non costante, con una forte contrazione negli ultimi anni. Secondo questi dati, dal 2016 al 2020, in termini di valori assoluti la crescita media degli RTD-B risulterebbe di circa 790 nuovi futuri stabilizzati all’anno.
Recentemente sono stati presentati in un’occasione pubblica dati relativi alla numerosità di RTD-B reclutati dal 2016 al 2019. [72] Mentre i dati a nostra disposizione registrano una situazione statica, che rappresenta il risultato di ingressi ed esiti dalla fascia, questi dati si riferiscono, appunto, esclusivamente al reclutamento. I dati sono stati forniti in forma aggregata per i 4 anni e distinti per Area CUN. [73]
Tabella 194 . Reclutamento degli RTD-B per area CUN. Anni 2016-2019. Valori assoluti. Fonte: ns. elaborazione dati ANVUR. [74]
|
Area CUN |
RTD-B – reclutamento 2016-2019 |
Media annuale |
|
Area 01 |
341 |
85,25 |
|
Area 02 |
281 |
70,25 |
|
Area 03 |
291 |
72,75 |
|
Area 04 |
97 |
24,25 |
|
Area 05 |
529 |
132,25 |
|
Area 06 |
745 |
186,25 |
|
Area 07 |
264 |
66,00 |
|
Area 08 |
346 |
86,50 |
|
Area 09 |
607 |
151,75 |
|
Area 10 |
538 |
134,5 |
|
Area 11 |
489 |
122,25 |
|
Area 12 |
325 |
81,25 |
|
Area 13 |
484 |
121,00 |
|
Area 14 |
203 |
50,75 |
|
Totale |
5540 |
1385,00 |
Ricordiamo ora la numerosità degli RTD-B nelle tre macro-aree del nostro Paese. Cominciamo col riassumere qui le serie storiche dei valori assoluti.
Tabella 195 . Numerosità e crescita media degli RTD-B per area geografica. Anni 2010-2020. Valori assoluti. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca .
|
Anno |
RTD-B Nord |
RTD-B Centro |
RTD-B Sud e Isole |
Totale RTD-B |
|
2 |
2 |
|||
|
2011 |
6 |
1 |
7 |
|
|
2012 |
10 |
6 |
4 |
20 |
|
2013 |
67 |
29 |
18 |
114 |
|
2014 |
150 |
89 |
59 |
298 |
|
2015 |
345 |
162 |
193 |
700 |
|
2016 |
903 |
508 |
481 |
1892 |
|
2017 |
1227 |
611 |
597 |
2435 |
|
2018 |
1856 |
885 |
924 |
3665 |
|
2019 |
2201 |
958 |
1121 |
4280 |
|
2020 |
2287 |
1051 |
1310 |
4648 |
|
Crescita media 2016-2020 |
388,4 |
177,8 |
223,4 |
789,6 |
Osserviamo ora la distribuzione degli RTD-B nelle tra macro-aree del Paese in percentuale sul totale della fascia.
Tabella 196 . RTD-B per area geografica. Anni 2010-2020. Valori percentuali sul totale della fascia. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
|
Anno |
RTD-B Nord |
RTD-B Centro |
RTD-B Sud e Isole |
|
2010 |
100,00% |
||
|
2011 |
85,71% |
14,29% |
|
|
2012 |
50,00% |
30,00% |
20,00% |
|
2013 |
58,77% |
25,44% |
15,79% |
|
2014 |
50,34% |
29,87% |
19,80% |
|
2015 |
49,29% |
23,14% |
27,57% |
|
2016 |
47,73% |
26,85% |
25,42% |
|
2017 |
50,39% |
25,09% |
24,52% |
|
2018 |
50,64% |
24,15% |
25,21% |
|
2019 |
51,43% |
22,38% |
26,19% |
|
2020 |
49,20% |
22,61% |
28,18% |
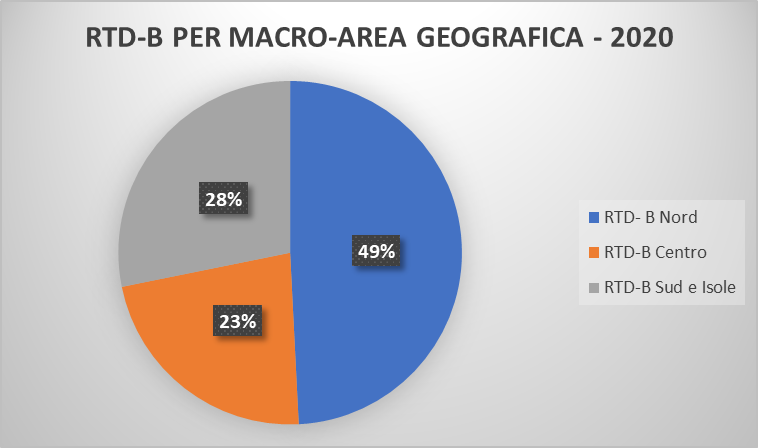
Figura 109 . RTD-B per area geografica. Anno 2020. Valori percentuali sul totale della fascia. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
Dalla tabella precedente si evince che la distribuzione di RTD-B nelle tra macro-aree del Paese dal 2012 è in media del 50,87% al Nord, 25,50% al Centro e 23,63% al Sud e nelle Isole.
Raffrontando la distribuzione degli RTD-B alla distribuzione dei docenti/ricercatori a tempo indeterminato e determinato – che nel decennio preso in esame è mediamente 43,62% al Nord, 25,36% al Centro e 31,01% al Sud e nelle Isole – gli RTD-B presentano una concentrazione maggiorata al Nord di oltre 7 punti e diminuita di oltre 7 punti al Sud e nelle Isole.
Osserviamo anche la composizione di genere in percentuale rispetto ai totali delle aree.
Tabella 197 . RTD-B per genere e per area geografica. Anni 2010-2020. Valori percentuali sul totale dell’area. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
|
NORD |
CENTRO |
SUD e ISOLE |
||||
|
Anno |
RTD-B Donne |
RTD-B Uomini |
RTD-B Donne |
RTD-B Uomini |
RTD-B Donne |
RTD-B Uomini |
|
2010 |
0,00% |
100,00% |
||||
|
2011 |
33,33% |
66,67% |
0,00% |
100,00% |
||
|
2012 |
30,00% |
70,00% |
33,33% |
66,67% |
25,00% |
75,00% |
|
2013 |
40,30% |
59,70% |
37,93% |
62,07% |
61,11% |
38,89% |
|
2014 |
36,00% |
64,00% |
32,58% |
67,42% |
55,93% |
44,07% |
|
2015 |
38,55% |
61,45% |
33,33% |
66,67% |
41,97% |
58,03% |
|
2016 |
39,76% |
60,24% |
39,76% |
60,24% |
40,96% |
59,04% |
|
2017 |
41,16% |
58,84% |
41,57% |
58,43% |
40,03% |
59,97% |
|
2018 |
40,36% |
59,64% |
43,73% |
56,27% |
41,45% |
58,55% |
|
2019 |
40,44% |
59,56% |
43,53% |
56,47% |
41,93% |
58,07% |
|
2020 |
40,71% |
59,29% |
42,44% |
57,56% |
42,06% |
57,94% |
|
Media |
34,60% |
65,40% |
38,69% |
61,31% |
39,04% |
60,96% |
Notiamo che la composizione di genere è maggiormente squilibrata in favore degli uomini nell’area Nord del Paese, mentre nel Centro, nel Sud e nelle Isole abbiamo una proporzione di donne e uomini abbastanza simile.
Nella tabella seguente riportiamo la numerosità degli RTD-B nelle regioni italiane, in valori assoluti dal 2010 al 2020, evidenziandone la crescita annua media nel periodo 2016-2020.
Tabella 198 . Numerosità e crescita annua media degli RTD-B nelle regioni italiane. Anni 2010-2020. Valori assoluti. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
|
Anno |
Abruzzo |
Basilicata |
Calabria |
Campania |
Emilia Romagna |
Friuli |
Lazio |
Liguria |
Lombardia |
Marche |
Molise |
Piemonte |
Puglia |
Sardegna |
Sicilia |
Toscana |
Trentino Alto Adige |
Umbria |
Valle d’Aosta |
Veneto |
Totale |
|
2010 |
2 |
2 |
|||||||||||||||||||
|
2011 |
6 |
1 |
7 |
||||||||||||||||||
|
2012 |
2 |
1 |
1 |
6 |
5 |
2 |
1 |
1 |
1 |
20 |
|||||||||||
|
2013 |
6 |
9 |
39 |
9 |
3 |
17 |
12 |
3 |
1 |
2 |
8 |
3 |
2 |
114 |
|||||||
|
2014 |
1 |
7 |
18 |
50 |
9 |
27 |
6 |
29 |
31 |
27 |
1 |
8 |
24 |
25 |
12 |
6 |
17 |
298 |
|||
|
2015 |
19 |
11 |
78 |
98 |
17 |
68 |
13 |
84 |
35 |
49 |
16 |
35 |
34 |
51 |
36 |
8 |
48 |
700 |
|||
|
2016 |
53 |
9 |
30 |
162 |
221 |
52 |
239 |
50 |
269 |
67 |
11 |
130 |
59 |
59 |
98 |
171 |
64 |
31 |
117 |
1892 |
|
|
2017 |
65 |
9 |
36 |
221 |
247 |
44 |
306 |
90 |
409 |
67 |
11 |
179 |
65 |
70 |
120 |
212 |
69 |
26 |
189 |
2435 |
|
|
2018 |
85 |
15 |
47 |
315 |
395 |
74 |
368 |
114 |
599 |
97 |
20 |
309 |
123 |
78 |
241 |
357 |
94 |
63 |
271 |
3665 |
|
|
2019 |
98 |
15 |
55 |
458 |
460 |
103 |
415 |
129 |
694 |
109 |
15 |
356 |
146 |
98 |
236 |
361 |
105 |
73 |
354 |
4280 |
|
|
2020 |
144 |
18 |
95 |
500 |
463 |
110 |
470 |
113 |
758 |
132 |
18 |
347 |
178 |
115 |
242 |
373 |
124 |
76 |
1 |
371 |
4648 |
|
Crescita media 2016-20 |
25 |
3,6 |
16,8 |
84,4 |
73 |
18,6 |
80,4 |
20 |
134,8 |
19,4 |
15,2 |
59,6 |
32,4 |
16 |
41,6 |
64,4 |
17,6 |
13,6 |
0,2 |
64,6 |
789,6 |
Nel grafico seguente riaggreghiamo i dati della numerosità degli RTD-B nel 2020 nelle aree del Nord Est, Nord Ovest, Centro, Sud continentale e Isole.
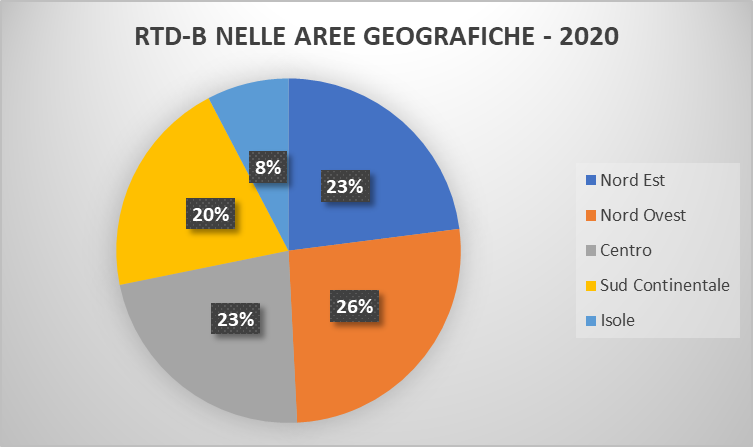
Figura 110 . RTD-B nelle aree geografiche. Anno 2020. Valori percentuali. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
Nel grafico seguente presentiamo la grafica relativa alla Tabella 76 (par. 2.8. Considerazioni sulle differenze regionali e di area geografica ) sulla numerosità degli RTD-B nelle regioni italiane nell’anno 2020, in valori percentuali sul totale della fascia e in ordine decrescente.
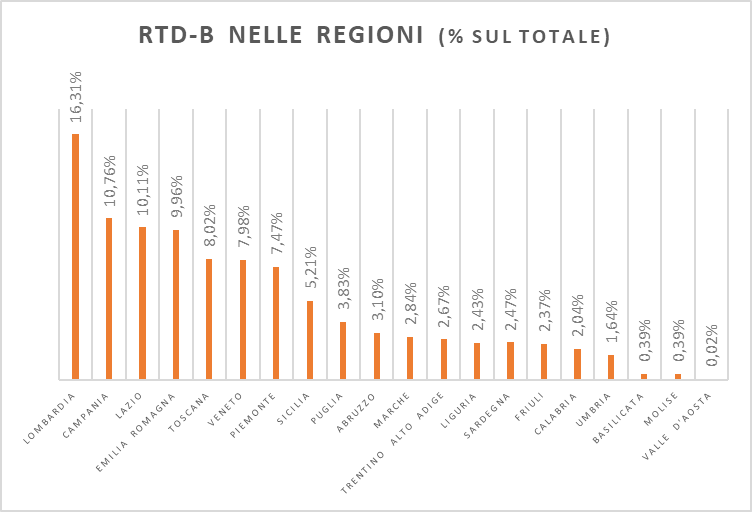
Figura 111 . RTD-B nelle regioni italiane. Anno 2020. Valori percentuali sul totale della fascia. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
Siccome gli RTD-B possono essere a tutti gli effetti considerati come dei professori associati virtuali, abbiamo provato a calcolare l’incidenza degli RTD-B sulle fasce di docenza a tempo indeterminato, ricavando per ogni singola regione la percentuale di RTD-B sull’insieme di PO, PA, RU e RTD-B.
Tabella 199 . Incidenza degli RTD-B sulle posizioni a tempo indeterminato nelle regioni italiane. Anno 2020. Valori percentuali sul totale dei docenti/ricercatori a tempo indeterminato e degli RTD-B. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca
|
Regione |
RTD-B |
Docenti T.I. + RTD-B |
Incidenza RTD-B |
|
Trentino Alto Adige |
124 |
830 |
14,94% |
|
Piemonte |
347 |
3151 |
11,01% |
|
Veneto |
371 |
3445 |
10,77% |
|
Campania |
500 |
4886 |
10,23% |
|
Abruzzo |
144 |
1440 |
10,00% |
|
Liguria |
113 |
1131 |
9,99% |
|
Toscana |
373 |
3819 |
9,77% |
|
Marche |
132 |
1361 |
9,70% |
|
Emilia Romagna |
463 |
4779 |
9,69% |
|
Lombardia |
758 |
8165 |
9,28% |
|
Sardegna |
115 |
1391 |
8,27% |
|
Friuli |
110 |
1339 |
8,22% |
|
Umbria |
76 |
970 |
7,84% |
|
Calabria |
95 |
1260 |
7,54% |
|
Lazio |
470 |
6348 |
7,40% |
|
Puglia |
178 |
2495 |
7,13% |
|
Sicilia |
242 |
3506 |
6,90% |
|
Molise |
18 |
263 |
6,84% |
|
Basilicata |
18 |
295 |
6,10% |
|
Valle d’Aosta |
1 |
48 |
2,08% |
|
Totale nazionale |
4648 |
50922 |
9,13% |
Vediamo che la “classifica” cambia significativamente rispetto a quella che riguarda la distribuzione degli RTD-B tra le regioni.
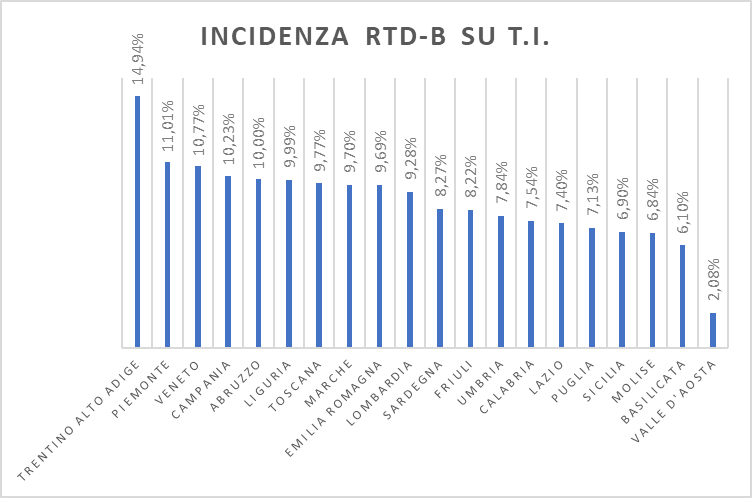
Figura 112 . Incidenza degli RTD-B sulle posizioni a tempo indeterminato nelle regioni italiane. Anno 2020. Valori percentuali sul totale dei docenti/ricercatori a tempo indeterminato e degli RTD-B. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
Anticipiamo ora la numerosità degli RTD-B nelle 14 aree CUN in valori assoluti, evidenziandone la crescita annua media nel periodo 2016-2020.
Tabella 200 . Numerosità degli RTD-B nelle aree CUN. Anni 2010-2020. Valori assoluti. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
|
Anno |
Area 01 |
Area 02 |
Area 03 |
Area 04 |
Area 05 |
Area 06 |
Area 07 |
Area 08 |
Area 09 |
Area 10 |
Area 11 |
Area 12 |
Area 13 |
Area 14 |
|
2010 |
2 |
|||||||||||||
|
2011 |
2 |
1 |
4 |
|||||||||||
|
2012 |
1 |
3 |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
5 |
|||||
|
2013 |
5 |
6 |
6 |
3 |
12 |
10 |
7 |
8 |
9 |
6 |
14 |
8 |
17 |
3 |
|
2014 |
13 |
29 |
23 |
8 |
38 |
20 |
15 |
21 |
32 |
25 |
25 |
14 |
24 |
11 |
|
2015 |
33 |
48 |
44 |
17 |
68 |
61 |
26 |
52 |
90 |
67 |
69 |
32 |
67 |
26 |
|
2016 |
103 |
114 |
107 |
36 |
192 |
204 |
81 |
126 |
207 |
200 |
183 |
88 |
186 |
65 |
|
2017 |
141 |
137 |
128 |
42 |
230 |
278 |
117 |
157 |
263 |
258 |
237 |
139 |
227 |
81 |
|
2018 |
201 |
176 |
199 |
63 |
362 |
463 |
193 |
222 |
402 |
375 |
341 |
214 |
325 |
129 |
|
2019 |
269 |
211 |
227 |
77 |
395 |
575 |
204 |
272 |
481 |
402 |
390 |
257 |
357 |
163 |
|
2020 |
285 |
226 |
247 |
79 |
424 |
648 |
219 |
284 |
517 |
421 |
449 |
268 |
406 |
175 |
|
Crescita media 2016-2020 |
50,4 |
35,6 |
40,6 |
12,4 |
71,2 |
117,4 |
38,6 |
46,4 |
85,4 |
70,8 |
76 |
47,2 |
67,8 |
29,8 |
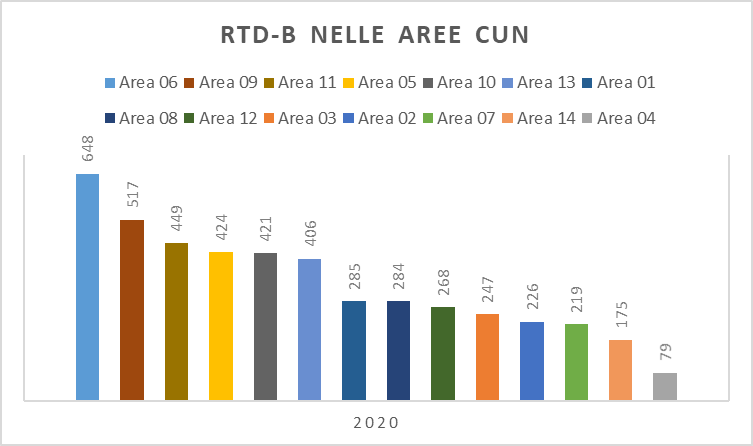
Figura 113 . Numerosità degli RTD-B nelle aree CUN in ordine decrescente. Anno 2020. Valori assoluti. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
Confrontiamo ora la percentuale di RTD-B nelle 14 aree CUN con la numerosità del totale dei docenti/ricercatori delle rispettive aree.
Tabella 201 . Incidenza degli RTD-B sul totale dei docenti/ricercatori di ciascuna area CUN. Anni 2010-2020. Valori percentuali sul totale delle singole aree. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
|
Anno |
Area 01 |
Area 02 |
Area 03 |
Area 04 |
Area 05 |
Area 06 |
Area 07 |
Area 08 |
Area 09 |
Area 10 |
Area 11 |
Area 12 |
Area 13 |
Area 14 |
|
2010 |
0,04% |
|||||||||||||
|
2011 |
0,04% |
0,02% |
0,08% |
|||||||||||
|
2012 |
0,04% |
0,10% |
0,04% |
0,01% |
0,06% |
0,04% |
0,04% |
0,04% |
0,10% |
|||||
|
2013 |
0,16% |
0,27% |
0,21% |
0,29% |
0,25% |
0,10% |
0,23% |
0,23% |
0,17% |
0,12% |
0,30% |
0,17% |
0,36% |
0,17% |
|
2014 |
0,42% |
1,32% |
0,81% |
0,78% |
0,80% |
0,21% |
0,50% |
0,60% |
0,62% |
0,51% |
0,54% |
0,30% |
0,51% |
0,65% |
|
2015 |
1,10% |
2,24% |
1,57% |
1,69% |
1,47% |
0,67% |
0,89% |
1,52% |
1,71% |
1,39% |
1,53% |
0,68% |
1,40% |
1,55% |
|
2016 |
3,40% |
5,28% |
3,83% |
3,59% |
4,15% |
2,26% |
2,74% |
3,69% |
3,90% |
4,24% |
4,11% |
1,90% |
3,90% |
3,90% |
|
2017 |
4,67% |
6,29% |
4,61% |
4,17% |
5,04% |
3,14% |
3,95% |
4,65% |
4,90% |
5,55% |
5,39% |
3,04% |
4,75% |
4,90% |
|
2018 |
6,63% |
7,93% |
7,12% |
6,14% |
7,76% |
5,28% |
6,44% |
6,48% |
7,26% |
8,12% |
7,65% |
4,65% |
6,70% |
7,73% |
|
2019 |
8,71% |
9,14% |
7,92% |
7,36% |
8,26% |
6,50% |
6,65% |
7,69% |
8,42% |
8,58% |
8,60% |
5,49% |
7,19% |
9,39% |
|
2020 |
9,10% |
9,60% |
8,56% |
7,60% |
8,85% |
7,32% |
7,16% |
8,00% |
8,91% |
8,91% |
9,91% |
5,70% |
8,00% |
10,06% |
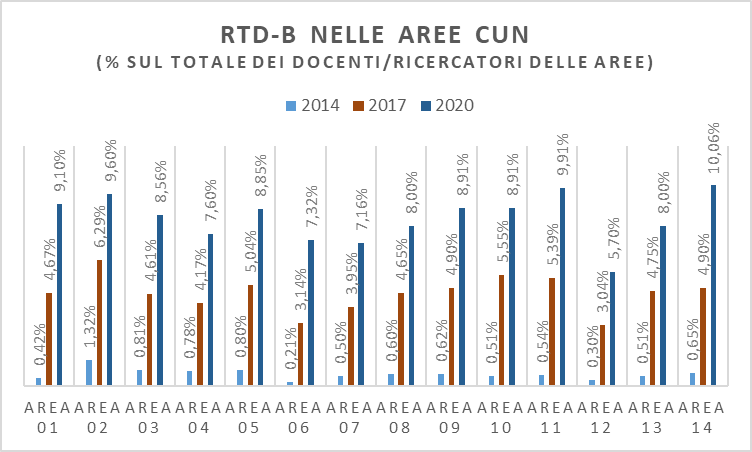
Figura 114 . RTD-B sul totale dei docenti/ricercatori dell’area CUN. Anni 2014, 2017, 2020. Valori percentuali sul totale dell’area. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
La figura di professore straordinario a tempo determinato è stata introdotta dalla legge 230/2005 (art. 1 c. 12) che prevede la possibilità di conferire incarichi della durata massima di tre anni, più ulteriori 3 anni, finanziati da soggetti esterni per attività di ricerca in specifici programmi di ricerca e sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni o con altri soggetti pubblici o privati. Il conferimento degli incarichi è riservato a quanti abbiano conseguito l’idoneità per la fascia dei professori ordinari, o anche a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale. Ai titolari degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari con eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione.
Alcuni atenei hanno previsto nei propri regolamenti procedure comparative per la selezione dei professori straordinari. Tuttavia, come ha fatto rilevare il CUN, gli atenei attribuiscono gli incarichi prevalentemente a professori ordinari in quiescenza oppure a professionisti ritenuti in possesso del requisito della “elevata qualificazione scientifica e professionale” e, nella larghissima maggioranza dei casi, tali incarichi sono assegnati tramite conferimento diretto e la valutazione del requisito del “possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale” è spesso effettuata secondo modalità e criteri non esplicitati. [75]
Riassumiamo qui brevemente alcuni dati già forniti nel corso della trattazione, cominciando dalla distribuzione di genere, già esposta nella Figura 11 in termini percentuali, che qui riproponiamo in valori assoluti nella tabella e nel grafico seguenti.
Tabella 202 . Numerosità dei professori straordinari a tempo determinato per genere. Anni 2008-2020. Valori assoluti. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
|
Anno |
Straordinari t.d. Donne |
Straordinari t.d. Uomini |
Totale |
|
2008 |
4 |
10 |
14 |
|
2009 |
5 |
16 |
21 |
|
2010 |
8 |
33 |
41 |
|
2011 |
11 |
37 |
48 |
|
2012 |
12 |
52 |
64 |
|
2013 |
27 |
90 |
117 |
|
2014 |
35 |
161 |
196 |
|
2015 |
48 |
249 |
297 |
|
2016 |
52 |
249 |
301 |
|
2017 |
54 |
295 |
349 |
|
2018 |
66 |
319 |
385 |
|
2019 |
80 |
348 |
428 |
|
2020 |
83 |
319 |
402 |
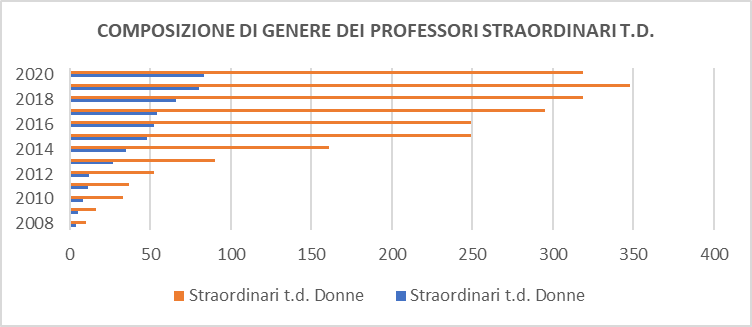
Figura 115 . Numerosità dei professori straordinari a tempo determinato per genere. Anni 2008-2020. Valori assoluti. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
Presentiamo ora la distribuzione dei professori straordinari a tempo determinato nelle università statali, nelle università non statali e in quelle telematiche in valori percentuali sui totali della fascia dal 2008 al 2020.
Tabella 203 . Straordinari a tempo determinato nelle università statali, non statali e telematiche. Anni 2008-2020. Valori percentuali sulla fascia. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
|
Anno |
Università statali |
Università non statali |
Università telematiche |
|
2008 |
50,00% |
21,43% |
28,57% |
|
2009 |
47,62% |
33,33% |
19,05% |
|
2010 |
39,02% |
36,59% |
24,39% |
|
2011 |
31,25% |
31,25% |
37,50% |
|
2012 |
32,81% |
26,56% |
40,63% |
|
2013 |
14,53% |
15,38% |
70,09% |
|
2014 |
8,67% |
17,35% |
73,98% |
|
2015 |
6,06% |
25,93% |
68,01% |
|
2016 |
7,31% |
23,59% |
69,10% |
|
2017 |
7,16% |
21,49% |
71,35% |
|
2018 |
6,49% |
24,42% |
69,09% |
|
2019 |
6,31% |
24,07% |
69,63% |
|
2020 |
7,96% |
18,66% |
73,38% |
Dal 2014 oltre il 90% degli Straordinari a tempo determinato è presso università non statali legalmente riconosciute. In particolare, mentre risultano quasi completamente assenti nelle Grandi università non statali, nel 2020 essi rappresentano il 4,88% del totale della docenza nelle Medie università non statali e il 4,62% nelle Piccole università non statali. Nelle università telematiche, a partire dal 2013 essi rappresentano una quota sempre più significativa del corpo docente (il 20,15% nel 2013; il 38,56% nel 2020).
Tabella 204 . Straordinari a tempo determinato nelle università statali, non statali e telematiche. Anni 2008-2020. Valori percentuali sul corpo docente. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
|
Anno |
Statali |
Non statali |
Telematiche |
|
2008 |
0,01% |
0,12% |
4,65% |
|
2009 |
0,02% |
0,26% |
2,63% |
|
2010 |
0,03% |
0,55% |
3,91% |
|
2011 |
0,03% |
0,53% |
5,98% |
|
2012 |
0,04% |
0,60% |
8,28% |
|
2013 |
0,03% |
0,64% |
20,15% |
|
2014 |
0,03% |
1,18% |
25,75% |
|
2015 |
0,04% |
2,56% |
29,58% |
|
2016 |
0,04% |
2,37% |
31,28% |
|
2017 |
0,05% |
2,48% |
35,83% |
|
2018 |
0,05% |
3,04% |
36,49% |
|
2019 |
0,05% |
3,24% |
39,06% |
|
2020 |
0,06% |
2,35% |
38,56% |
Se il contratto da RTD-B è ormai l’unica porta per la stabilizzazione accademica, veniamo ora a quanti possono aspirare a questa condizione.
Requisiti per partecipare ai concorsi RTD-B sono, come abbiamo detto: dottorato di ricerca, contratto triennale come RTD-A, oppure un triennio da RTD-2005, o di assegni di ricerca anche non consecutivi, oppure possesso dell’ASN o del diploma di specializzazione medica.
I primi due gruppi da prendere in considerazione sono allora gli RTD-A e gli Assegnisti di ricerca. I primi hanno un contratto di durata triennale prorogabile per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte. I secondi hanno un contratto la cui durata è compresa tra 1 e 3 anni, con un limite massimo cumulativo di 6 anni.
Nel 2020 il database del Miur – interrogato il 31 dicembre 2020 – riporta un totale di 14.476 assegnisti, mentre lo stesso database, interrogato alla stessa data, riporta un totale di 4.886 RTD-A.
Abbiamo ancora altre due figure di precari – il collaboratore in attività di ricerca e il docente a contratto – che intrattengono un rapporto più incerto con l’accademia e con le prospettive di carriera.
I dati più recenti di cui disponiamo per i collaboratori in attività di ricerca sono relativi al 2019 e riportano un totale di 58.905 contratti stipulati in quell’anno. I dati più recenti sui docenti a contratto si riferiscono all’anno accademico 2018/2019 e riportano un totale di 29.956 docenti.
I contratti RTD-A sono triennali e prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte.
Come gli RTD-B, gli RTD-A hanno obblighi didattici che vengono solitamente determinati nei regolamenti di ateneo.
Possiamo quindi considerare gli RTD-A come precari della ricerca e della didattica, anche se di un precariato meno instabile di quello degli assegnisti di ricerca o dei docenti a contratto.
Per accedere all’anticamera della stabilizzazione – vale a dire un contratto da RTD-B – gli RTD-A sono in concorrenza con gli assegnisti con almeno di tre anni di “anzianità” e con tutti gli abilitati non a tempo indeterminato e non RTD-B della loro area concorsuale.
Se, dunque, consideriamo che gli RTD-A nel 2020 sono 4.886, che gli assegnisti sono 14.476, e che tutti gli abilitati non a tempo indeterminato e non RTD-B assommano a oltre 16.000, [76] mentre dal 2016 al 2019 sono stati reclutati in media 1.385 RTD-B all’anno, vediamo come molti RTD-A siano a minaccia di espulsione dal sistema.
A causa dell’evidente sproporzione fra gli RTD-B e il loro tasso di crescita e il numero di quanti possono aspirare ad entrare nei loro ranghi, riteniamo inutile il confronto fra RTD-B e RTD-A. Ci limiteremo, pertanto, a riassumere e completare qui le osservazioni già fatte nel corso della trattazione. Cominciamo dalla composizione di genere, che riproponiamo in valori assoluti.
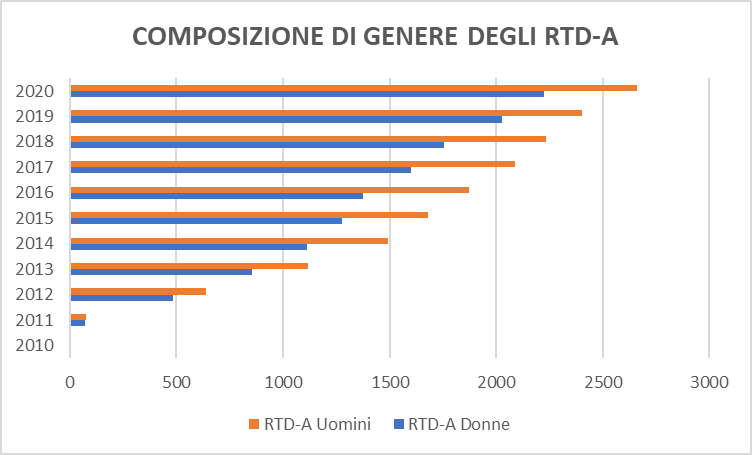
Figura 116 . Numerosità degli RTD-A per genere. Anni 2010-2020. Valori assoluti. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
Come già osservato più volte, in questa posizione precaria lo squilibrio di genere è inferiore a quello presente fra gli RTD-B.
Tabella 205 . Numerosità degli RTD-A per genere. Anni 2010-2020. Valori assoluti. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
|
Anno |
RTD-A Donne |
RTD-A Uomini |
Totale |
|
2010 |
0 |
3 |
3 |
|
2011 |
73 |
77 |
150 |
|
2012 |
484 |
637 |
1121 |
|
2013 |
854 |
1117 |
1971 |
|
2014 |
1115 |
1492 |
2607 |
|
2015 |
1275 |
1682 |
2957 |
|
2016 |
1374 |
1873 |
3247 |
|
2017 |
1601 |
2090 |
3691 |
|
2018 |
1757 |
2236 |
3993 |
|
2019 |
2029 |
2405 |
4434 |
|
2020 |
2225 |
2661 |
4886 |
Procediamo ora con le percentuali della composizione di genere della fascia.
Osserviamo che la percentuale media di donne (40,19%) e uomini (59,81%) negli RTD-A è più sfavorevole alle donne di quella dei ricercatori a tempo indeterminato dal 2008 al 2010, quando la media delle ricercatrici sul totale era del 45,21% contro il 54,79% dei ricercatori. A questo risultato contribuisce certamente il fatto che i primi 3 RTD-A reclutati in Lazio erano uomini.
Tabella 206 . RTD-A per genere. Anni 2010-2020. Percentuali sui totali della fascia. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
|
Anno |
RTD-A Donne |
RTD-A Uomini |
|
2010 |
0,00% |
100,00% |
|
2011 |
48,67% |
51,33% |
|
2012 |
43,18% |
56,82% |
|
2013 |
43,33% |
56,67% |
|
2014 |
42,77% |
57,23% |
|
2015 |
43,12% |
56,88% |
|
2016 |
42,32% |
57,68% |
|
2017 |
43,38% |
56,62% |
|
2018 |
44,00% |
56,00% |
|
2019 |
45,76% |
54,24% |
|
2020 |
45,54% |
54,46% |
Vediamo ora come e quanto crescono gli RTD-A.
Tabella 207 . Numerosità e crescita degli RTD-A. Anni 2010-2020. Valori assoluti, differenza e percentuali rispetto all’anno precedente. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
|
Anno |
Tot. RTD-A |
Crescita in percentuale |
Crescita in valori assoluti |
|
2010 |
3 |
||
|
2011 |
150 |
4900,00% |
147 |
|
2012 |
1121 |
647,33% |
971 |
|
2013 |
1971 |
75,83% |
850 |
|
2014 |
2607 |
32,27% |
636 |
|
2015 |
2957 |
13,43% |
350 |
|
2016 |
3247 |
9,81% |
290 |
|
2017 |
3691 |
13,67% |
444 |
|
2018 |
3993 |
8,18% |
302 |
|
2019 |
4434 |
11,04% |
441 |
|
2020 |
4886 |
10,19% |
452 |
|
Media 2010-2020 |
572,18% |
488,3 |
|
|
Media 2016-2020 |
10,58% |
385,8 |
I dati a nostra disposizione riguardano la numerosità degli RTD-A ad una certa data. Questo ci presenta il quadro di una crescita storicamente non costante. Secondo questi dati, dal 2011 al 2020, in termini di valori assoluti la crescita media degli RTD-A risulterebbe di circa 488,3 unità all’anno (385,8 dal 2016 al 2020).
Recentemente sono stati presentati in un’occasione pubblica dati relativi alla numerosità di RTD-A reclutati dal 2016 al 2019. [77] Mentre i dati a nostra disposizione registrano una situazione statica, che rappresenta il risultato di ingressi ed esiti dalla fascia, questi dati si riferiscono, appunto, esclusivamente al reclutamento. I dati sono stati forniti in forma aggregata per i 4 anni e distinti per Area CUN. [78]
Tabella 208 . Reclutamento degli RTD-A per area CUN. Anni 2016-2019. Valori assoluti. Fonte: ns. elaborazione dati ANVUR. [79]
|
Area CUN |
RTD-A – reclutamento 2016-2019 |
Media annuale |
|
Area 01 |
305 |
76,25 |
|
Area 02 |
310 |
77,50 |
|
Area 03 |
285 |
71,25 |
|
Area 04 |
105 |
26,25 |
|
Area 05 |
464 |
116,00 |
|
Area 06 |
936 |
234,00 |
|
Area 07 |
308 |
77,00 |
|
Area 08 |
400 |
100,00 |
|
Area 09 |
865 |
216,25 |
|
Area 10 |
408 |
102,00 |
|
Area 11 |
419 |
104,75 |
|
Area 12 |
283 |
70,75 |
|
Area 13 |
469 |
117,25 |
|
Area 14 |
166 |
41,50 |
|
Totale |
5723 |
1430,75 |
Ricordiamo ora la distribuzione di RTD-A nelle tre macro-aree del nostro Paese. Cominciamo col riassumere qui le serie storiche dei valori assoluti.
Tabella 209 . Numerosità degli RTD-A per area geografica. Anni 2010-2020. Valori assoluti. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
|
Anno |
RTD-A Nord |
RTD-A Centro |
RTD-A Sud e Isole |
Totale RTD-A |
|
2010 |
0 |
3 |
0 |
3 |
|
2011 |
52 |
21 |
77 |
150 |
|
2012 |
555 |
231 |
335 |
1121 |
|
2013 |
989 |
426 |
556 |
1971 |
|
2014 |
1278 |
623 |
706 |
2607 |
|
2015 |
1415 |
732 |
810 |
2957 |
|
2016 |
1525 |
819 |
903 |
3247 |
|
2017 |
1760 |
914 |
1017 |
3691 |
|
2018 |
1967 |
995 |
1031 |
3993 |
|
2019 |
2010 |
1052 |
1372 |
4434 |
|
2020 |
2285 |
1102 |
1499 |
4886 |
Osserviamo ora la distribuzione degli RTD-A nelle tre macro-aree del Paese in percentuale sul totale della fascia.
Tabella 210 . RTD-A per area geografica. Anni 2010-2020. Valori percentuali sul totale della fascia. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
|
Anno |
RTD-A Nord |
RTD-A Centro |
RTD-A Sud e Isole |
|
2010 |
0,00% |
100,00% |
0,00% |
|
2011 |
34,67% |
14,00% |
51,33% |
|
2012 |
49,51% |
20,61% |
29,88% |
|
2013 |
50,18% |
21,61% |
28,21% |
|
2014 |
49,02% |
23,90% |
27,08% |
|
2015 |
47,85% |
24,75% |
27,39% |
|
2016 |
46,97% |
25,22% |
27,81% |
|
2017 |
47,68% |
24,76% |
27,55% |
|
2018 |
49,26% |
24,92% |
25,82% |
|
2019 |
45,33% |
23,73% |
30,94% |
|
2020 |
46,77% |
22,55% |
30,68% |
Osserviamo anche la composizione di genere in percentuale rispetto ai totali delle aree geografiche.
Riscontriamo che, anche escludendo dalla media il 2010, la percentuale media di donne e uomini è: 45,23% di donne e 54,77% di uomini al Nord; 40,55% di donne e 59,45% di uomini al Centro; 44,84% di donne e 55,16% di uomini al Sud e nelle Isole.
Tabella 211 . RTD-A per genere e per area geografica. Anni 2010-2020. Valori percentuali sul totale dell’area. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
|
Nord |
Centro |
Sud e Isole |
||||
|
Anno |
RTD-A Donne |
RTD-A Uomini |
RTD-A Donne |
RTD-A Uomini |
RTD-A Donne |
RTD-A Uomini |
|
2010 |
0,00% |
100,00% |
||||
|
2011 |
51,92% |
48,08% |
33,33% |
66,67% |
50,65% |
49,35% |
|
2012 |
47,75% |
52,25% |
35,06% |
64,94% |
41,19% |
58,81% |
|
2013 |
45,80% |
54,20% |
38,03% |
61,97% |
42,99% |
57,01% |
|
2014 |
43,82% |
56,18% |
40,93% |
59,07% |
42,49% |
57,51% |
|
2015 |
42,61% |
57,39% |
42,49% |
57,51% |
44,57% |
55,43% |
|
2016 |
42,16% |
57,84% |
41,76% |
58,24% |
43,08% |
56,92% |
|
2017 |
43,75% |
56,25% |
42,01% |
57,99% |
43,95% |
56,05% |
|
2018 |
43,67% |
56,33% |
43,02% |
56,98% |
45,59% |
54,41% |
|
2019 |
45,87% |
54,13% |
44,49% |
55,51% |
46,57% |
53,43% |
|
2020 |
44,95% |
55,05% |
44,37% |
55,63% |
47,30% |
52,70% |
Nelle tabelle seguenti, la numerosità degli RTD-A nelle regioni italiane, in valori assoluti e in percentuali sulla fascia.
Tabella 212 . Numerosità degli RTD-A nelle regioni italiane. Anni 2010-2020. Valori assoluti. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
|
Anno |
Abruzzo |
Basilicata |
Calabria |
Campania |
Emilia Romagna |
Friuli |
Lazio |
Liguria |
Lombardia |
Marche |
Molise |
Piemonte |
Puglia |
Sardegna |
Sicilia |
Toscana |
Trentino Alto Adige |
Umbria |
Valle d’Aosta |
Veneto |
Totale |
|
2010 |
3 |
3 |
|||||||||||||||||||
|
2011 |
48 |
17 |
19 |
16 |
1 |
1 |
1 |
12 |
15 |
1 |
6 |
13 |
150 |
||||||||
|
2012 |
2 |
13 |
83 |
70 |
21 |
96 |
40 |
203 |
27 |
5 |
120 |
1 |
120 |
111 |
82 |
39 |
26 |
2 |
60 |
1121 |
|
|
2013 |
4 |
22 |
205 |
174 |
28 |
191 |
56 |
410 |
36 |
7 |
133 |
28 |
144 |
146 |
153 |
79 |
46 |
2 |
107 |
1971 |
|
|
2014 |
11 |
25 |
250 |
217 |
37 |
294 |
83 |
540 |
43 |
5 |
159 |
42 |
150 |
223 |
218 |
104 |
68 |
2 |
136 |
2607 |
|
|
2015 |
13 |
2 |
24 |
269 |
279 |
39 |
335 |
100 |
587 |
47 |
3 |
152 |
172 |
112 |
215 |
227 |
107 |
123 |
2 |
149 |
2957 |
|
2016 |
17 |
3 |
25 |
356 |
292 |
42 |
361 |
93 |
619 |
49 |
12 |
176 |
215 |
70 |
205 |
289 |
114 |
120 |
1 |
188 |
3247 |
|
2017 |
39 |
5 |
19 |
491 |
303 |
44 |
408 |
82 |
765 |
61 |
19 |
191 |
215 |
68 |
161 |
336 |
136 |
109 |
3 |
236 |
3691 |
|
2018 |
61 |
5 |
23 |
511 |
274 |
52 |
490 |
91 |
809 |
61 |
19 |
259 |
135 |
92 |
185 |
385 |
138 |
59 |
3 |
341 |
3993 |
|
2019 |
121 |
29 |
82 |
560 |
287 |
42 |
551 |
91 |
822 |
69 |
23 |
261 |
162 |
138 |
257 |
391 |
146 |
41 |
3 |
358 |
4434 |
|
2020 |
142 |
30 |
102 |
572 |
399 |
49 |
577 |
118 |
883 |
79 |
25 |
282 |
191 |
149 |
288 |
408 |
162 |
38 |
1 |
391 |
4886 |
Tabella 213 . RTD-A nelle regioni italiane. Anni 2010-2020. Valori percentuali sulla fascia. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
|
Anno |
Abruzzo |
Basilicata |
Calabria |
Campania |
Emilia Romagna |
Friuli |
Lazio |
Liguria |
Lombardia |
Marche |
Molise |
Piemonte |
Puglia |
Sardegna |
Sicilia |
Toscana |
Trentino Alto Adige |
Umbria |
Valle d’Aosta |
Veneto |
|
2010 |
100% |
|||||||||||||||||||
|
2011 |
32,00% |
11,33% |
0,00% |
12,67% |
0,00% |
10,67% |
0,67% |
0,67% |
0,00% |
0,67% |
8,00% |
10,0% |
0,67% |
4,00% |
0,00% |
0,00% |
8,67% |
|||
|
2012 |
0,18% |
0,00% |
1,16% |
7,40% |
6,24% |
1,87% |
8,56% |
3,57% |
18,11% |
2,41% |
0,45% |
10,7% |
0,09% |
10,7% |
9,90% |
7,31% |
3,48% |
2,32% |
0,18% |
5,35% |
|
2013 |
0,20% |
0,00% |
1,12% |
10,40% |
8,83% |
1,42% |
9,69% |
2,84% |
20,80% |
1,83% |
0,36% |
6,75% |
1,42% |
7,31% |
7,41% |
7,76% |
4,01% |
2,33% |
0,10% |
5,43% |
|
2014 |
0,42% |
0,00% |
0,96% |
9,59% |
8,32% |
1,42% |
11,28% |
3,18% |
20,71% |
1,65% |
0,19% |
6,10% |
1,61% |
5,75% |
8,55% |
8,36% |
3,99% |
2,61% |
0,08% |
5,22% |
|
2015 |
0,44% |
0,07% |
0,81% |
9,10% |
9,44% |
1,32% |
11,33% |
3,38% |
19,85% |
1,59% |
0,10% |
5,14% |
5,82% |
3,79% |
7,27% |
7,68% |
3,62% |
4,16% |
0,07% |
5,04% |
|
2016 |
0,52% |
0,09% |
0,77% |
10,96% |
8,99% |
1,29% |
11,12% |
2,86% |
19,06% |
1,51% |
0,37% |
5,42% |
6,62% |
2,16% |
6,31% |
8,90% |
3,51% |
3,70% |
0,03% |
5,79% |
|
2017 |
1,06% |
0,14% |
0,51% |
13,30% |
8,21% |
1,19% |
11,05% |
2,22% |
20,73% |
1,65% |
0,51% |
5,17% |
5,82% |
1,84% |
4,36% |
9,10% |
3,68% |
2,95% |
0,08% |
6,39% |
|
2018 |
1,53% |
0,13% |
0,58% |
12,80% |
6,86% |
1,30% |
12,27% |
2,28% |
20,26% |
1,53% |
0,48% |
6,49% |
3,38% |
2,30% |
4,63% |
9,64% |
3,46% |
1,48% |
0,08% |
8,54% |
|
2019 |
2,73% |
0,65% |
1,85% |
12,63% |
6,47% |
0,95% |
12,43% |
2,05% |
18,54% |
1,56% |
0,52% |
5,89% |
3,65% |
3,11% |
5,80% |
8,82% |
3,29% |
0,92% |
0,07% |
8,07% |
|
2020 |
2,91% |
0,61% |
2,09% |
11,71% |
8,17% |
1,00% |
11,81% |
2,42% |
18,07% |
1,62% |
0,51% |
5,77% |
3,91% |
3,05% |
5,89% |
8,35% |
3,32% |
0,78% |
0,02% |
8,00% |
|
2020 |
2,91% |
0,61% |
2,09% |
11,71% |
8,17% |
1,00% |
11,81% |
2,42% |
18,07% |
1,62% |
0,51% |
5,77% |
3,91% |
3,05% |
5,89% |
8,35% |
3,32% |
0,78% |
0,02% |
8,00% |
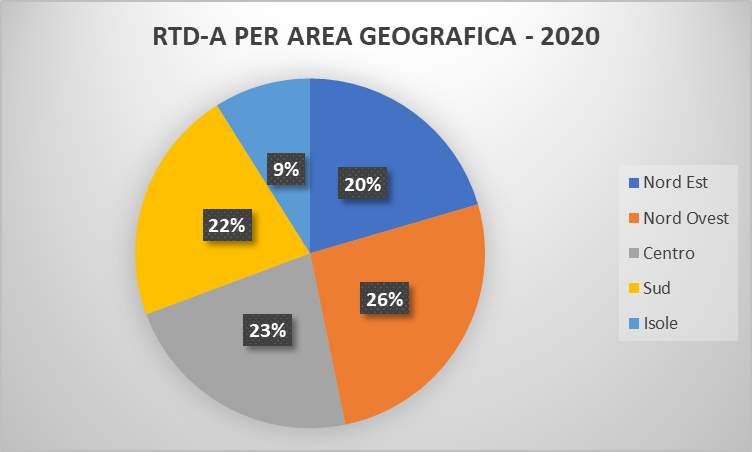
Figura 117 . RTD-A nelle aree geografiche. Valori percentuali. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
Concludiamo questo breve riepilogo con la distribuzione di RTD-A per aree CUN in valori assoluti.
Tabella 214 . RTD-A nelle aree CUN. Anni 2010-2020. Valori assoluti. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
|
Anno |
Area 01 |
Area 02 |
Area 03 |
Area 04 |
Area 05 |
Area 06 |
Area 07 |
Area 08 |
Area 09 |
Area 10 |
Area 11 |
Area 12 |
Area 13 |
Area 14 |
Totale |
|
2010 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||||
|
2011 |
2 |
3 |
7 |
4 |
10 |
19 |
3 |
11 |
29 |
29 |
9 |
6 |
14 |
4 |
150 |
|
2012 |
37 |
46 |
62 |
17 |
106 |
168 |
60 |
77 |
146 |
105 |
87 |
67 |
109 |
34 |
1121 |
|
2013 |
74 |
104 |
100 |
31 |
190 |
315 |
91 |
130 |
237 |
175 |
162 |
118 |
179 |
65 |
1971 |
|
2014 |
114 |
134 |
127 |
42 |
246 |
424 |
119 |
166 |
331 |
210 |
213 |
157 |
226 |
98 |
2607 |
|
2015 |
126 |
139 |
142 |
45 |
264 |
465 |
146 |
177 |
409 |
231 |
239 |
184 |
278 |
112 |
2957 |
|
2016 |
153 |
144 |
154 |
51 |
257 |
554 |
172 |
218 |
476 |
217 |
238 |
204 |
289 |
120 |
3247 |
|
2017 |
170 |
176 |
174 |
68 |
291 |
619 |
196 |
236 |
565 |
256 |
282 |
188 |
333 |
137 |
3691 |
|
2018 |
199 |
199 |
165 |
71 |
330 |
665 |
199 |
256 |
621 |
280 |
315 |
208 |
355 |
130 |
3993 |
|
2019 |
194 |
221 |
201 |
79 |
398 |
729 |
264 |
306 |
671 |
307 |
349 |
234 |
354 |
127 |
4434 |
|
2020 |
230 |
241 |
232 |
81 |
437 |
837 |
262 |
342 |
692 |
378 |
367 |
260 |
394 |
133 |
4886 |
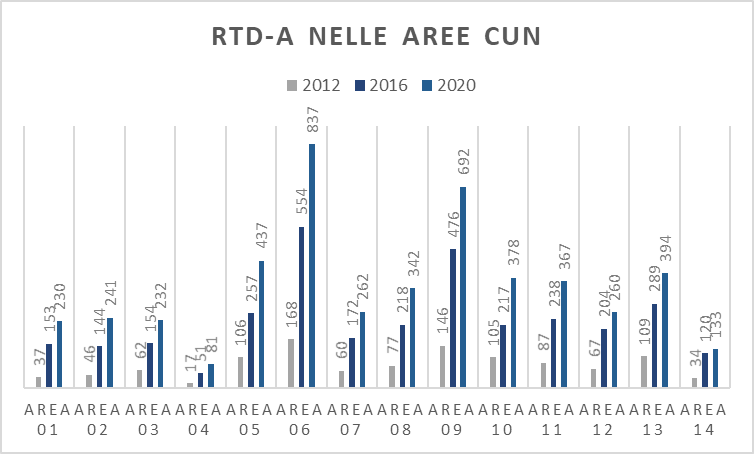
Figura 118 . RTD-A nelle aree CUN. Anni 2012, 2016, 2020. Valori assoluti. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
Vediamo ora la distribuzione degli RTD-A nelle aree CUN, in valori percentuali sul totale della fascia.
Tabella 215 . RTD-A nelle aree CUN. Anni 2010-2020. Valori percentuali sul totale della fascia. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
|
Anno |
Area 01 |
Area 02 |
Area 03 |
Area 04 |
Area 05 |
Area 06 |
Area 07 |
Area 08 |
Area 09 |
Area 10 |
Area 11 |
Area 12 |
Area 13 |
Area 14 |
|
2010 |
33,33% |
66,67% |
||||||||||||
|
2011 |
1,33% |
2,00% |
4,67% |
2,67% |
6,67% |
12,67% |
2,00% |
7,33% |
19,33% |
19,33% |
6,00% |
4,00% |
9,33% |
2,67% |
|
2012 |
3,30% |
4,10% |
5,53% |
1,52% |
9,46% |
14,99% |
5,35% |
6,87% |
13,02% |
9,37% |
7,76% |
5,98% |
9,72% |
3,03% |
|
2013 |
3,75% |
5,28% |
5,07% |
1,57% |
9,64% |
15,98% |
4,62% |
6,60% |
12,02% |
8,88% |
8,22% |
5,99% |
9,08% |
3,30% |
|
2014 |
4,37% |
5,14% |
4,87% |
1,61% |
9,44% |
16,26% |
4,56% |
6,37% |
12,70% |
8,06% |
8,17% |
6,02% |
8,67% |
3,76% |
|
2015 |
4,26% |
4,70% |
4,80% |
1,52% |
8,93% |
15,73% |
4,94% |
5,99% |
13,83% |
7,81% |
8,08% |
6,22% |
9,40% |
3,79% |
|
2016 |
4,71% |
4,43% |
4,74% |
1,57% |
7,91% |
17,06% |
5,30% |
6,71% |
14,66% |
6,68% |
7,33% |
6,28% |
8,90% |
3,70% |
|
2017 |
4,61% |
4,77% |
4,71% |
1,84% |
7,88% |
16,77% |
5,31% |
6,39% |
15,31% |
6,94% |
7,64% |
5,09% |
9,02% |
3,71% |
|
2018 |
4,98% |
4,98% |
4,13% |
1,78% |
8,26% |
16,65% |
4,98% |
6,41% |
15,55% |
7,01% |
7,89% |
5,21% |
8,89% |
3,26% |
|
2019 |
4,38% |
4,98% |
4,53% |
1,78% |
8,98% |
16,44% |
5,95% |
6,90% |
15,13% |
6,92% |
7,87% |
5,28% |
7,98% |
2,86% |
|
2020 |
4,71% |
4,93% |
4,75% |
1,66% |
8,94% |
17,13% |
5,36% |
7,00% |
14,16% |
7,74% |
7,51% |
5,32% |
8,06% |
2,72% |
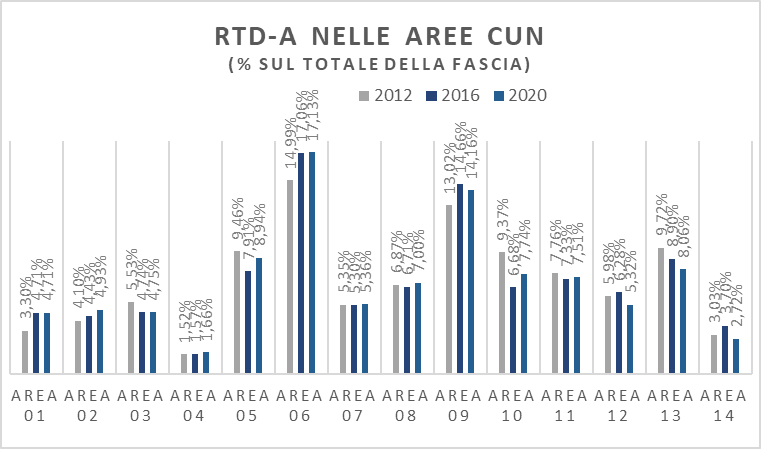
Figura 119 . RTD-A nelle aree CUN. Anni 2012, 2016, 2020. Valori percentuali sul totale della fascia. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
Confrontiamo ora la presenza di RTD-A nelle 14 aree CUN con la numerosità totale delle rispettive aree.
Tabella 216 . Incidenza degli RTD-A sul totale dei docenti/ricercatori di ciascuna area CUN. Anni 2010-2020. Valori percentuali sul totale delle singole aree. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
|
Anno |
Area 01 |
Area 02 |
Area 03 |
Area 04 |
Area 05 |
Area 06 |
Area 07 |
Area 08 |
Area 09 |
Area 10 |
Area 11 |
Area 12 |
Area 13 |
Area 14 |
|
2010 |
0,03% |
0,04% |
||||||||||||
|
2011 |
0,06% |
0,13% |
0,24% |
0,37% |
0,20% |
0,19% |
0,10% |
0,30% |
0,55% |
0,54% |
0,18% |
0,12% |
0,29% |
0,23% |
|
2012 |
1,16% |
2,06% |
2,12% |
1,61% |
2,17% |
1,70% |
1,97% |
2,12% |
2,78% |
2,01% |
1,82% |
1,39% |
2,27% |
1,94% |
|
2013 |
2,37% |
4,68% |
3,46% |
2,98% |
3,95% |
3,27% |
3,03% |
3,66% |
4,55% |
3,43% |
3,43% |
2,47% |
3,74% |
3,74% |
|
2014 |
3,68% |
6,10% |
4,46% |
4,09% |
5,20% |
4,52% |
4,00% |
4,77% |
6,37% |
4,25% |
4,63% |
3,34% |
4,77% |
5,69% |
|
2015 |
4,19% |
6,48% |
5,07% |
4,46% |
5,70% |
5,10% |
4,98% |
5,19% |
7,79% |
4,80% |
5,29% |
3,94% |
5,83% |
6,62% |
|
2016 |
5,05% |
6,66% |
5,51% |
5,09% |
5,56% |
6,13% |
5,82% |
6,39% |
8,97% |
4,60% |
5,34% |
4,41% |
6,06% |
7,16% |
|
2017 |
5,63% |
8,08% |
6,26% |
6,75% |
6,37% |
7,00% |
6,62% |
6,99% |
10,52% |
5,51% |
6,41% |
4,11% |
6,97% |
8,23% |
|
2018 |
6,57% |
8,96% |
5,91% |
6,92% |
7,07% |
7,58% |
6,64% |
7,47% |
11,22% |
6,06% |
7,06% |
4,51% |
7,32% |
7,86% |
|
2019 |
6,28% |
9,58% |
7,01% |
7,55% |
8,32% |
8,24% |
8,60% |
8,65% |
11,74% |
6,55% |
7,69% |
5,00% |
7,13% |
7,61% |
|
2020 |
7,34% |
10,24% |
8,04% |
7,79% |
9,12% |
9,45% |
8,56% |
9,63% |
11,93% |
8,00% |
8,10% |
5,53% |
7,76% |
7,66% |
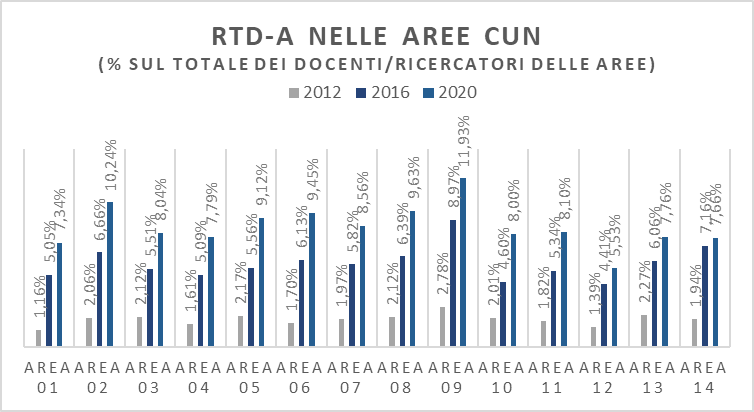
Figura 120 . Incidenza degli RTD-A sul totale dei docenti/ricercatori di ciascuna area CUN . Anni 2012, 2016, 2020. Valori percentuali sul totale dell’area. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
Il reclutamento di assegnisti di ricerca è regolato dall’art. 22 della legge 240/2010 che, al comma 2, stabilisce che «possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca». Il dottorato di ricerca non è un requisito obbligatorio (a meno che nel bando non sia diversamente indicato), ma costituisce tuttavia sempre titolo preferenziale.
Le risorse per gli assegni provengono da finanziamenti di varia natura (progetti nazionali o europei, Fondo di Finanziamento degli Atenei o fonti esterne) e gli assegni, non collegati ai punti organico, dipendono dalla semplice disponibilità di risorse.
Gli assegnisti – reclutati per svolgere un’attività lavorativa di ricerca su progetti sotto la guida di un responsabile – possono svolgere anche funzioni di didattica sussidiaria e avere in affidamento incarichi di docenza, se i regolamenti di ateneo lo consentono . I contratti sono da un anno a tre anni, per una durata complessiva che non può superare i dodici anni, anche non continuativi e in sedi e enti diversi. Gli assegnisti possono concorrere per posizioni di RTD-A oppure di RTD-B, se hanno cumulato già tre anni di assegno o hanno ottenuto l’abilitazione.
Il database del Miur – interrogato il 31 dicembre 2020 – riporta un totale di 14.476 assegnisti.
L’interrogazione del database Miur è possibile solo “ad oggi” e la variabile del genere non è presente. Tuttavia fra quelli contenuti nel Portale dei dati dell’istruzione superiore (USTAT-Miur) è stato possibile estrarre dati essenziali riguardanti gli assegnisti dal 2012 al 2019. [80]
Nella tabella seguente riportiamo i totali per anno e per genere.
Tabella 217 . Assegnisti di ricerca per genere. Anni 2012-2019. Valori assoluti. Fonte: ns. Elaborazione dati USTAT-Miur.
|
Anno |
Assegniste |
Assegnisti |
Totale |
|
2012 |
8071 |
7676 |
15747 |
|
2013 |
8183 |
8097 |
16280 |
|
2014 |
8048 |
7861 |
15909 |
|
2015 |
7151 |
6891 |
14042 |
|
2016 |
7096 |
6850 |
13946 |
|
2017 |
7110 |
7014 |
14124 |
|
2018 |
7071 |
7034 |
14105 |
|
2019 |
7195 |
7264 |
14459 |
|
Variaz. % 2012-2019 |
-10,85% |
-5,37% |
-8,18% |
Vediamo innanzitutto che la numerosità degli assegnisti ha avuto un picco negativo nel 2016 (-11,44%) e con qualche oscillazione è in ripresa. Rispetto al 2012 la decrescita è dell’8,18% e riguarda maggiormente le donne (-10,85%).
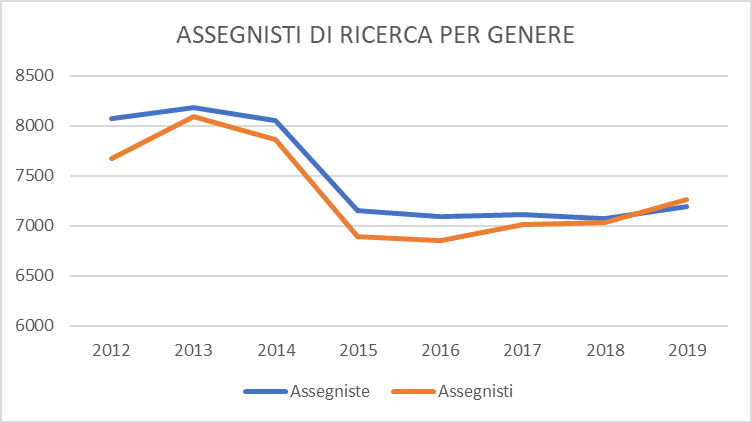
Figura 121 . Assegnisti di ricerca per genere. Anni 2012-2019. Valori assoluti. Fonte: ns. Elaborazione dati USTAT-Miur.
La cosa è maggiormente evidente nell’incidenza percentuale delle donne e degli uomini sui totali, come si evince dalla tabella seguente.
Tabella 218 . Assegnisti di ricerca per genere. Anni 2012-2019. Valori percentuali. Fonte: ns. Elaborazione dati USTAT-Miur.
|
Anno |
Assegniste |
Assegnisti |
|
2012 |
51,25% |
48,75% |
|
2013 |
50,26% |
49,74% |
|
2014 |
50,59% |
49,41% |
|
2015 |
50,93% |
49,07% |
|
2016 |
50,88% |
49,12% |
|
2017 |
50,34% |
49,66% |
|
2018 |
50,13% |
49,87% |
|
2019 |
49,76% |
50,24% |
|
Media 2012-2019 |
50,52% |
49,48% |
Nel segmento temporale considerato le donne hanno in media un’incidenza superiore a quella degli uomini, ma l’evoluzione pare stabilmente essere quella di un aumento della componente maschile a scapito di quella femminile, come appare evidente nella figura seguente.
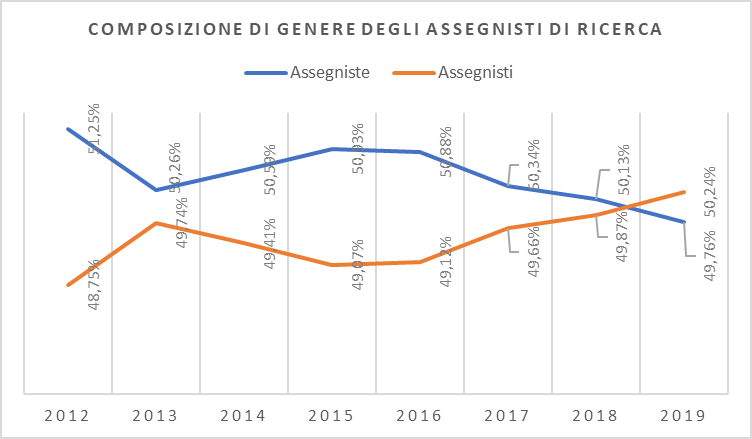
Figura 122 . Assegnisti di ricerca per genere. Anni 2012-2019. Valori percentuali. Fonte: ns. Elaborazione dati USTAT-Miur.
Degli assegnisti del 2020 non conosciamo la distribuzione per genere ma, tuttavia, su di essi siamo in grado di elaborare una serie di informazioni.
Cominciamo prendendo in considerazione la distribuzione degli assegnisti nelle tre macro-aree del Paese in valori assoluti e in percentuale.
Tabella 219 . Numerosità degli assegnisti di ricerca per area geografica. Anno 2020. Valori assoluti e percentuali sul totale. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
|
Nord |
Centro |
Sud e Isole |
Totale |
|
8675 |
3573 |
2228 |
14476 |
|
59,93% |
24,68% |
15,39% |
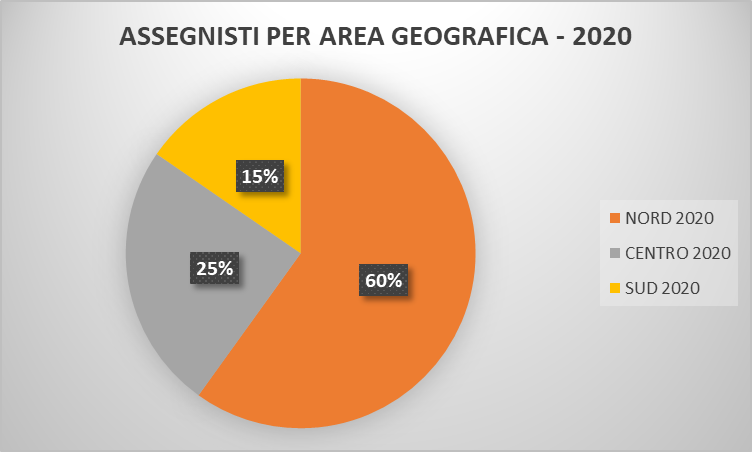
Figura 123 . Numerosità degli assegnisti di ricerca per area geografica. Anno 2020. Percentuali sul totale. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
Come di consueto, scendiamo nel dettaglio regione per regione, cominciando dalle regioni del Nord.
Tabella 220 . NORD. Numerosità degli assegnisti di ricerca per regione. Anno 2020. Valori assoluti e percentuali sul totale dell’area geografica e della fascia. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
|
Anno |
Valle d’Aosta |
Piemonte |
Liguria |
Emilia Romagna |
Lombardia |
Veneto |
Friuli |
Trentino Alto Adige |
Totale |
|
2020 |
8 |
1076 |
332 |
1924 |
2967 |
1540 |
364 |
464 |
8675 |
|
% area |
0,09% |
12,40% |
3,83% |
22,18% |
34,20% |
17,75% |
4,20% |
5,35% |
100,00% |
|
% totale |
0,06% |
7,43% |
2,29% |
13,29% |
20,50% |
10,64% |
2,51% |
3,21% |
59,93% |
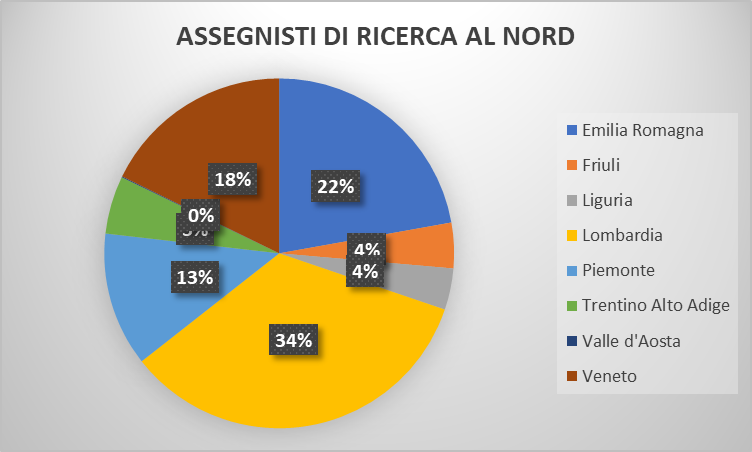
Figura 124 . NORD. Numerosità degli assegnisti di ricerca per regione. Anno 2020. Valori percentuali sul totale dell’area. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
Passiamo ora alle regioni del Centro.
Tabella 221 . CENTRO. Numerosità degli assegnisti di ricerca per regione. Anno 2020. Valori assoluti e percentuali sul totale dell’area geografica e della fascia. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
|
Anno |
Lazio |
Marche |
Toscana |
Umbria |
Totale |
|
2020 |
1452 |
381 |
1522 |
218 |
3573 |
|
% area |
40,64% |
10,66% |
42,60% |
6,10% |
100,00% |
|
% totale |
10,03% |
2,63% |
10,51% |
1,51% |
24,68% |
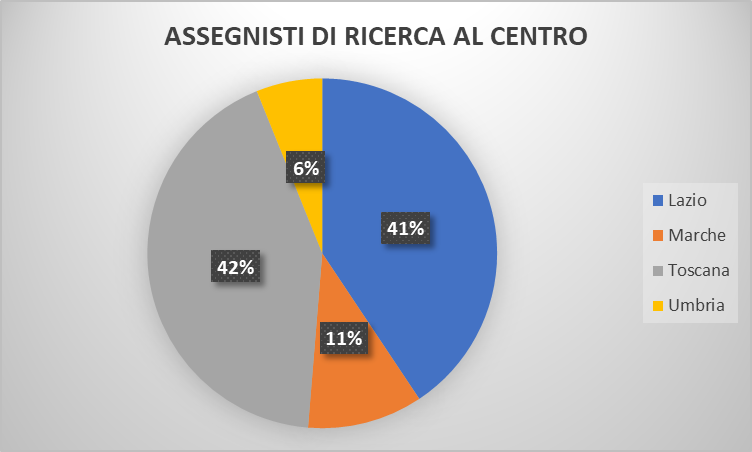
Figura 125 . CENTRO. Numerosità degli assegnisti di ricerca per regione. Anno 2020. Valori percentuali sul totale dell’area. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
Veniamo, infine, alle regioni del Sud e alle Isole.
Tabella 222 . SUD e ISOLE. Numerosità degli assegnisti di ricerca per regione. Anno 2020. Valori assoluti e percentuali sul totale dell’area geografica e della fascia. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
|
Anno |
Abruzzo |
Molise |
Basilicata |
Campania |
Calabria |
Puglia |
Sardegna |
Sicilia |
Totale |
|
2020 |
257 |
35 |
37 |
827 |
288 |
302 |
194 |
288 |
2228 |
|
% area |
11,54% |
1,57% |
1,66% |
37,12% |
12,93% |
13,55% |
8,71% |
12,93% |
100,01% |
|
% totale |
1,78% |
0,24% |
0,26% |
5,71% |
1,99% |
2,09% |
1,34% |
1,99% |
15,39% |
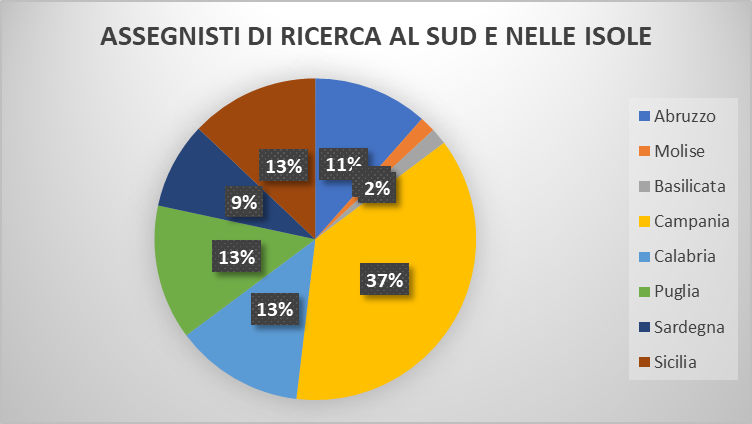
Figura 126 . SUD e ISOLE. Numerosità degli assegnisti di ricerca per regione. Anno 2020. Valori percentuali sul totale dell’area. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
Veniamo ora al confronto fra tutte le regioni italiane, con istogrammi che presentano la numerosità degli assegnisti nelle singole regioni in ordine decrescente.
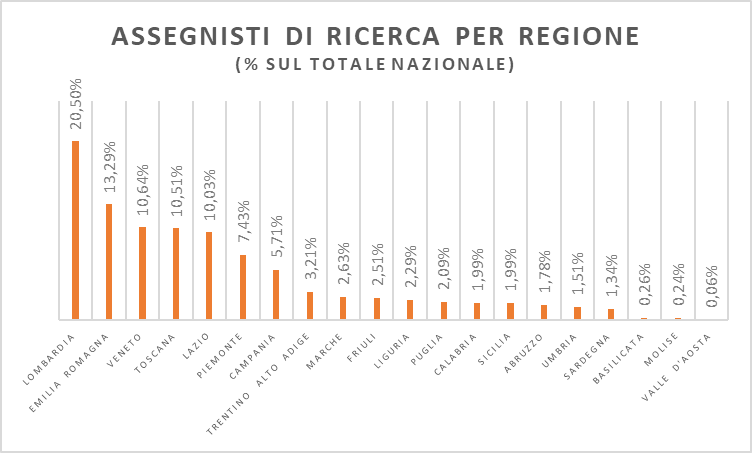
Figura 127 . Numerosità degli assegnisti di ricerca nelle regioni italiane. Anno 2020. Valori percentuali sul totale nazionale. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
Cerchiamo ora di approssimare quali siano le prospettive di stabilizzazione degli assegnisti. Ovviamente non si possono fare previsioni sull’andamento del reclutamento degli RTD-B. Sappiamo che dal 2016 al 2019 sono stati reclutati in tutto 5.540 RTD-B, [81] cifra dalla quale ricaviamo una media di reclutati di 1.385 unità all’anno, dei quali non conosciamo la distribuzione geografica. Dai dati a nostra disposizione sappiamo soltanto che dal 2016 al 2020 gli RTD-B sono cresciuti in media di circa 388 unità all’anno al Nord (circa il 49%), circa 178 al Centro (circa il 23%) e circa 223 al Sud e nelle Isole (circa il 28%; le cifre sono state tutte arrotondate all’unità superiore). Potremmo quindi ipotizzare che le cifre della crescita rispecchino i reclutamenti, almeno in percentuale. Se così fosse, i 1.385 reclutati annuali sarebbero così ripartiti: Nord 679; Centro 319; Sud e Isole 389, cifre tutte arrotondate all’unità superiore.
Analogamente, non possiamo prevedere quale sarà il numero degli assegnisti negli anni a venire, o anche soltanto nel 2021. Sappiamo solo che dal 2012 al 2020 nell’università italiana abbiamo avuto una media di 14.788 assegnisti all’anno (anche questa cifra è arrotondata all’unità superiore). Ponendo che il numero di RTD-B reclutati in un anno rimanga simile anche per il 2021 alle medie finora registrate, possiamo confrontare il numero degli assegnisti con quello della media del reclutamento annuale degli RTD-B dal 2016 al 2019. Attraverso questo confronto possiamo tentare di calcolare la percentuale di assegnisti che nel 2021 hanno “probabilità di stabilizzazione” nelle tre macro aree.
Ovviamente questo calcolo – oltre ad essere puramente ipotetico e a non avere alcuna validità previsionale – non tiene conto degli altri competitors (vale a dire degli RTD-A che hanno concluso i trienni e di un numero cospicuo di abilitati alla seconda fascia in questo momento esterni al sistema della ricerca universitaria italiana), né può tener conto – data la natura dei dati a nostra disposizione – dell’“anzianità” degli assegnisti: non sappiamo infatti quanti anni di assegno abbiano cumulato i singoli assegnisti nel momento in cui estraiamo i dati. Questo calcolo ci è quindi utile più che altro a comprendere quale sia l’ordine di grandezza della precarizzazione e a prendere coscienza delle alte probabilità di espulsione di personale altamente formato e qualificato dal sistema della ricerca italiano.
Tabella 223 . Numerosità degli assegnisti di ricerca e percentuali della “probabilità di stabilizzazione” degli assegnisti nel 2021 sul totale dell’area. Anno 2020. Valori assoluti e percentuali. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca e ANVUR. [82]
|
Area geografica |
Nord |
Centro |
Sud e Isole |
Totale |
|
Assegnisti di ricerca |
8675 |
3573 |
2228 |
14476 |
|
“Probabilità di stabilizzazione” |
7,82% |
8,92% |
17,41% |
9,57% |
Vediamo come, piuttosto contro-intuitivamente, gli assegnisti sembrerebbero avere maggiori probabilità di stabilizzazione non dove c’è la maggiore concentrazione di RTD-B e degli assegnisti stessi ma, piuttosto, nelle aree dove la concentrazione di assegnisti e di RTD-B è più bassa.
Vediamo ora le prospettive di ricambio per aree CUN, esaminando la numerosità degli assegnisti per singola area, in valori assoluti e in percentuale rispetto alla numerosità dei docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato della stessa area. Presenteremo solo i grafici.
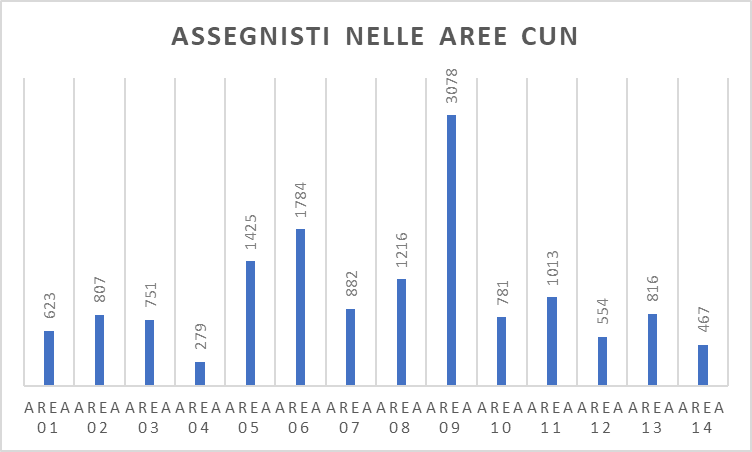
Figura 128 . Numerosità degli assegnisti di ricerca per area CUN. Anno 2020. Valori assoluti. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
Posto che il numero degli assegnisti è pari al 25,74% del numero dei docenti/ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato, vediamo come questo rapporto si modifica nelle diverse aree CUN.
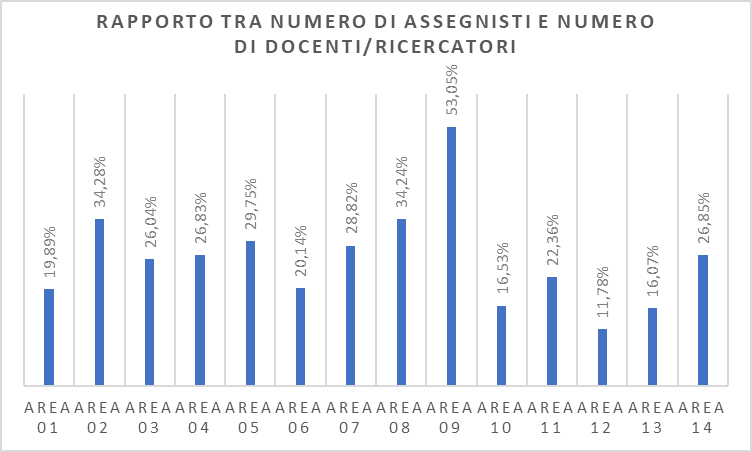
Figura 129 . Confronto tra assegnisti di ricerca e docenti/ricercatori per area CUN. Anno 2020. Valori percentuali rispetto al numero di docenti/ricercatori dell’area. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca.
Cerchiamo ora di capire quali siano le prospettive di stabilizzazione degli assegnisti reclutati nelle diverse aree CUN. Anche in questo caso vale il discorso già fatto per le regioni. Ovviamente non si possono fare previsioni sull’andamento del reclutamento degli RTD-B. Tuttavia abbiamo i dati relativi alla numerosità di RTD-B reclutati dal 2016 al 2019 forniti in forma aggregata per i 4 anni e distinti per area CUN (cfr. Tabella 194 ). [83]
Posto che la numerosità degli RTD-B reclutati nel 2021 rimanga simile alle medie finora registrate, sarà possibile approssimare la percentuale di “probabili reclutati nel 2021” sugli assegnisti di ciascuna area CUN. Anche qui valgono le osservazioni già fatte: questo calcolo non tiene conto degli RTD-A che hanno concluso i trienni e degli abilitati in seconda fascia “esterni”, né può tener conto – data la natura dei dati a nostra disposizione – dell’“anzianità” degli assegnisti. Il calcolo non ha quindi alcuna validità previsionale, ma serve solo a stabilire un ordine di grandezza fra gli assegnisti e i reclutati in prospettiva della stabilizzazione.
Tabella 224 . Numerosità degli assegnisti di ricerca per area CUN, media del reclutamento annuale di RTD-B dal 2016 al 2019 e percentuali della “probabilità di stabilizzazione” degli assegnisti nel 2021 sul totale delle singole aree. Anno 2020. Valori assoluti e percentuali della media dei reclutati sugli assegnisti. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca e ANVUR.
|
Area CUN |
Area 01 |
Area 02 |
Area 03 |
Area 04 |
Area 05 |
Area 06 |
Area 07 |
Area 08 |
Area 09 |
Area 10 |
Area 11 |
Area 12 |
Area 13 |
Area 14 |
|
Assegnisti 2020 |
623 |
807 |
751 |
279 |
1425 |
1784 |
882 |
1216 |
3078 |
781 |
1013 |
554 |
816 |
467 |
|
Media re clutamento RTD-B 2016-2019 |
85,25 |
70,25 |
72,75 |
24,25 |
132,25 |
186,25 |
66 |
86,5 |
151,75 |
134,5 |
122,25 |
81,25 |
121 |
50,75 |
|
“Probabilità di stabilizzazione” |
13,68% |
8,71% |
9,69% |
8,69% |
9,28% |
10,44% |
7,48% |
7,11% |
4,93% |
17,22% |
12,07% |
14,67% |
14,83% |
10,87% |
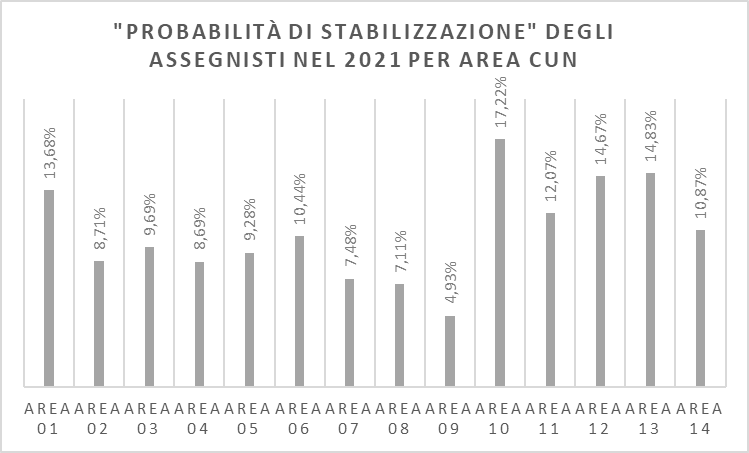
Figura 130 . Percentuali della “probabilità di stabilizzazione” degli assegnisti nel 2021 per area CUN, calcolata sulla media del reclutamento annuale degli RTD-B nel periodo 2016-2019 nelle singole aree. Anno 2020. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca e ANVUR.
Anche in questo caso notiamo come non sempre la maggiore presenza di ricercatori a tempo determinato e di assegnisti in un’area implichi maggiori speranze di stabilizzazione per gli afferenti. Si veda in particolare il caso dell’Area 09 – Ingegneria industriale e dell’informazione, in cui, malgrado l’aumento di numerosità, tanto più notevole in un contesto di generale decrescita, si prefigura (pur con tutti i caveat già indicati) una probabilità di stabilizzazione degli assegnisti inferiore al 5% del loro attuale numero.
In questo paragrafo trattiamo i dati relativi a borse di studio e di ricerca per laureati, ai contratti di prestazione autonoma per programmi di ricerca, ai contratti di formazione specialistica dei medici e tecnologi a tempo deter minato. [84] L’USTAT-Miur riunisce questi dati nel file: 2015-2019 Collaboratori in attività di ricerca . [85] In questo file viene indicato il genere del titolare del contratto, ma non vengono specificati né il settore scientifico-disciplinare o l’area CUN, [86] né l’estensione temporale dei contratti. Per questo motivo, dato che l’estensione temporale di questi rapporti è estremamente variabile e può essere inferiore o superiore all’anno solare, in questo paragrafo diversamente che negli altri, non parleremo di numerosità dei collaboratori ma di numero di contratti di collaborazione stipulati in un anno.
Dal 2015 al 2019 il numero dei contratti di collaborazione in attività di ricerca ha conosciuto un notevole incremento.
Tabella 225 . Contratti di collaborazione in attività di ricerca. Anni 2015-2019. Valori assoluti e variazione percentuale. Anni 2015-2019. Fonte: ns. elaborazione dati USTAT-Miur.
|
Anno |
Contratti di collaborazione in attività di ricerca |
|
2015 |
42374 |
|
2016 |
51994 |
|
2017 |
50595 |
|
2018 |
55032 |
|
2019 |
58905 |
|
Variaz. % 2015-2019 |
+39,01% |
Esaminiamo ora la composizione di genere dei titolari dei contratti, partendo dai valori assoluti e dalle variazioni percentuali nel periodo preso in esame.
Tabella 226 . Contratti di collaborazione in attività di ricerca per genere. Anni 2015-2019. Valori assoluti e variazioni percentuali. Fonte: ns. elaborazione dati USTAT-Miur.
|
Anno |
Titolari donne |
Titolari uomini |
Totale |
|
2015 |
25167 |
17207 |
42374 |
|
2016 |
29904 |
22090 |
51994 |
|
2017 |
28337 |
22258 |
50595 |
|
2018 |
30467 |
24565 |
55032 |
|
2019 |
31842 |
27063 |
58905 |
|
Variaz. % 2015-2019 |
+26,52% |
+57,28% |
+39,01% |
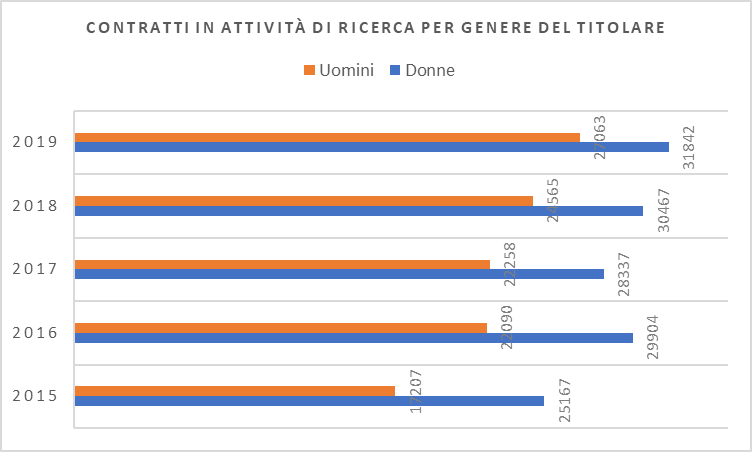
Figura 131 . Contratti di collaborazione in attività di ricerca per genere del titolare. Anni 2015-2019. Valori assoluti. Fonte: ns. elaborazione dati USTAT-Miur.
Quello dei contratti di collaborazione in attività di ricerca è uno dei rarissimi casi in cui il numero delle titolari di contratti donne sopravanza quello degli uomini anche se, nella crescita del periodo preso in esame (+39,01%), i contratti assegnati agli uomini crescono molto più di quelli assegnati alle donne (+57,28% contro il +26,52% delle donne).
Esaminiamo qui le percentuali della composizione di genere dei titolari dei contratti di collaborazione nel periodo preso in esame.
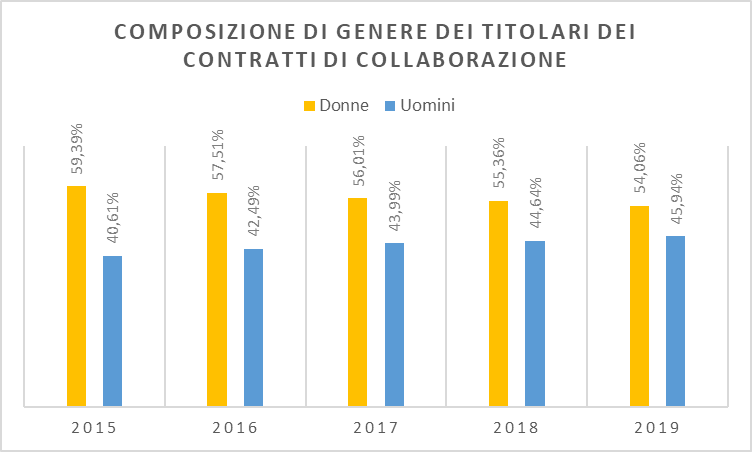
Figura 132 . Contratti di collaborazione in attività di ricerca per genere del titolare. Anni 2015-2019. Valori percentuali sul totale. Fonte: ns. elaborazione dati USTAT-Miur.
Esaminiamo ora il numero dei contratti di collaborazione in attività di ricerca stipulati nell’anno nelle diverse aree del Paese e le variazioni percentuali nel periodo preso in esame.
Tabella 227 . Contratti di collaborazione in attività di ricerca per area geografica. Anni 2015-2019. Valori assoluti e variazioni percentuali. Fonte: ns. elaborazione dati USTAT-Miur.
|
Anno |
Nord-Est |
Nord-Ovest |
Centro |
Sud |
Isole |
Totale |
|
2015 |
8194 |
11311 |
9849 |
7523 |
5497 |
42374 |
|
2016 |
11935 |
13693 |
11453 |
8928 |
5985 |
51994 |
|
2017 |
11687 |
13940 |
11533 |
8521 |
4914 |
50595 |
|
2018 |
13728 |
14640 |
12084 |
9116 |
5464 |
55032 |
|
2019 |
14383 |
15725 |
12605 |
10283 |
5909 |
58905 |
|
Variaz. % 2015-2019 |
+75,53% |
+39,02% |
+27,98% |
+36,69% |
+7,49% |
+39,01% |
Notiamo una crescita generalizzata del numero dei contratti di collaborazione in attività di ricerca rilevati ogni anno dal Miur, sebbene anche in questo caso le diverse aree del Paese si muovano in maniera differente. Osserviamo l’incidenza percentuale del numero dei contratti nelle tre macro-aree geografiche sul totale dei contratti stipulati ogni anno.
Tabella 228 . Contratti di collaborazione in attività di ricerca per area geografica. Anni 2015-2019. Valori percentuali sul totale nazionale. Fonte: ns. elaborazione dati USTAT-Miur.
|
Anno |
Nord |
Centro |
Sud e Isole |
|
2015 |
46,03% |
23,24% |
30,73% |
|
2016 |
49,29% |
22,03% |
28,68% |
|
2017 |
50,65% |
22,79% |
26,55% |
|
2018 |
51,55% |
21,96% |
26,49% |
|
2019 |
51,11% |
21,40% |
27,49% |
|
Variaz. punti percentuali |
+5,08 |
-1,84 |
-3,24 |
La concentrazione del numero di contratti di collaborazione in attività di ricerca cresce nel Nord fino ad arrivare, nel 2019, ad una percentuale superiore al 50% del totale nazionale; decresce invece al Centro e, in maniera ancor più accentuata, nel Sud e nelle Isole. La percentuale media di contratti di collaborazione in attività di ricerca sul totale nazionale è, nel periodo preso in esame, del 49,73% al Nord, del 22,28% al Centro e del 27,99% al Sud e nelle Isole.
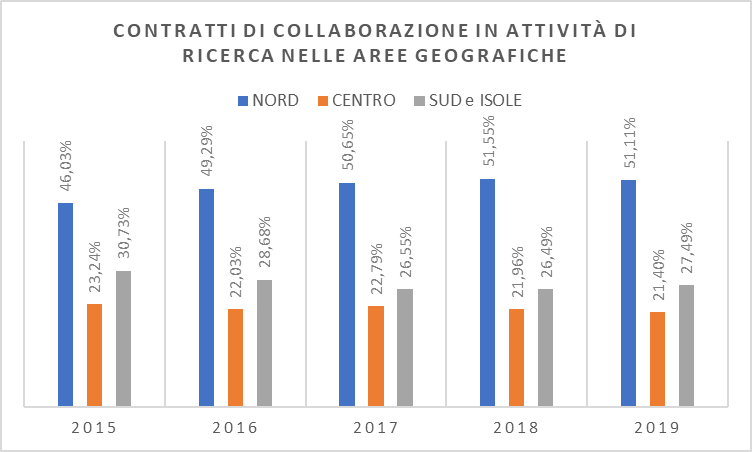
Figura 133 . Contratti di collaborazione in attività di ricerca per area geografica. Anni 2015-2019. Valori percentuali sul totale nazionale. Fonte: ns. elaborazione dati USTAT-Miur.
Guardiamo ora al numero dei contratti di collaborazione in attività di ricerca stipulati in un anno nelle tre macro-aree del Paese in dettaglio.
Esaminiamo prima la situazione del Nord regione per regione. Come di consueto, la situazione presenta rilevanti differenze al suo interno. Partiamo dai valori assoluti e dalle variazioni percentuali dal 2015 al 2019.
Tabella 229 . NORD. Contratti di collaborazione in attività di ricerca per regione. Anni 2015-2019. Valori assoluti e variazioni percentuali. Fonte: ns. elaborazione dati USTAT-Miur.
|
Anno |
Valle d’Aosta |
Piemonte |
Liguria |
Emilia-Romagna |
Lombardia |
Veneto |
Friuli Venezia-Giulia |
Trentino-Alto Adige |
NORD |
|
2015 |
31 |
2677 |
1116 |
3170 |
7487 |
3828 |
981 |
215 |
19505 |
|
2016 |
19 |
3370 |
1108 |
3503 |
9196 |
6399 |
1182 |
851 |
25628 |
|
2017 |
10 |
3699 |
964 |
3940 |
9267 |
5827 |
1121 |
799 |
25627 |
|
2018 |
8 |
3826 |
999 |
4309 |
9807 |
7482 |
1217 |
720 |
28368 |
|
2019 |
10 |
4150 |
1214 |
4433 |
10351 |
7953 |
1278 |
719 |
30108 |
|
Variaz. % 2015-2019 |
-67,74% |
+55,02% |
+8,78% |
+39,84% |
+38,25% |
+107,76% |
+30,28% |
+234,42% |
+54,36% |
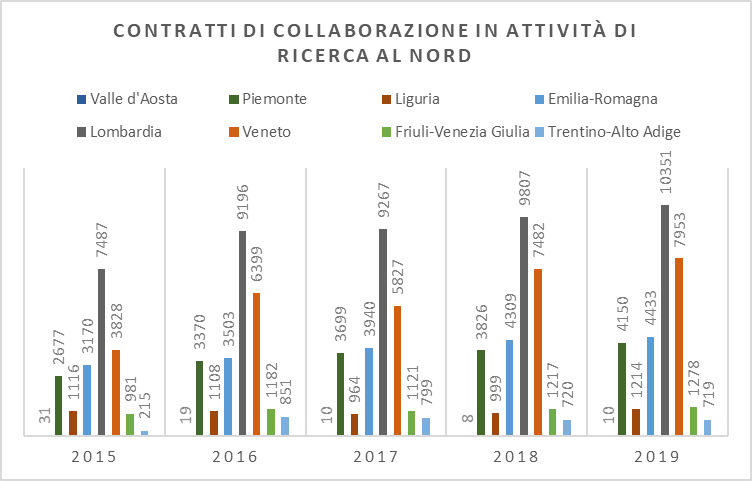
Figura 134 . NORD. Contratti di collaborazione in attività di ricerca per regione. Anni 2015-2019. Valori assoluti. Fonte: ns. elaborazione dati USTAT-Miur.
Esaminiamo ora la situazione del Centro regione per regione. Partiamo dai valori assoluti e dalle variazioni percentuali dal 2015 al 2019.
Tabella 230 . CENTRO. Contratti di collaborazione in attività di ricerca per regione. Anni 2015-2019. Valori assoluti e variazioni percentuali. Fonte: ns. elaborazione dati USTAT-Miur.
|
Anno |
Lazio |
Marche |
Toscana |
Umbria |
CENTRO |
|
2015 |
4734 |
643 |
3798 |
674 |
9849 |
|
2016 |
5179 |
875 |
4579 |
820 |
11453 |
|
2017 |
5127 |
985 |
4740 |
681 |
11533 |
|
2018 |
4966 |
1018 |
5190 |
910 |
12084 |
|
2019 |
5031 |
1148 |
5541 |
885 |
12605 |
|
Variaz. % 2015-2019 |
+6,27% |
+78,54% |
+45,89% |
+31,31% |
+27,98% |
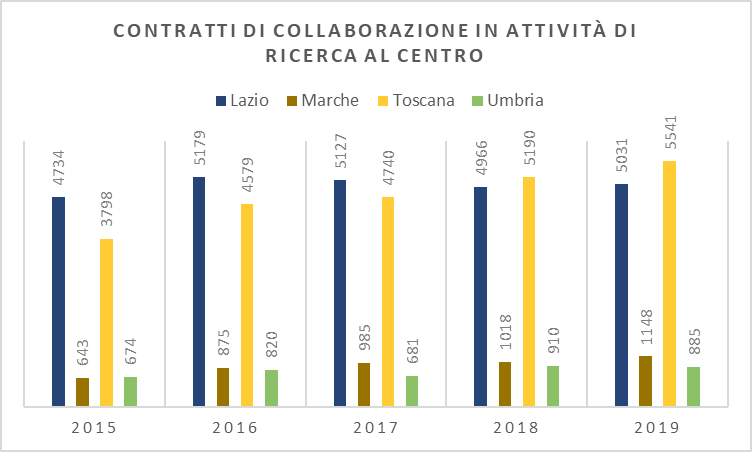
Figura 135 . CENTRO Contratti di collaborazione in attività di ricerca per regione. Anni 2015-2019. Valori assoluti. Fonte: ns. elaborazione dati USTAT-Miur.
Esaminiamo ora i dati del Sud e delle Isole.
Tabella 231 . SUD e ISOLE. Contratti di collaborazione in attività di ricerca per regione. Anni 2015-2019. Valori assoluti e variazioni percentuali. Fonte: ns. elaborazione dati USTAT-Miur.
|
Anno |
Abruzzo |
Molise |
Basilicata |
Campania |
Calabria |
Puglia |
Sardegna |
Sicilia |
SUD e ISOLE |
|
2015 |
1320 |
42 |
126 |
3483 |
718 |
1834 |
1893 |
3604 |
13020 |
|
2016 |
1307 |
61 |
40 |
4683 |
640 |
2197 |
2073 |
3912 |
14913 |
|
2017 |
1366 |
51 |
84 |
4524 |
719 |
1777 |
1814 |
3100 |
13435 |
|
2018 |
1260 |
78 |
82 |
4674 |
806 |
2216 |
1890 |
3574 |
14580 |
|
2019 |
1244 |
71 |
82 |
5778 |
797 |
2311 |
2350 |
3559 |
16192 |
|
Variaz. % 2015-19 |
-5,76% |
+69,05% |
-34,92% |
+65,89% |
+11,00% |
+26,01% |
+24,14% |
-1,25% |
+24,36% |
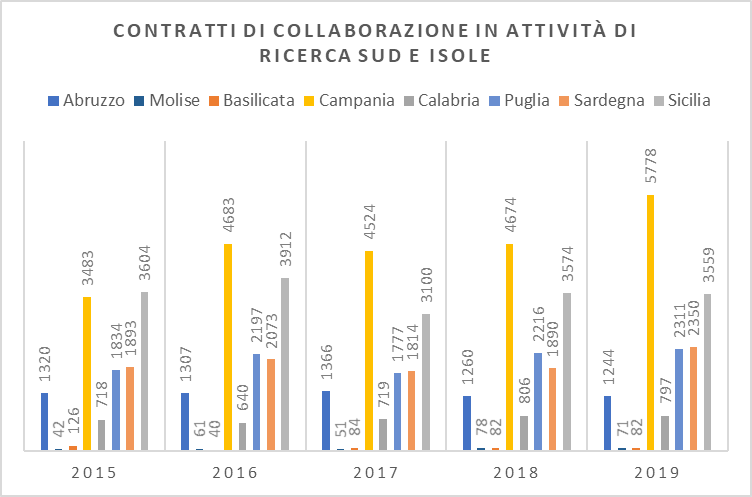
Figura 136 . SUD e ISOLE. Contratti di collaborazione in attività di ricerca per regione. Anni 2015-2019. Valori assoluti. Fonte: ns. elaborazione dati USTAT-Miur.
Approfondiamo ora la situazione dei contratti a collaboratori in attività di ricerca nel sistema delle università statali, non statali legalmente riconosciute, e telematiche. Cominciamo dai valori assoluti.
Tabella 232 . Contratti di collaborazione in attività di ricerca per grandezza e tipologia degli atenei. Anni 2015-2019. Valori assoluti e variazioni percentuali. Fonte: ns. elaborazione dati USTAT-Miur.
|
Anno |
Statali |
Non statali |
Telematiche |
Totale |
|
2015 |
40100 |
2256 |
18 |
42374 |
|
2016 |
48283 |
3669 |
42 |
51994 |
|
2017 |
46898 |
3676 |
21 |
50595 |
|
2018 |
51208 |
3790 |
34 |
55032 |
|
2019 |
54699 |
4028 |
178 |
58905 |
|
Variaz. % 2015-2019 |
+36,41% |
+78,55% |
+888,89% |
+39,01% |
Esaminiamo ora la situazione del sistema statale nella sua articolazione. La situazione presenta rilevanti differenze al suo interno. Le differenze sono legate alle diverse dimensioni degli atenei ma, evidentemente, anche alla loro collocazione geografica, che qui non prendiamo in considerazione, e alla diversa funzione e specializzazione (nel caso di Politecnici e Scuole Superiori). Partiamo dai valori assoluti e dalle variazioni percentuali.
Tabella 233 . Università STATALI. Contratti di collaborazione in attività di ricerca per grandezza e tipologia degli atenei. Anni 2015-2019. Valori assoluti e variazioni percentuali. Fonte: ns. elaborazione dati USTAT-Miur.
|
Anno |
Mega |
Grandi |
Medie |
Piccole |
Politecnici |
Scuole Superiori |
Totale università Statali |
|
2015 |
16438 |
14943 |
6371 |
1516 |
586 |
246 |
40100 |
|
2016 |
22310 |
15988 |
7623 |
1456 |
742 |
164 |
48283 |
|
2017 |
21298 |
15096 |
7511 |
1575 |
1072 |
346 |
46898 |
|
2018 |
24111 |
16295 |
7817 |
1610 |
1003 |
372 |
51208 |
|
2019 |
25575 |
17771 |
8380 |
1626 |
1028 |
319 |
54699 |
|
Variaz. % 2015-2019 |
+55,58% |
+18,93% |
+31,53% |
+7,26% |
+75,43% |
+29,67% |
+36,41% |
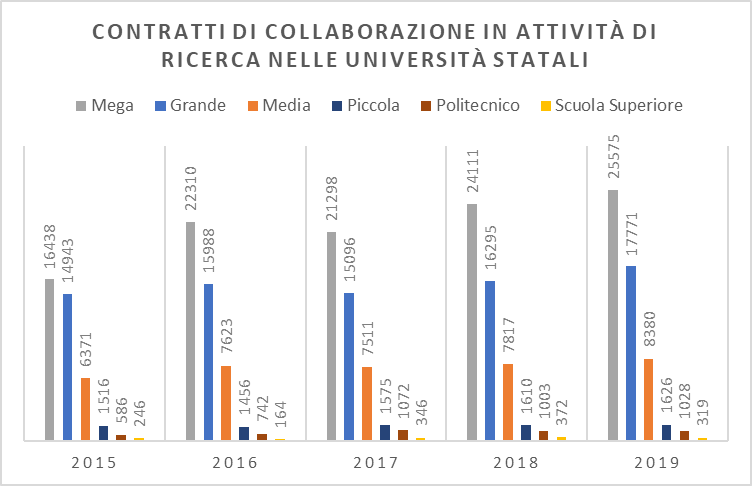
Figura 137 . UNIVERSITÀ STATALI. Contratti di collaborazione in attività di ricerca per grandezza e tipologia degli atenei. Anni 2015-2019. Valori assoluti. Fonte: ns. elaborazione dati USTAT-Miur.
Esaminiamo i dati delle università non statali articolate per grandezza e tipologia. Partiamo dai valori assoluti e dalle variazioni percentuali dal 2015 al 2019.
Tabella 234 . UNIVERSITÀ NON STATALI. Contratti di collaborazione in attività in attività di ricerca per grandezza e tipologia degli atenei. Anni 2015-2019. Valori assoluti e variazioni percentuali. Fonte: ns. elaborazione dati USTAT-Miur.
|
Anno |
Non statali Grandi |
Non statali Medie |
Non statali Piccole |
Telematiche |
Totale università non statali |
|
2015 |
1487 |
139 |
630 |
18 |
2274 |
|
2016 |
2404 |
416 |
849 |
42 |
3711 |
|
2017 |
2414 |
411 |
851 |
21 |
3697 |
|
2018 |
2422 |
329 |
1039 |
34 |
3824 |
|
2019 |
2363 |
418 |
1247 |
178 |
4206 |
|
Variaz. % 2015-2019 |
+58,91% |
+200,72% |
+97,94% |
+888,89% |
+84,96% |
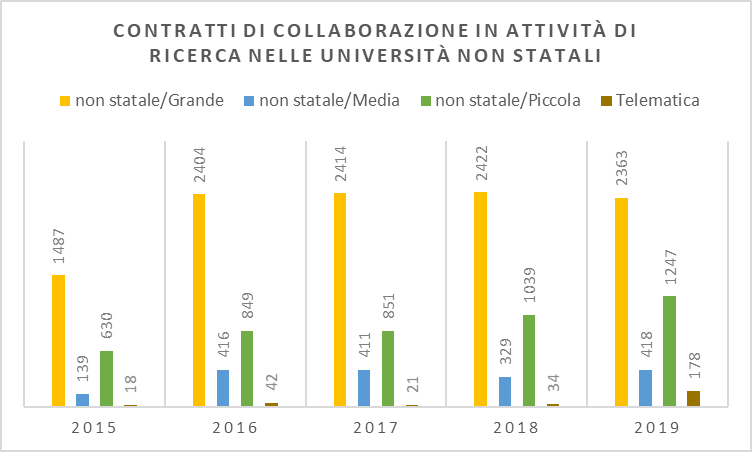
Figura 138 . UNIVERSITÀ NON STATALI Contratti di collaborazione in attività di ricerca per grandezza e tipologia degli atenei. Anni 2015-2019. Valori assoluti. Fonte: ns. elaborazione dati USTAT-Miur.
I docenti a contratto hanno contratti di diritto privato della durata di un anno accademico, rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso. L’art. 23 della legge 240/2010 distingue fra contratti stipulati al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale; contratti a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama; e contratti a titolo oneroso per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.
Solo questi ultimi vengono selezionati a seguito di un bando pubblico con procedure disciplinate dai regolamenti di ateneo, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. A loro può essere affidata l’intera responsabilità di insegnamenti ufficiali vacanti, per i quali non sussistano le condizioni per attribuire supplenze o affidamenti, ovvero quella d’insegnamenti per corsi di alta formazione post-laurea (master), oppure moduli o parti di insegnamenti ufficiali o cicli di lezioni e di seminari. In questi ultimi due casi essi non rimediano a una carenza d’organico ma integrano l’offerta didattica con apporti di particolari specializzazioni o competenze di alta qualificazione scientifica e/o professionale.
Abbiamo preso in esame gli anni accademici dal 2014/2015 al 2018/2019, quelli cioè per i quali il MIUR mette a disposizione i dati relativi ai docenti a contratto.
Nelle università italiane abbiamo circa un docente a contratto ogni due docenti/ricercatori, conteggiando fra essi anche i ricercatori a tempo indeterminato. [87] Nella seguente tabella, oltre al rapporto tra docenti/ricercatori e docenti a contratto, abbiamo calcolato l’incidenza percentuale dei docenti a contratto sul “totale della docenza”, ovvero sulla somma di docenti/ricercatori e contrattisti. Il rapporto fra docenti a tempo indeterminato o a tempo determinato e docenti a contratto sale ininterrottamente per tutto il periodo preso in esame. Analogamente cresce la percentuale di docenti a contratto sul totale della docenza che, per il periodo preso in esame, registra una media del 34,25%.
Tabella 235 . Rapporto fra docenti a contratto e docenti/ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato. Anni accademici 2014/2015-2018/2019. Valori assoluti, variazioni percentuali e percentuali di contrattisti sul totale della docenza (docenti/ricercatori + docenti a contratto). Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca e USTAT-Miur.
|
Docenti/ricercatori |
Docenti a contratto |
Docenti/ricercatori per docenti a contratto |
% contrattisti sul totale della docenza |
|
|
2014/2015 |
55606 |
28107 |
1,98 |
33,58% |
|
2015/2016 |
54766 |
27360 |
2,00 |
33,31% |
|
2016/2017 |
54548 |
28237 |
1,93 |
34,11% |
|
2017/2018 |
54152 |
28973 |
1,87 |
34,85% |
|
2018/2019 |
54675 |
29956 |
1,83 |
35,40% |
|
Variaz. % 2014-2018 |
-1,67% |
+6,58% |
-7,74% |
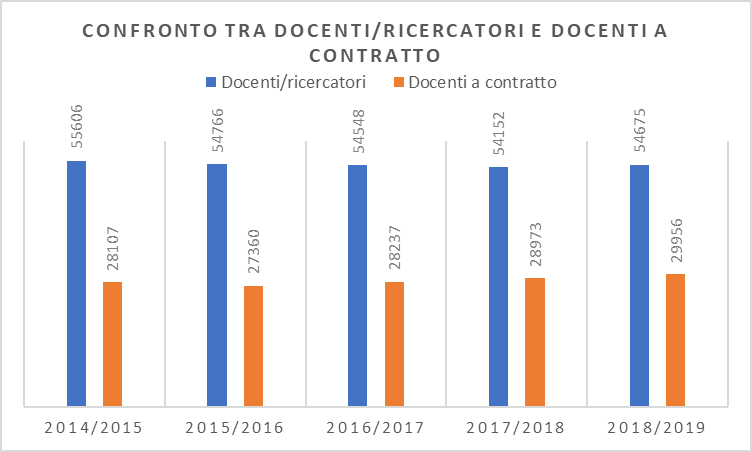
Figura 139 . Confronto tra docenti a contratto e docenti/ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato. Anni accademici 2014/2015-2018/2019. Valori assoluti. Fonte: ns. elaborazione dati USTAT-Miur.
Passiamo ora al confronto fra il numero degli iscritti e quello dei docenti/ricercatori e dei docenti a contratto, implementando la già presentata Tabella 8 . Nella seguente elaborazione, dal novero dei docenti sono stati sottratti quelli delle Scuole Superiori. Gli iscritti a questa tipologia di atenei non sono infatti compresi nei dati forniti dal Miur sugli iscritti. [88]
Tabella 236 . Rapporto fra iscritti, docenti a contratto e docenti/ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato. Anni accademici 2014/2015-2018/2019. Valori assoluti, variazioni percentuali, rapporti tra iscritti e totale della docenza e iscritti e docenti/ricercatori. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca e USTAT-Miur.
|
Anno Accademico |
Iscritti |
Docenti/ricercatori |
Docenti a contratto |
Iscritti per docente |
Iscritti per Docente/ricercatore |
|
2014/2015 |
1663325 |
55287 |
27801 |
20,02 |
30,09 |
|
2015/2016 |
1648374 |
54451 |
27122 |
20,21 |
30,27 |
|
2016/2017 |
1665549 |
54215 |
27978 |
20,26 |
30,72 |
|
2017/2018 |
1692568 |
53801 |
28781 |
20,50 |
31,46 |
|
2018/2019 |
1720674 |
54293 |
29767 |
20,47 |
31,69 |
|
Variaz. % 2014-2018 |
+3,45% |
-1,80% |
+7,07% |
+2,25% |
+5,34% |
Nel periodo preso in esame, nelle università italiane abbiamo una crescita di iscritti (+3,45%), un calo dei docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato (-1,8%) e una crescita di docenti a contratto (+7,07%). Il numero medio di iscritti per docente è 20,29; tuttavia, se scorporiamo i docenti a contratto, la media diventa di 30,85 iscritti per docente.
Esaminiamo ora la composizione di genere dei docenti a contratto.
Tabella 237 . Numerosità dei docenti a contratto per genere. Anni accademici 2014/2015-2018/2019. Valori assoluti e variazioni percentuali. Fonte: ns. elaborazione dati USTAT-Miur.
|
Anno Accademico |
Donne |
Uomini |
Totale |
|
2014/2015 |
11127 |
16980 |
28107 |
|
2015/2016 |
10565 |
16795 |
27360 |
|
2016/2017 |
10940 |
17297 |
28237 |
|
2017/2018 |
11199 |
17774 |
28973 |
|
2018/2019 |
11694 |
18262 |
29956 |
|
Variaz. % 2014-2018 |
+5,10% |
+7,55% |
+6,58% |
Figura 140 . Docenti a contratto per genere. Anni accademici 2014/2015-2018/2019. Valori assoluti. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca e USTAT-Miur.
Anche per i docenti a contratto è evidente uno squilibrio di genere, sebbene meno marcato di quello che riscontriamo nei totali riguardanti i docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato. Con movimento inverso a questi ultimi, esso sembra tuttavia in via di accentuazione.
Tabella 238 . Docenti a contratto e docenti/ricercatori per genere. Anni accademici 2014/2015-2018/2019. Valori percentuali sui totali delle due tipologie. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca e USTAT-Miur.
|
Anno Accademico |
% donne docenti a contratto |
% uomini docenti a contratto |
% donne docenti/ricercatori |
% uomini docenti/ricercatori |
|
2014/2015 |
39,59% |
60,41% |
36,68% |
63,32% |
|
2015/2016 |
38,61% |
61,39% |
36,85% |
63,15% |
|
2016/2017 |
38,74% |
61,26% |
37,09% |
62,91% |
|
2017/2018 |
38,65% |
61,35% |
37,41% |
62,59% |
|
2018/2019 |
39,04% |
60,96% |
37,82% |
62,18% |
|
Variaz. punti perc. |
-0,55 |
+0,55 |
+1,14 |
-1,14 |
Esaminiamo ora, come di consueto, la distribuzione dei docenti a contratto nelle diverse aree del Paese.
Tabella 239 . Numerosità dei docenti a contratto per area geografica. Anni accademici 2014/2015-2018/2019. Valori assoluti, variazioni percentuali e distribuzioni percentuali sul totale nazionale. Fonte: ns. elaborazione dati USTAT-Miur.
|
Anno accademico |
Nord-Est |
Nord-Ovest |
Centro |
Sud |
Isole |
Totale |
|
2014/2015 |
6037 |
9224 |
7586 |
3925 |
1335 |
28107 |
|
2015/2016 |
4865 |
9697 |
7763 |
3603 |
1432 |
27360 |
|
2016/2017 |
5358 |
9575 |
8072 |
3737 |
1495 |
28237 |
|
2017/2018 |
5383 |
9926 |
8472 |
3755 |
1437 |
28973 |
|
2018/2019 |
5552 |
9961 |
8911 |
4155 |
1377 |
29956 |
|
Variaz. % 2014-2018 |
-8,03% |
+7,99% |
+17,47% |
+5,86% |
+3,15% |
+6,58% |
|
21,48% |
32,82% |
26,99% |
13,96% |
4,75% |
100% |
|
|
2018/2019 (% sul tot) |
18,53% |
33,25% |
29,75% |
13,87% |
4,60% |
100% |
Notiamo una crescita del numero dei docenti a contratto quasi generalizzata, sebbene di entità differenti. Il Nord Est fa eccezione a questa tendenza. Quest’area, infatti, passa dall’impiegare il 21,48% dei docenti a contratto nel 2014/2015, a un’incidenza del 18,53% nel 2018/2019. Negli stessi anni la percentuale di docenti a contratto sul totale nazionale aumenta nel Nord Ovest e nel Centro. Pressoché invariate restano invece le percentuali di docenti a contratto nel Sud e nelle Isole sul totale nazionale.
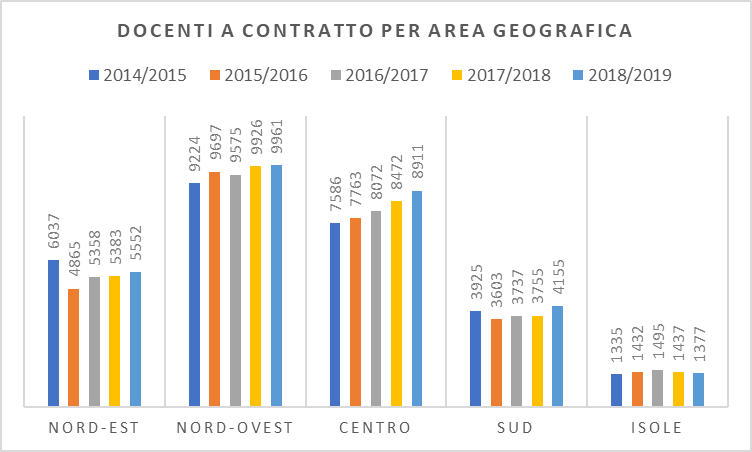
Figura 141 . Numerosità dei docenti a contratto per area geografica. Anni accademici 2014/2015-2018/2019. Valori assoluti. Fonte: ns. elaborazione dati USTAT-Miur.
Nella tabella seguente i valori assoluti e le variazioni percentuali dei docenti/ricercatori a tempo determinato e indeterminato e dei docenti a contratto. Abbiamo considerato la numerosità dei docenti/ricercatori nel segmento temporale 2014-2018.
Tabella 240 . Docenti a contratto e docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato per area geografica. Anni accademici 2014/2015-2018/2019. Valori assoluti e variazioni percentuali. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca e USTAT-Miur.
|
NORD |
CENTRO |
SUD e ISOLE |
||||
|
Anno Accademico |
Docenti/ricercatori |
Docenti a contratto |
Docenti/ricercatori |
Docenti a contratto |
Docenti/ricercatori |
Docenti a contratto |
|
2014/2015 |
23941 |
15261 |
14267 |
7586 |
17398 |
5260 |
|
2015/2016 |
23686 |
14562 |
13977 |
7763 |
17103 |
5035 |
|
2016/2017 |
23678 |
14933 |
13913 |
8072 |
16957 |
5232 |
|
2017/2018 |
23698 |
15309 |
13757 |
8472 |
16697 |
5192 |
|
2018/2019 |
24226 |
15513 |
13746 |
8911 |
16703 |
5532 |
|
Variaz. % 2014-2018 |
+1,19% |
+1,65% |
-3,65% |
+17,47% |
-3,99% |
+5,17% |
Mentre al Centro a una decrescita del 3,65% dei docenti/ricercatori corrisponde una crescita del 17,47% dei docenti a contratto, nel Nord le due categorie di docenti sono entrambe in crescita (+1,19% la prima e +1,65% la seconda). Nel Sud e nelle Isole i docenti/ricercatori decrescono del 3,99% e i docenti a contratto crescono del 5,17%.
Nella tabella seguente, l’incidenza percentuale dei docenti/ricercatori e dei docenti a contratto sui rispettivi totali nazionali per area geografica.
Tabella 241 . Docenti a contratto e docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato per area geografica. Anni accademici 2014/2015-2018/2019. Valori percentuali sui totali nazionali delle due tipologie. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca e USTAT-Miur.
|
NORD |
CENTRO |
SUD e ISOLE |
||||
|
Anno Accademico |
Docenti/ricercatori su totale nazionale |
Docenti a contratto su totale nazionale |
Docenti/ricercatori su totale nazionale |
Docenti a contratto su totale nazionale |
Docenti/ricercatori su totale nazionale |
Docenti a contratto su totale nazionale |
|
2014/2015 |
43,05% |
54,30% |
25,66% |
26,99% |
31,29% |
18,71% |
|
2015/2016 |
43,25% |
53,22% |
25,52% |
28,37% |
31,23% |
18,40% |
|
2016/2017 |
43,41% |
52,88% |
25,51% |
28,59% |
31,09% |
18,53% |
|
2017/2018 |
43,76% |
52,84% |
25,40% |
29,24% |
30,83% |
17,92% |
|
2018/2019 |
44,31% |
51,79% |
25,14% |
29,75% |
30,55% |
18,47% |
|
Variaz. punti percentuali |
+1,26 |
-2,51 |
-0,52 |
+2,76 |
-0,74 |
-0,24 |
Nel periodo preso in esame, nel Nord la quota percentuale dei docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato sul loro totale nazionale aumenta, mentre la quota percentuale dei docenti a contratto diminuisce, rimanendo comunque sensibilmente più alta della percentuale dei docenti/ricercatori.
Nel Centro, le percentuali di docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato e di docenti a contratto sono abbastanza equiparabili, la prima lievemente in discesa, la seconda in salita piuttosto rilevante.
Nel Sud e nelle Isole le due percentuali scendono, la seconda rimanendo comunque inferiore alla prima.
Nel grafico seguente visualizziamo l’incidenza percentuale dei docenti a contratto sul totale della docenza considerato, come in precedenza, come la somma di docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato e docenti a contratto. Esaminando la percentuale dei docenti a contratto sul totale della docenza notiamo che il Nord mantiene costantemente l’incidenza più alta. Al Centro si passa da un 34,71% di contrattisti sul totale della docenza dell’anno accademico 2014/2015 al 39,33% del 2018/2019. Al Sud e nelle Isole si passa dal 23,21% al 24,88%. La percentuale media di contrattisti sul totale della docenza, nel periodo preso in esame, è del 38,79% al Nord, del 36,92% al Centro e del 23,63% al Sud e nelle Isole. La percentuale media nazionale è del 34,25%.
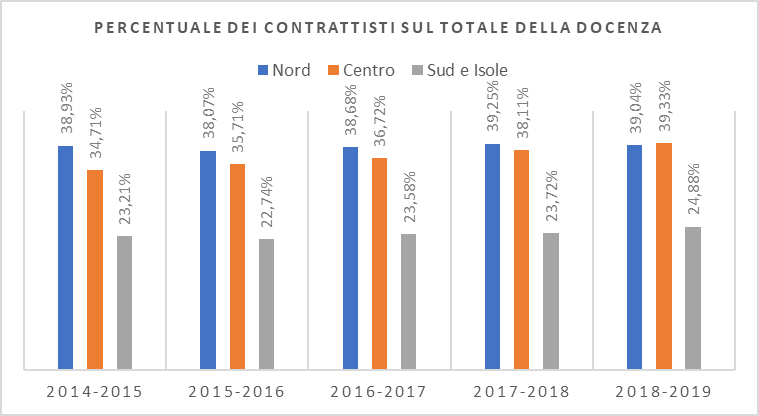
Figura 142 . Percentuale dei docenti a contratto sul totale della docenza (docenti/ricercatori + docenti a contratto) nell’area geografica. Anni accademici 2014/2015-2018/2019. Valori percentuali. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca e USTAT-Miur.
Approfondiamo ora, come di consueto, la situazione dei docenti a contratto in ciascuna delle tre macro-aree del Paese.
Cominciamo con l’esaminare la situazione del Nord confrontando il numero dei docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato con quello dei docenti a contratto e calcolando l’incidenza dei docenti a contratto sul totale della docenza dell’area geografica, considerato, come di consueto, come la somma di docenti/ricercatori e di docenti a contratto dell’area.
Tabella 242 . NORD. Rapporto fra docenti a contratto e docenti/ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato. Anni accademici 2014/2015-2018/2019. Valori assoluti e percentuali sul totale della docenza nell’area. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca e USTAT-Miur.
|
Anno Accademico |
Docenti/ricercatori |
Docenti a contratto |
Docenti/ricercatori per contrattista |
% contrattisti sul totale della docenza nell’area |
|
2014/2015 |
23941 |
15261 |
1,57 |
38,93% |
|
2015/2016 |
23686 |
14562 |
1,63 |
38,07% |
|
2016/2017 |
23678 |
14933 |
1,59 |
38,68% |
|
2017/2018 |
23698 |
15309 |
1,55 |
39,25% |
|
2018/2019 |
24226 |
15513 |
1,56 |
39,04% |
|
Variaz. % 2014-2018 |
+1,19% |
+1,65% |
-0,45% |
Rispetto alla Tabella 235 , possiamo notare nel Nord una maggiore incidenza della docenza a contratto rispetto alle medie nazionali. Nel periodo in esame, i docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato crescono meno di quelli a contratto e la percentuale media di docenti a contratto sul totale della docenza risulta del 38,79%, rispetto al 34,25% registrato a livello nazionale.
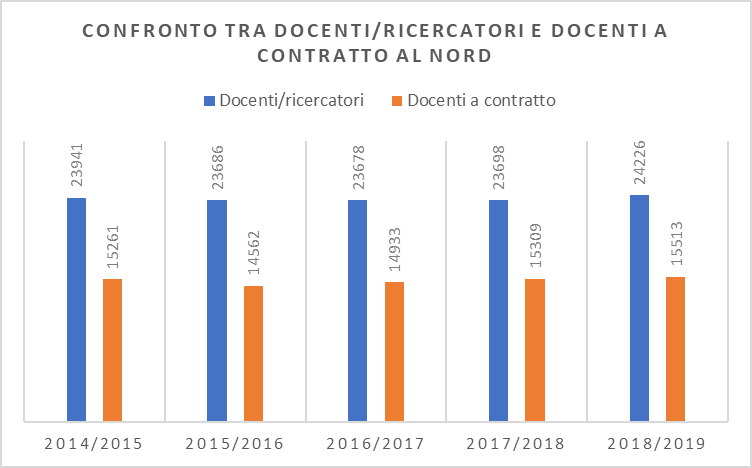
Figura 143 . NORD. Docenti a contratto e docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato. Anni accademici 2014/2015-2018/2019. Valori assoluti. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca e USTAT-Miur.
Confrontiamo ora il numero degli iscritti nelle università del Nord con quello del totale della docenza – calcolato dalla somma dei docenti/ricercatori e dei docenti a contratto – e poi con il numero dei soli docenti/ricercatori. Dal numero dei docenti sono stati sottratti, come di consueto, quelli delle Scuole Superiori ad ordinamento speciale (Pavia IUSS e Trieste SISSA).
Tabella 243 . NORD. Rapporto fra iscritti, docenti a contratto e docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato. Anni accademici 2014/2015-2018/2019. Valori assoluti, variazioni percentuali e rapporti tra iscritti e totale della docenza e iscritti e docenti/ricercatori. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca e USTAT-Miur.
|
Anno Accademico |
Iscritti |
Docenti/ricercatori |
Docenti a contratto |
Totale docenza |
Iscritti per docente |
Iscritti per docente/ricercatore |
|
2014/2015 |
686493 |
23856 |
15121 |
38977 |
17,61 |
28,78 |
|
2015/2016 |
691035 |
23597 |
14449 |
38046 |
18,16 |
29,28 |
|
2016/2017 |
703803 |
23575 |
14848 |
38423 |
18,32 |
29,85 |
|
2017/2018 |
726674 |
23598 |
15243 |
38841 |
18,71 |
30,79 |
|
2018/2019 |
742271 |
24124 |
15455 |
39579 |
18,75 |
30,77 |
|
Variaz.% 2014-2018 |
+8,13% |
+1,12% |
+2,21% |
+1,54% |
+6,48% |
+6,92% |
Nel periodo preso in esame, nelle università del Nord abbiamo una crescita di iscritti (+8,13%), una crescita dei docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato (+1,12%) e una crescita di docenti a contratto (+2,21%). Il numero medio di iscritti per docente è 18,31 (media nazionale 20,29 iscritti per docente) ma, se scorporiamo i docenti a contratto, la media diventa 29,9 (media nazionale 30,85 iscritti per docente/ricercatore).
Esaminiamo la situazione del Nord regione per regione. Come di consueto, la situazione presenta rilevanti differenze al suo interno. Le differenze sono legate, oltre che alle differenti caratteristiche dei territori, anche alle diverse dimensioni e composizioni dei sistemi regionali (numero, grandezza e tipologia degli atenei, presenza di università non statali e telematiche). Partiamo dai valori assoluti e dalle variazioni percentuali dal 2014/2015 al 2018/2019.
Tabella 244 . NORD. Numerosità dei docenti a contratto per regione. Anni accademici 2014/2015-2018/2019. Valori assoluti e variazioni percentuali. Fonte: ns. elaborazione dati USTAT-Miur.
|
Anno |
Valle d’Aosta |
Piemonte |
Liguria |
Emilia Romagna |
Lombardia |
Veneto |
Friuli |
Trentino Alto Adige |
Totale |
|
2014/2015 |
48 |
1105 |
780 |
1902 |
7291 |
2859 |
726 |
550 |
15261 |
|
2015/2016 |
51 |
1095 |
663 |
1713 |
7888 |
1991 |
641 |
520 |
14562 |
|
2016/2017 |
70 |
1097 |
768 |
1685 |
7640 |
2542 |
614 |
517 |
14933 |
|
2017/2018 |
60 |
1038 |
803 |
1802 |
8025 |
2442 |
659 |
480 |
15309 |
|
2018/2019 |
74 |
1055 |
808 |
1820 |
8024 |
2569 |
729 |
434 |
15513 |
|
Variaz. % 2014-2018 |
+54,17% |
-4,52% |
+3,59% |
-4,31% |
+10,05% |
-10,14% |
+0,41% |
-21,09% |
+1,65% |
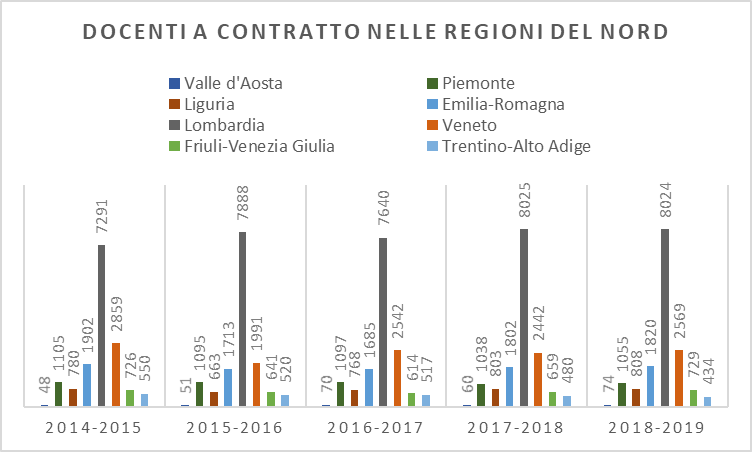
Figura 144 . NORD. Numerosità dei docenti a contratto per regione. Anni accademici 2014/2015-2018/2019. Valori assoluti. Fonte: ns. elaborazione dati USTAT-Miur.
Come si evince dal grafico seguente, nel Nord Est, nel periodo preso in esame, i docenti a contratto rappresentano una percentuale media sul totale della docenza (considerata come di consueto come la somma di docenti/ricercatori e docenti a contratto) che va dal 41,33% del Veneto, al 38,03% del Trentino Alto Adige, al 32,63% del Friuli Venezia Giulia, al 26,11% dell’Emilia Romagna (media nazionale 34,39%, media dell’area 38,79% ).
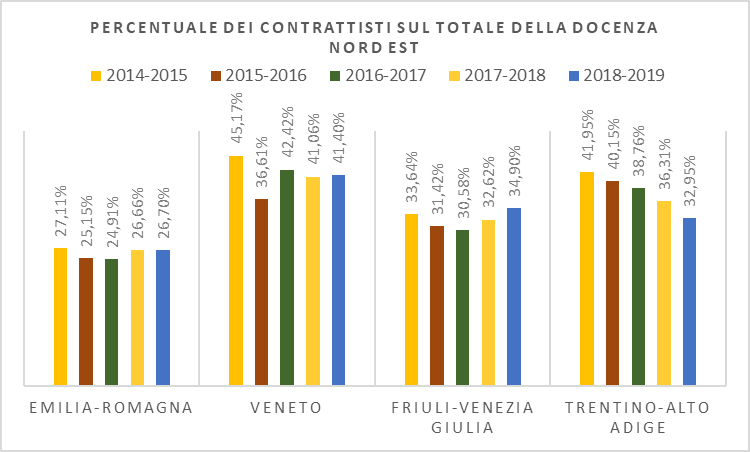
Figura 145 . NORD EST. Percentuale contrattisti sul totale della docenza (docenti/ricercatori + docenti a contratto) nell’area geografica. Anni accademici 2014/2015-2018/2019. Valori percentuali. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca e USTAT-Miur.
Nel Nord Ovest, nel periodo preso in esame, i docenti a contratto rappresentano una percentuale sul totale della docenza (considerata come la somma di docenti/ricercatori e docenti a contratto) che va in media dal 53,46% della Valle d’Aosta, al 47,57% della Lombardia, al 32,55% della Liguria, al 25,16% del Piemonte (media nazionale 34,39%, media dell’area 38,79% ).
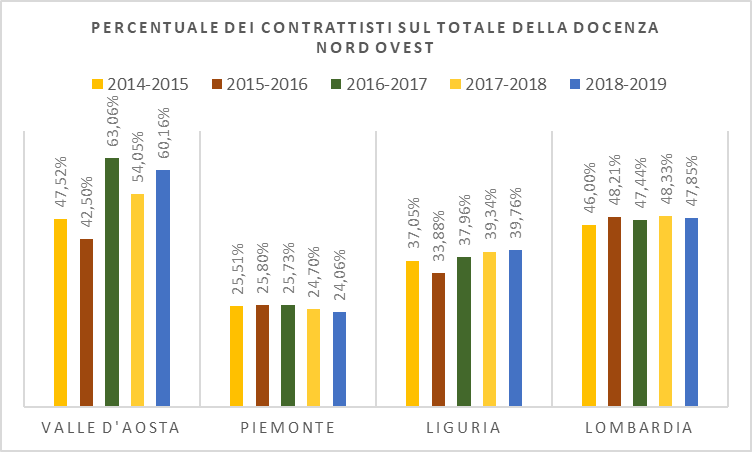
Figura 146 . NORD OVEST. Percentuale contrattisti sul totale della docenza (docenti/ricercatori + docenti a contratto) nell’area geografica. Anni accademici 2014/2015-2018/2019. Valori percentuali. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca e USTAT-Miur.
Confrontiamo ora il numero degli iscritti nelle università delle diverse regioni del Nord con quello del totale della docenza – calcolato dalla somma dei docenti/ricercatori e dei docenti a contratto – e poi con il numero dei soli docenti/ricercatori. Dal numero dei docenti della Lombardia sono stati sottratti quelli dell’Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia (IUSS) e dal numero di docenti del Friuli quelli dei docenti della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste (SISSA).
Poiché è impossibile concentrare tutti i dati in una sola tabella, presenteremo una tabella per ogni regione. Cominciamo con il Nord Est.
Tabella 245 . EMILIA ROMAGNA. Rapporto fra iscritti, docenti a contratto e docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato. Anni accademici 2014/2015-2018/2019. Valori assoluti e variazioni percentuali. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca e USTAT-Miur.
|
Anno Accademico |
Iscritti |
Docenti/ricercatori |
Docenti a contratto |
Iscritti per docente |
Iscritti per docente/ricercatore |
|
2014/2015 |
135436 |
5113 |
1902 |
19,31 |
26,49 |
|
2015/2016 |
137010 |
5097 |
1713 |
20,12 |
26,88 |
|
2016/2017 |
139964 |
5079 |
1685 |
20,69 |
27,56 |
|
2017/2018 |
146298 |
4958 |
1802 |
21,64 |
29,51 |
|
2018/2019 |
150971 |
4997 |
1820 |
22,15 |
30,21 |
|
Variaz.% 2014-2018 |
+11,47% |
-2,27% |
-4,31% |
+14,71% |
+14,06% |
Tabella 246 . FRIULI VENEZIA GIULIA. Rapporto fra iscritti, docenti a contratto e docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato [89] . Anni accademici 2014/2015-2018/2019. Valori assoluti e variazioni percentuali. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca e USTAT-Miur.
|
Anno Accademico |
Iscritti |
Docenti/ricercatori |
Docenti a contratto |
Iscritti per docente |
Iscritti per docente/ricercatore |
|
2014/2015 |
30426 |
1366 |
686 |
14,83 |
22,27 |
|
2015/2016 |
29851 |
1329 |
607 |
15,42 |
22,46 |
|
2016/2017 |
29796 |
1312 |
585 |
15,71 |
22,71 |
|
2017/2018 |
29989 |
1282 |
628 |
15,70 |
23,39 |
|
2018/2019 |
30134 |
1278 |
699 |
15,24 |
23,58 |
|
Variaz.% 2014-2018 |
-0,96% |
-6,44% |
+1,90% |
+2,80% |
+5,86% |
Tabella 247 . TRENTINO ALTO ADIGE. Rapporto fra iscritti, docenti a contratto e docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato. Anni accademici 2014/2015-2018/2019. Valori assoluti e variazioni percentuali. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca e USTAT-Miur.
|
Anno Accademico |
Iscritti |
Docenti/ricercatori |
Docenti a contratto |
Iscritti per docente |
Iscritti per docente/ricercatore |
|
2014/2015 |
19254 |
761 |
550 |
14,69 |
25,30 |
|
2015/2016 |
19210 |
775 |
520 |
14,83 |
24,79 |
|
2016/2017 |
19407 |
817 |
517 |
14,55 |
23,75 |
|
2017/2018 |
19893 |
842 |
480 |
15,05 |
23,63 |
|
2018/2019 |
20254 |
883 |
434 |
15,38 |
22,94 |
|
Variaz.% 2014-2018 |
+5,19% |
+16,03% |
-21,09% |
+4,71% |
-9,34% |
Tabella 248 . VENETO. Rapporto fra iscritti, docenti a contratto e docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato. Anni accademici 2014/2015-2018/2019. Valori assoluti e variazioni percentuali. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca e USTAT-Miur.
|
Anno Accademico |
Iscritti |
Docenti/ricercatori |
Docenti a contratto |
Iscritti per docente |
Iscritti per docente/ricercatore |
|
2014/2015 |
104049 |
3471 |
2859 |
16,44 |
29,98 |
|
2015/2016 |
105095 |
3447 |
1991 |
19,33 |
30,49 |
|
2016/2017 |
104800 |
3451 |
2542 |
17,49 |
30,37 |
|
2017/2018 |
105641 |
3506 |
2442 |
17,76 |
30,13 |
|
2018/2019 |
106056 |
3637 |
2569 |
17,09 |
29,16 |
|
Variaz.% 2014-2018 |
+1,93% |
+4,78% |
-10,14% |
+3,97% |
-2,72% |
Nel periodo preso in esame, nelle università del Nord Est abbiamo situazioni piuttosto differenziate. Abbiamo una crescita di iscritti in Emilia Romagna (+11,47%), Trentino Alto Adige (+5,19%), e in Veneto (+1,93%). In Friuli Venezia Giulia abbiamo una lieve decrescita di iscritti (-0,96%). Abbiamo una crescita dei docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato in Trentino Alto Adige (+16,03%) e in Veneto (+4,78%). I docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato diminuiscono invece in Friuli Venezia Giulia (-6,44%) e in Emilia Romagna (-2,27%). Infine, abbiamo una crescita di docenti a contratto in Friuli Venezia Giulia (+1,9%) e una decrescita in Trentino Alto Adige (-21,09%), in Veneto (-10,14%) e in Emilia Romagna (-4,31%).
Il numero medio di iscritti per docente è 20,78 in Emilia Romagna, 17,62 in Veneto, 15,38 in Friuli Venezia Giulia, 14,9 in Trentino Alto Adige (media del Nord 18,31; media del Nord Est 17,17; media nazionale 20,29) ma, se scorporiamo i docenti a contratto, le medie diventano 30,03 in Veneto, 28,13 in Emilia Romagna, 24,08 in Trentino Alto Adige, 22,88 in Friuli Venezia Giulia (media del Nord, 29,9; media del Nord Est 26,28; media nazionale 30,85).
Veniamo ora alle regioni del Nord Ovest.
Tabella 249 . VALLE D’AOSTA Rapporto fra iscritti, docenti a contratto e docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato. Anni accademici 2014/2015-2018/2019. Valori assoluti e variazioni percentuali. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca e USTAT-Miur.
|
Anno Accademico |
Iscritti |
Docenti/ricercatori |
Docenti a contratto |
Iscritti per docente |
Iscritti per docente/ricercatore |
|
2014/2015 |
1152 |
55 |
48 |
11,18 |
20,95 |
|
2015/2016 |
1118 |
50 |
51 |
11,07 |
22,36 |
|
2016/2017 |
1059 |
50 |
70 |
8,83 |
21,18 |
|
2017/2018 |
1052 |
51 |
60 |
9,48 |
20,63 |
|
2018/2019 |
1026 |
49 |
74 |
8,34 |
20,94 |
|
Variaz.% 2014-2018 |
-10,94% |
-10,91% |
+54,17% |
-25,42% |
-0,03% |
Tabella 250 . PIEMONTE. Rapporto fra iscritti, docenti a contratto e docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato. Anni accademici 2014/2015-2018/2019. Valori assoluti e variazioni percentuali. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca e USTAT-Miur.
|
Anno Accademico |
Iscritti |
Docenti/ricercatori |
Docenti a contratto |
Iscritti per docente |
Iscritti per docente/ricercatore |
|
2014/2015 |
106209 |
3226 |
1105 |
24,52 |
32,92 |
|
2015/2016 |
107791 |
3149 |
1095 |
25,40 |
34,23 |
|
2016/2017 |
111366 |
3166 |
1097 |
26,12 |
35,18 |
|
2017/2018 |
115808 |
3164 |
1038 |
27,56 |
36,60 |
|
2018/2019 |
118075 |
3330 |
1055 |
26,93 |
35,46 |
|
Variaz. % 2014-2018 |
+11,17% |
+3,22% |
-4,52% |
+9,80% |
+7,70% |
Tabella 251 . LIGURIA. Rapporto fra iscritti, docenti a contratto e docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato. Anni accademici 2014/2015-2018/2019. Valori assoluti e variazioni percentuali. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca e USTAT-Miur.
|
Anno Accademico |
Iscritti |
Docenti/ricercatori |
Docenti a contratto |
Iscritti per docente |
Iscritti per docente/ricercatore |
|
2014/2015 |
32136 |
1325 |
780 |
15,27 |
24,25 |
|
2015/2016 |
31256 |
1294 |
663 |
15,97 |
24,15 |
|
2016/2017 |
31415 |
1255 |
768 |
15,53 |
25,03 |
|
2017/2018 |
31982 |
1238 |
803 |
15,67 |
25,83 |
|
2018/2019 |
30219 |
1224 |
808 |
14,87 |
24,69 |
|
Variaz. % 2014-2018 |
-5,97% |
-7,62% |
+3,59% |
-2,59% |
+1,79% |
Tabella 252 . LOMBARDIA. Rapporto fra iscritti, docenti a contratto e docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato [90] . Anni accademici 2014/2015-2018/2019. Valori assoluti e variazioni percentuali. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca e USTAT-Miur.
|
Anno Accademico |
Iscritti |
Docenti/ricercatori |
Docenti a contratto |
Iscritti per docente |
Iscritti per docente/ricercatore |
|
2014/2015 |
257831 |
8539 |
1325 |
26,14 |
30,19 |
|
2015/2016 |
259704 |
8456 |
1294 |
26,64 |
30,71 |
|
2016/2017 |
265996 |
8445 |
1255 |
27,42 |
31,50 |
|
2017/2018 |
276011 |
8557 |
1238 |
28,18 |
32,26 |
|
2018/2019 |
285536 |
8726 |
1224 |
28,70 |
32,72 |
|
Variaz. % 2014-2018 |
+10,75% |
+2,19% |
-7,62% |
+9,79% |
+8,37% |
Nel periodo preso in esame, nelle università del Nord Ovest abbiamo situazioni piuttosto differenziate. Abbiamo una crescita di iscritti in Piemonte (+11,17%) e Lombardia (+10,75%). Abbiamo invece una decrescita di iscritti in Liguria (-5,97%) e in Valle d’Aosta (-10,94%). Parallelamente abbiamo una crescita dei docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato in Piemonte (+3,22%) e in Lombardia (+2,19%). I docenti/ricercatori diminuiscono invece in Valle d’Aosta (-10,91%) e in Liguria (-7,62%). Infine, abbiamo una crescita di docenti a contratto in Valle d’Aosta (+54,17%) e in Liguria (+3,59%) e una decrescita Lombardia (-7,62%) e in Piemonte (-4,52%)
Il numero medio di iscritti per docente è 9,78 in Valle d’Aosta, 26,11 in Piemonte, 15,46 in Liguria, 27,41 in Lombardia (media del Nord 18,31; media del Nord Ovest 19,69; media nazionale 20,29) ma, se scorporiamo i docenti a contratto, le medie diventano 21,21 in Valle d’Aosta, 34,88 in Piemonte, 24,79 in Liguria, 31,48 in Lombardia (media del Nord, 29,9; media del Nord Ovest 28,09; media nazionale 30,85).
Passiamo ora ad approfondire la situazione del Centro confrontando il numero dei docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato con quello dei docenti a contratto.
Tabella 253 . CENTRO. Rapporto fra docenti a contratto e docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato. Anni accademici 2014/2015-2018/2019. Valori assoluti e percentuali. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca e USTAT-Miur.
|
Anno Accademico |
Docenti/ricercatori |
Docenti a contratto |
Docenti/ricercatori per contrattista |
% contrattisti sul totale della docenza nell’area |
|
2014/2015 |
14267 |
7586 |
1,88 |
34,71% |
|
2015/2016 |
13977 |
7763 |
1,80 |
35,71% |
|
2016/2017 |
13913 |
8072 |
1,72 |
36,72% |
|
2017/2018 |
13757 |
8472 |
1,62 |
38,11% |
|
2018/2019 |
13746 |
8911 |
1,54 |
39,33% |
|
Variaz. % 2014-2018 |
-3,65% |
+17,47% |
-17,98% |
Rispetto alla Tabella 235 , possiamo notare nel Centro una maggiore incidenza della docenza a contratto rispetto alle medie nazionali. Nel periodo in esame, i docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato decrescono, mentre crescono in maniera rilevante quelli a contratto. La percentuale media di docenti a contratto sul totale della docenza sale al 36,92%, rispetto al 34,25% registrato a livello nazionale.
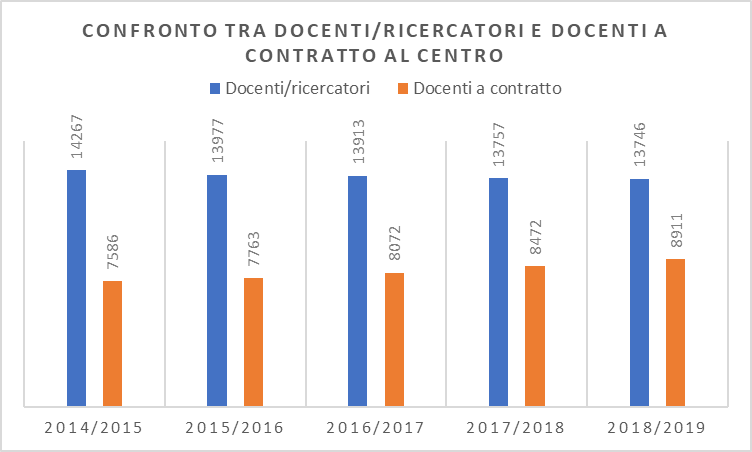
Figura 147 . CENTRO. Docenti a contratto e docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato. Anni accademici 2014/2015-2018/2019. Valori assoluti. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca e USTAT-Miur.
Confrontiamo ora il numero degli iscritti nelle università del Centro con quello del totale della docenza – calcolato dalla somma dei docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato e dei docenti a contratto – e poi con il numero dei soli docenti/ricercatori. Dal numero dei docenti sono stati sottratti, come di consueto, quelli delle Scuole Superiori ad Ordinamento Speciale (Scuola IMT Alti Studi di Lucca, Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant’Anna di Pisa e Scuola Normale Superiore di Pisa).
Tabella 254 . CENTRO. Rapporto fra iscritti, docenti a contratto e docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato. Anni accademici 2014/2015-2018/2019 Valori assoluti, variazioni percentuali e rapporti tra iscritti e totale della docenza e iscritti e docenti/ricercatori. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca e USTAT-Miur.
|
Anno Accademico |
Iscritti |
Docenti/ricercatori |
Docenti a contratto |
Totale docenza |
Iscritti per docente |
Iscritti per docente/ricercatore |
|
2014-2015 |
421986 |
14033 |
7586 |
21619 |
19,52 |
30,07 |
|
2015-2016 |
421827 |
13751 |
7763 |
21514 |
19,61 |
30,68 |
|
2016-2017 |
429581 |
13684 |
8072 |
21756 |
19,75 |
31,39 |
|
2017-2018 |
432892 |
13519 |
8472 |
21991 |
19,68 |
32,02 |
|
2018-2019 |
441936 |
13491 |
8911 |
22402 |
19,73 |
32,76 |
|
Variaz. % 2014-2018 |
+4,73% |
-3,86% |
+17,47% |
+1,07% |
+8,94% |
Nel periodo preso in esame, nelle università del Centro abbiamo una crescita di iscritti (+4,73%), una decrescita dei docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato (-3,86%) e una crescita di docenti a contratto (+17,47%). Il numero medio di iscritti per docente è 19,66 (media nazionale 20,29 iscritti per docente) ma, se scorporiamo i docenti a contratto, la media diventa 31,38 (media nazionale 30,85 iscritti per docente/ricercatore).
Esaminiamo la situazione del Centro regione per regione. Pure in questo caso all’interno dell’area registriamo rilevanti differenze relative, oltre che alle caratteristiche dei territori, alle diverse dimensioni e composizioni dei sistemi regionali (numero, grandezza e tipologia degli atenei, presenza di università non statali e telematiche). Partiamo dai valori assoluti e dalle variazioni percentuali dal 2014/2015 al 2018/2019.
Tabella 255 . CENTRO. Numerosità dei docenti a contratto per regione. Anni accademici 2014/2015-2018/2019. Valori assoluti e variazioni percentuali. Fonte: ns. elaborazione dati USTAT-Miur.
|
Anno |
Lazio |
Marche |
Toscana |
Umbria |
Totale |
|
2014/2015 |
4267 |
783 |
2347 |
189 |
7586 |
|
2015/2016 |
4334 |
810 |
2435 |
184 |
7763 |
|
2016/2017 |
4375 |
966 |
2516 |
215 |
8072 |
|
2017/2018 |
5061 |
883 |
2263 |
265 |
8472 |
|
2018/2019 |
5250 |
984 |
2373 |
304 |
8911 |
|
Variaz. % 2014-2018 |
+23,04% |
+25,67% |
+1,11% |
+60,85% |
+17,47% |
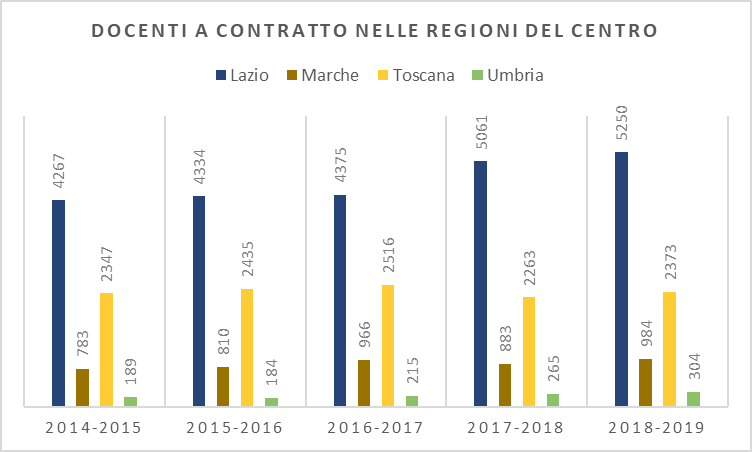
Figura 148 . CENTRO. Numerosità dei docenti a contratto per regione. Anni accademici 2014/2015-2018/2019. Valori assoluti. Fonte: ns. elaborazione dati USTAT-Miur.
Nelle regioni del Centro, nel periodo preso in esame, i docenti a contratto rappresentano una percentuale sul totale della docenza (considerata come di consueto come la somma di docenti/ricercatori e docenti a contratto) che va in media dal 39,16% del Lazio, al 38,30% delle Marche, al 36,43% della Toscana, al 16,98% dell’Umbria (media nazionale 34,39%; media dell’area 36,92%).
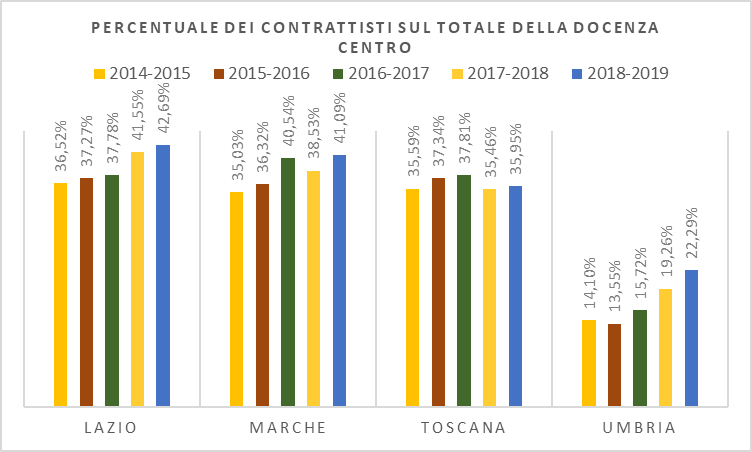
Figura 149 . CENTRO. Percentuale contrattisti sul totale della docenza (docenti/ricercatori + docenti a contratto) nell’area geografica. Anni accademici 2014/2015-2018/2019. Valori percentuali. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca e USTAT-Miur.
Confrontiamo ora il numero degli iscritti nelle università delle diverse regioni del Centro con quello del totale della docenza – calcolato dalla somma dei docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato e dei docenti a contratto – e poi con il numero dei soli docenti/ricercatori. Dal numero dei docenti della Toscana sono stati sottratti quelli delle Scuole Superiori ad Ordinamento Speciale (Scuola IMT Alti Studi di Lucca, Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant’Anna di Pisa e Scuola Normale Superiore di Pisa).
Poiché è impossibile concentrare tutti i dati in una sola tabella, presenteremo una tabella per ogni regione.
Tabella 256 . LAZIO. Rapporto fra iscritti, docenti a contratto e docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato. Anni accademici 2014/2015-2018/2019. Valori assoluti e variazioni percentuali. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca e USTAT-Miur.
|
Anno Accademico |
Iscritti |
Docenti/ricercatori |
Docenti a contratto |
Iscritti per docente |
Iscritti per docente/ricercatore |
|
2014/2015 |
239414 |
7417 |
4267 |
20,49 |
32,28 |
|
2015/2016 |
241269 |
7296 |
4334 |
20,75 |
33,07 |
|
2016/2017 |
245889 |
7204 |
4375 |
21,24 |
34,13 |
|
2017/2018 |
249015 |
7119 |
5061 |
20,44 |
34,98 |
|
2018/2019 |
257177 |
7047 |
5250 |
20,91 |
36,49 |
|
Variaz. % 2014-2018 |
+7,42% |
-4,99% |
+23,04% |
+2,06% |
+13,06% |
Tabella 257 . MARCHE. Rapporto fra iscritti, docenti a contratto e docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato. Anni accademici 2014/2015-2018/2019. Valori assoluti e variazioni percentuali. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca e USTAT-Miur.
|
Anno Accademico |
Iscritti |
Docenti/ricercatori |
Docenti a contratto |
Iscritti per docente |
Iscritti per Docenti/ricercatori |
|
2014/2015 |
45905 |
1452 |
783 |
20,54 |
31,62 |
|
2015/2016 |
45760 |
1420 |
810 |
20,52 |
32,23 |
|
2016/2017 |
46239 |
1417 |
966 |
19,40 |
32,63 |
|
2017/2018 |
46046 |
1409 |
883 |
20,09 |
32,68 |
|
2018/2019 |
46139 |
1411 |
984 |
19,26 |
32,70 |
|
Variaz. % 2014-2018 |
+0,51% |
-2,82% |
+25,67% |
-6,20% |
+3,43% |
Tabella 258 . TOSCANA. Rapporto fra iscritti, docenti a contratto e docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato [91] . Anni accademici 2014/2015-2018/2019. Valori assoluti e variazioni percentuali. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca e USTAT-Miur.
|
Anno Accademico |
Iscritti |
Docenti/ricercatori |
Docenti a contratto |
Iscritti per docente |
Iscritti per docenti/ricercatore |
|
2014/2015 |
113350 |
4013 |
2181 |
18,30 |
28,25 |
|
2015/2016 |
112385 |
3861 |
2310 |
18,21 |
29,11 |
|
2016/2017 |
113632 |
3910 |
2344 |
18,17 |
29,06 |
|
2017/2018 |
113911 |
3880 |
2139 |
18,93 |
29,36 |
|
2018/2019 |
114082 |
3973 |
2246 |
18,34 |
28,71 |
|
Variaz. % 2014-2018 |
+0,65% |
-1,00% |
+2,98% |
+0,24% |
+1,66% |
Tabella 259 . UMBRIA. Rapporto fra iscritti, docenti a contratto e docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato. Anni accademici 2014/2015-2018/2019. Valori assoluti e variazioni percentuali. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca e USTAT-Miur.
|
Anno Accademico |
Iscritti |
Docenti/ricercatori |
Docenti a contratto |
Iscritti per docente |
Iscritti per docente/ricercatore |
|
2014/2015 |
23317 |
1151 |
189 |
17,40 |
20,26 |
|
2015/2016 |
22413 |
1174 |
184 |
16,50 |
19,09 |
|
2016/2017 |
23821 |
1153 |
215 |
17,41 |
20,66 |
|
2017/2018 |
23920 |
1111 |
265 |
17,38 |
21,53 |
|
2018/2019 |
24538 |
1060 |
304 |
17,99 |
23,15 |
|
Variaz. % 2014-2018 |
+5,24% |
-7,91% |
+60,85% |
+3,38% |
+14,27% |
Nel periodo preso in esame, nelle università del Centro abbiamo situazioni piuttosto differenziate. Abbiamo dovunque una crescita di iscritti, sebbene di diversa entità (Lazio +7,42%; Umbria +5,24%; Toscana +0,65%; Marche +0,51%). Di converso abbiamo una decrescita dei docenti/ricercatori in tutte le regioni, anche qui con rilevanti differenze fra regione e regione (Umbria -7,91%; Lazio -4,99%; Marche -2,82%; Toscana -1%). Infine, anche i docenti a contratto aumentano ovunque, ma con percentuali di crescita ben differenti: +60,85% in Umbria; +25,67% nelle Marche; +23,04% in Lazio e +2,98% in Toscana.
Il numero medio di iscritti per docente è 17,34 in Umbria, 18,39 in Toscana, 19,96 nelle Marche, 20,77 in Lazio (media del Centro 19,66; media nazionale 20,29) ma, se scorporiamo i docenti a contratto, le medie diventano 20,94 in Umbria, 28,90 in Toscana, 32,37 nelle Marche, 34,19 in Lazio (media del Centro 31,38; media nazionale 30,85).
Passiamo ora ad esaminare la situazione del Sud e delle Isole confrontando il numero dei docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato con quello dei docenti a contratto.
Tabella 260 . SUD e ISOLE. Rapporto fra docenti a contratto e docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato. Anni accademici 2014/2015-2018/2019. Valori assoluti e percentuali. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca e USTAT-Miur.
|
Anno Accademico |
Docenti/ricercatori |
Docenti a contratto |
Docenti/ricercatori per contrattista |
% contrattisti sul totale della docenza nell’area |
|
17398 |
5260 |
3,31 |
23,21% |
|
|
2015/2016 |
17103 |
5035 |
3,40 |
22,74% |
|
2016/2017 |
16957 |
5232 |
3,24 |
23,58% |
|
2017/2018 |
16697 |
5192 |
3,22 |
23,72% |
|
2018/2019 |
16703 |
5532 |
3,02 |
24,88% |
|
Variaz. % 2014-2018 |
-3,99% |
+5,17% |
-8,72% |
Rispetto alla Tabella 235 , possiamo notare nel Sud e nelle Isole una minore incidenza della docenza a contratto rispetto alle medie nazionali. Nel periodo in esame, i docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato decrescono, mentre crescono quelli a contratto. La percentuale media di docenti a contratto sul totale della docenza è però soltanto del 23,63%, rispetto al 34,25% registrato a livello nazionale.
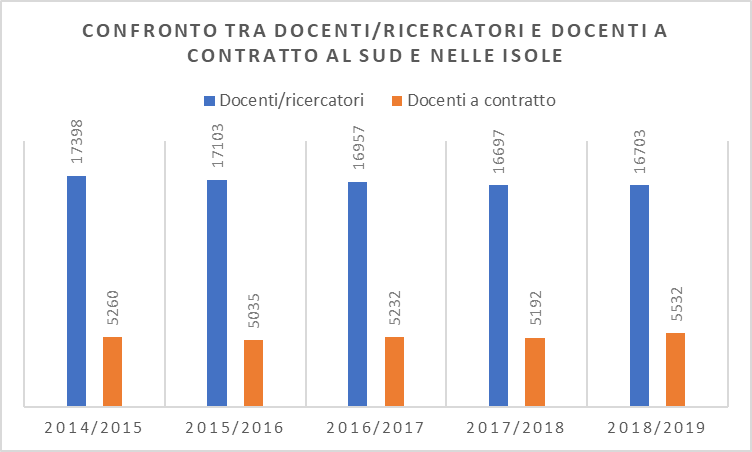
Figura 150 . SUD e ISOLE. Docenti a contratto e docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato. Anni accademici 2014/2015-2018/2019. Valori assoluti. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca e USTAT-Miur.
Confrontiamo ora il numero degli iscritti nelle università del Sud e delle Isole con quello del totale della docenza – calcolato dalla somma dei docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato e dei docenti a contratto – e poi con il numero dei soli docenti/ricercatori. Dal numero dei docenti sono stati sottratti, come di consueto, quelli del Gran Sasso Science Institute (GSSI).
Tabella 261 . SUD e ISOLE. Rapporto fra iscritti, docenti a contratto e docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato. Anni accademici 2014/2015-2018/2019. Valori assoluti, variazioni percentuali e rapporti tra iscritti e totale della docenza e iscritti e docenti/ricercatori. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca e USTAT-Miur.
|
Anno Accademico |
Iscritti |
Docenti/ricercatori |
Docenti a contratto |
Totale docenza |
Iscritti per docente |
Iscritti per docente/ricercatore |
|
2014/2015 |
554846 |
17398 |
5260 |
22658 |
24,49 |
31,89 |
|
2015/2016 |
535512 |
17103 |
5035 |
22138 |
24,19 |
31,31 |
|
2016/2017 |
532165 |
16956 |
5232 |
22188 |
23,98 |
31,39 |
|
2017/2018 |
533002 |
16684 |
5192 |
21876 |
24,36 |
31,95 |
|
2018/2019 |
536467 |
16678 |
5532 |
22210 |
24,15 |
32,17 |
|
Variaz. % 2014-2018 |
-3,31% |
-4,14% |
+5,17% |
-1,36% |
+0,86% |
Nel periodo preso in esame, nelle università del Sud e delle Isole abbiamo una decrescita di iscritti (-3,31%), una decrescita dei docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato (-4,14%) e una crescita di docenti a contratto (+5,17%). Il numero medio di iscritti per docente è 24,24 (media nazionale 20,29 iscritti per docente) ma, se scorporiamo i docenti a contratto, la media diventa 31,74 (media nazionale 30,85 iscritti per docente/ricercatore).
Esaminiamo la situazione del Sud e delle Isole regione per regione. Come nelle altre due aree, possiamo riscontrare fra una regione e l’altra rilevanti differenze riconducibili, oltre che alle caratteristiche dei territori, alle diverse dimensioni e composizioni dei sistemi regionali (numero, grandezza e tipologia degli atenei, presenza di università non statali e telematiche).
Partiamo dai valori assoluti e dalle variazioni percentuali dal 2014/2015 al 2018/2019.
Tabella 262 . SUD e ISOLE. Numerosità dei docenti a contratto per regione. Anni accademici 2014/2015-2018/2019. Valori assoluti e variazioni percentuali. Fonte: ns. elaborazione dati USTAT-Miur.
|
Anno |
Abruzzo |
Molise |
Basilicata |
Campania |
Calabria |
Puglia |
Sardegna |
Sicilia |
Totale |
|
2014/2015 |
607 |
282 |
174 |
1379 |
521 |
962 |
248 |
1087 |
5260 |
|
2015/2016 |
637 |
178 |
125 |
1360 |
618 |
685 |
234 |
1198 |
5035 |
|
2016/2017 |
718 |
195 |
131 |
1346 |
475 |
872 |
266 |
1229 |
5232 |
|
2017/2018 |
692 |
162 |
115 |
1383 |
518 |
885 |
368 |
1069 |
5192 |
|
2018/2019 |
680 |
156 |
134 |
1633 |
539 |
1013 |
357 |
1020 |
5532 |
|
Variaz. % 2014-2018 |
+12,03% |
-44,68% |
-22,99% |
+18,42% |
+3,45% |
+5,30% |
+43,95% |
-6,16% |
+5,17% |
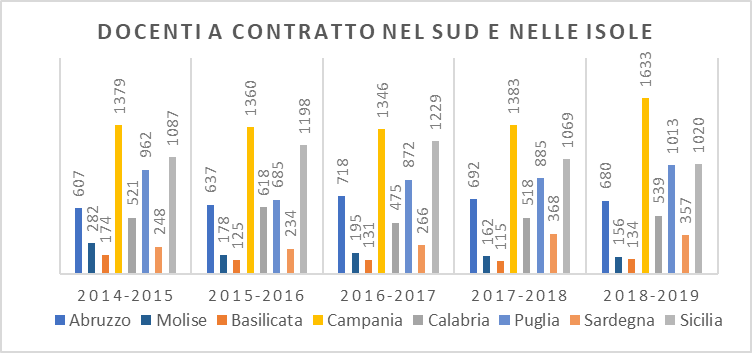
Figura 151 . SUD e ISOLE. Numerosità dei docenti a contratto per regione. Anni accademici 2014/2015-2018/2019. Valori assoluti. Fonte: ns. elaborazione dati USTAT-Miur.
Nelle regioni del Sud e nelle Isole, nel periodo preso in esame, i docenti a contratto rappresentano una percentuale sul totale della docenza (considerata come di consueto come la somma di docenti/ricercatori e docenti a contratto) che va in media dal 40,86% del Molise, al 31,57% dell’Abruzzo, al 30,4% della Basilicata, al 28,95% della Calabria, al 24,12% della Puglia, al 21,71% della Sicilia, il 21,24% della Campania e il 15,91% della Sardegna (media nazionale 34,39%; media dell’area 23,63%).
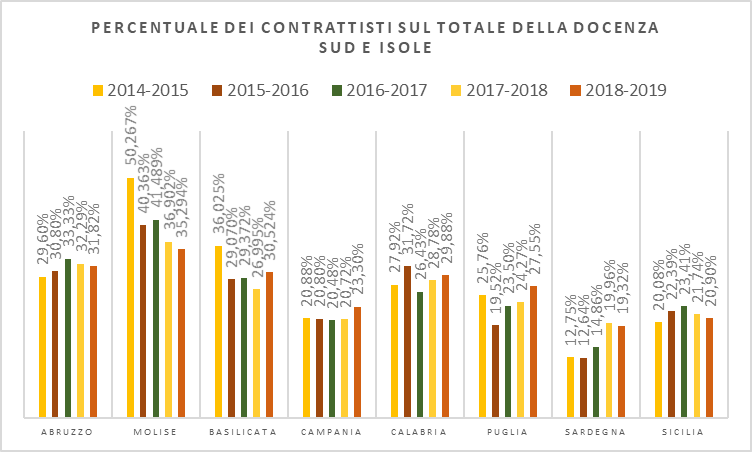
Figura 152 . SUD e ISOLE. Percentuale contrattisti sul totale della docenza (docenti/ricercatori + docenti a contratto) nell’area geografica. Anni accademici 2014/2015-2018/2019. Valori percentuali. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca e USTAT-Miur.
Confrontiamo ora il numero degli iscritti nelle università delle diverse regioni del Sud e nelle Isole con quello del totale della docenza – calcolato dalla somma dei docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato e dei docenti a contratto – e poi con il numero dei soli docenti/ricercatori.
Dal numero dei docenti dell’Abruzzo sono stati sottratti quelli del Gran Sasso Science Institute (GSSI). Poiché è impossibile concentrare tutti i dati in una sola tabella, presenteremo una tabella per ogni regione.
Tabella 263 . ABRUZZO. Rapporto fra iscritti, docenti a contratto e docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato [92] . Anni accademici 2014/2015-2018/2019. Valori assoluti e variazioni percentuali. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca e USTAT-Miur.
|
Anno Accademico |
Iscritti |
Docenti/ricercatori |
Docenti a contratto |
Iscritti per docente |
Iscritti per docente/ricercatore |
|
2014/2015 |
54996 |
1444 |
607 |
26,81 |
38,09 |
|
2015/2016 |
50110 |
1431 |
637 |
24,23 |
35,02 |
|
2016/2017 |
48149 |
1435 |
716 |
22,38 |
33,55 |
|
2017/2018 |
46276 |
1438 |
690 |
21,75 |
32,18 |
|
2018/2019 |
45104 |
1432 |
676 |
21,40 |
31,50 |
|
Variaz. % 2014-2018 |
-17,99% |
-0,83% |
+11,37% |
-20,20% |
-17,30% |
Tabella 264 . MOLISE. Rapporto fra iscritti, docenti a contratto e docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato. Anni accademici 2014/2015-2018/2019. Valori assoluti e variazioni percentuali. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca e USTAT-Miur.
|
Anno Accademico |
Iscritti |
Docenti/ricercatori |
Docenti a contratto |
Iscritti per docente |
Iscritti per docente/ricercatore |
|
2014/2015 |
7010 |
279 |
282 |
12,50 |
25,13 |
|
2015/2016 |
6938 |
263 |
178 |
15,73 |
26,38 |
|
2016/2017 |
6935 |
275 |
195 |
14,76 |
25,22 |
|
2017/2018 |
6894 |
277 |
162 |
15,70 |
24,89 |
|
2018/2019 |
6814 |
286 |
156 |
15,42 |
23,83 |
|
Variaz. % 2014-2018 |
-2,80% |
+2,51% |
-44,68% |
+23,37% |
-5,18% |
Tabella 265 . BASILICATA. Rapporto fra iscritti, docenti a contratto e docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato. Anni accademici 2014/2015-2018/2019. Valori assoluti e variazioni percentuali. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca e USTAT-Miur.
|
Anno Accademico |
Iscritti |
Docenti/ricercatori |
Docenti a contratto |
Iscritti per docente |
Iscritti per docente/ricercatore |
|
2014/2015 |
7196 |
309 |
174 |
14,90 |
23,29 |
|
2015/2016 |
6912 |
305 |
125 |
16,07 |
22,66 |
|
2016/2017 |
6686 |
315 |
131 |
14,99 |
21,23 |
|
2017/2018 |
6568 |
311 |
115 |
15,42 |
21,12 |
|
2018/2019 |
6415 |
305 |
134 |
14,61 |
21,03 |
|
Variaz. % 2014-2018 |
-10,85% |
-1,29% |
-22,99% |
-1,92% |
-9,68% |
Tabella 266 . CAMPANIA. Rapporto fra iscritti, docenti a contratto e docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato. Anni accademici 2014/2015-2018/2019. Valori assoluti e variazioni percentuali. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca e USTAT-Miur
|
Anno Accademico |
Iscritti |
Docenti/ricercatori |
Docenti a contratto |
Iscritti per docente |
Iscritti per docente/ricercatore |
|
2014/2015 |
191743 |
5226 |
1379 |
29,03 |
36,69 |
|
2015/2016 |
190487 |
5180 |
1360 |
29,13 |
36,77 |
|
2016/2017 |
195478 |
5226 |
1346 |
29,74 |
37,40 |
|
2017/2018 |
202252 |
5291 |
1383 |
30,30 |
38,23 |
|
2018/2019 |
210125 |
5375 |
1633 |
29,98 |
39,09 |
|
Variaz. % 2014-2018 |
+9,59% |
+2,85% |
+18,42% |
+3,28% |
+6,55% |
Tabella 267 . CALABRIA. Rapporto fra iscritti, docenti a contratto e docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato. Anni accademici 2014/2015-2018/2019. Valori assoluti e variazioni percentuali. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca e USTAT-Miur.
|
Anno Accademico |
Iscritti |
Docenti/ricercatori |
Docenti a contratto |
Iscritti per docente |
Iscritti per docente/ricercatore |
|
2014/2015 |
47043 |
1345 |
521 |
25,21 |
34,98 |
|
2015/2016 |
44645 |
1330 |
618 |
22,92 |
33,57 |
|
2016/2017 |
43514 |
1322 |
475 |
24,21 |
32,92 |
|
2017/2018 |
42495 |
1282 |
518 |
23,61 |
33,15 |
|
2018/2019 |
41725 |
1265 |
539 |
23,13 |
32,98 |
|
Variaz. % 2014-2018 |
-11,30% |
-5,95% |
+3,45% |
-8,26% |
-5,70% |
Tabella 268 . PUGLIA. Rapporto fra iscritti, docenti a contratto e docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato. Anni accademici 2014/2015-2018/2019. Valori assoluti e variazioni percentuali. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca e USTAT-Miur.
|
Anno Accademico |
Iscritti |
Docenti/ricercatori |
Docenti a contratto |
Iscritti per docente |
Iscritti per Docente/ricercatore |
|
2014/2015 |
87150 |
2773 |
962 |
23,33 |
31,43 |
|
2015/2016 |
83360 |
2825 |
685 |
23,75 |
29,51 |
|
2016/2017 |
81321 |
2839 |
872 |
21,91 |
28,64 |
|
2017/2018 |
81057 |
2761 |
885 |
22,23 |
29,36 |
|
2018/2019 |
81141 |
2664 |
1013 |
22,07 |
30,46 |
|
Variaz. % 2014-2018 |
-6,90% |
-3,93% |
+5,30% |
-5,43% |
-3,09% |
Tabella 269 . SARDEGNA. Rapporto fra iscritti, docenti a contratto e docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato. Anni accademici 2014/2015-2018/2019. Valori assoluti e variazioni percentuali. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca e USTAT-Miur.
|
Anno Accademico |
Iscritti |
Docenti/ricercatori |
Docenti a contratto |
Iscritti per docente |
Iscritti per docenti/ricercatori |
|
2014/2015 |
39278 |
1697 |
248 |
20,19 |
23,15 |
|
2015/2016 |
38489 |
1617 |
234 |
20,79 |
23,80 |
|
2016/2017 |
38714 |
1524 |
266 |
21,63 |
25,40 |
|
2017/2018 |
38167 |
1476 |
368 |
20,70 |
25,86 |
|
2018/2019 |
37992 |
1491 |
357 |
20,56 |
25,48 |
|
Variaz. % 2014-2018 |
-3,27% |
-12,14% |
+43,95% |
+1,80% |
+10,09% |
Tabella 270 . SICILIA. Rapporto fra iscritti, docenti a contratto e docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato. Anni accademici 2014/2015-2018/2019. Valori assoluti e variazioni percentuali. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca e USTAT-Miur.
|
Anno Accademico |
Iscritti |
Docenti/ricercatori |
Docenti a contratto |
Iscritti per docente |
Iscritti per docente/ricercatore |
|
2014/2015 |
120430 |
4325 |
1087 |
22,25 |
27,85 |
|
2015/2016 |
114571 |
4152 |
1198 |
21,42 |
27,59 |
|
2016/2017 |
111368 |
4020 |
1229 |
21,22 |
27,70 |
|
2017/2018 |
109293 |
3848 |
1069 |
22,23 |
28,40 |
|
2018/2019 |
107151 |
3860 |
1020 |
21,96 |
27,76 |
|
Variaz. % 2014-2018 |
-11,03% |
-10,75% |
-6,16% |
-1,33% |
-0,31% |
Nel periodo preso in esame, nelle università del Sud e delle Isole abbiamo situazioni piuttosto differenziate. Tranne che in Campania – dove gli iscritti salgono del 9,59% – abbiamo dovunque una decrescita di iscritti, sebbene di diversa entità. Abbiamo cali a due cifre in Abruzzo (-17,99%), Calabria (-11,3%), Sicilia (-11,03%) e Basilicata (-10,85%); cali più contenuti in Puglia (-6,9%), Sardegna (-3,27%), Molise (-2,8%).
Abbiamo una crescita dei docenti/ricercatori in Campania (+2,85%) e in Molise (+2,51%), e decrescite molto forti nelle Isole (Sardegna -12,14%; Sicilia -10,75%) e più o meno contenute in Calabria (-5,95%), Puglia (-3,93%), Basilicata (-1,29%), Abruzzo (-0,83%).
Infine, i docenti a contratto crescono in Campania (+18,42%), in Abruzzo (+11,37%), Puglia (+5,30%) e Calabria (+4,45%) mentre decrescono in maniera rilevante in Molise (-44,68%), Sardegna (-43,95%) e Basilicata (-22,99%), in maniera più contenuta in Sicilia (-6,16%).
Anche il numero medio di iscritti per docente ha numerose variazioni regionali. Da 14,82 iscritti per docente del Molise e dai 15,2 della Basilicata arriviamo ai 29,64 della Campania passando per Sardegna (20,77), Sicilia (21,81), Puglia (22,66), Abruzzo (23,31), Calabria (23,82), (media del Sud e delle Isole 24,24; media nazionale 20,29 iscritti per docente). Se, però, scorporiamo il numero dei docenti a contratto, le medie di iscritti per docente/ricercatore diventano: Campania 37,64; Abruzzo 34,07; Calabria 33,52; Puglia 29,88; Sicilia 27,86; Sardegna 24,74; Basilicata 21,87 (media del Sud e delle Isole 31,74; media nazionale 30,85).
Approfondiamo ora la situazione dei docenti a contratto nel sistema delle università statali, articolato in Mega, Grandi, Medie e Piccole università, Politecnici e Scuole Superiori ad ordinamento speciale, e nel sistema delle università non statali legalmente riconosciute, articolato in università Grandi, Medie, Piccole e telematiche. Cominciamo dai valori assoluti dei docenti a contratto nelle università statali, non statali e telematiche.
Tabella 271 . Numerosità dei docenti a contratto negli atenei statali, non statali e telematici. Anni accademici 2014/2015 – 2018/2019. Valori assoluti e variazioni percentuali. Fonte: ns. elaborazione dati USTAT-Miur.
|
Anno Accademico |
Università statali |
Università non statali |
Università telematiche |
Totale |
|
2014/2015 |
21118 |
6124 |
865 |
28107 |
|
2015/2016 |
20054 |
6222 |
1084 |
27360 |
|
2016/2017 |
20763 |
6469 |
1005 |
28237 |
|
2017/2018 |
20591 |
7090 |
1292 |
28973 |
|
2018/2019 |
21279 |
7330 |
1347 |
29956 |
|
+0,76% |
+19,69% |
+55,72% |
+6,58% |
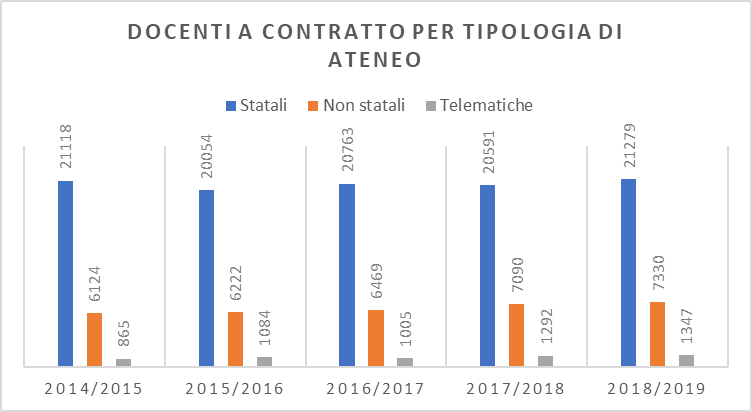
Figura 153 . Numerosità dei docenti a contratto nelle università statali, non statali e telematiche. Anni accademici 2014/2015 – 2018/2019. Valori assoluti. Fonte: ns. elaborazione dati USTAT-Miur.
Confrontiamo ora il numero dei docenti a contratto con quello dei docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato nei sistemi statale, non statale e nelle telematiche dal 2014 al 2018. Nel periodo preso in esame, i docenti/ricercatori nelle università statali decrescono del 2,52%, quelli delle università non statali aumentano del 7,57%, quelli delle telematiche aumentano del 29,48%. I docenti a contratto crescono dello 0,76% nelle statali, del 19,69% nelle non statali e del 55,72% nelle telematiche. Il numero dei docenti a contratto rispetto a quello dei docenti/ricercatori nel periodo preso in esame tende, a parte qualche incertezza nell’anno accademico 2015/2016, a salire costantemente. Il numero dei docenti a contratto è in media il 40,65% rispetto al numero dei docenti/ricercatori nelle università statali, il 221,22% in quelle non statali, il 166,83% nelle telematiche.
Tabella 272 . Docenti a contratto nelle università statali, non statali e telematiche. Anni accademici 2014/2015 – 2018/2019. Valori percentuali rispetto al numero dei docenti/ricercatori. Fonte: ns. elaborazione dati USTAT-Miur.
|
Anno Accademico |
Università statali |
Università non statali |
Università telematiche |
|
2014/2015 |
40,48% |
212,79% |
153,64% |
|
2015/2016 |
39,26% |
206,99% |
158,71% |
|
2016/2017 |
40,81% |
215,56% |
151,13% |
|
2017/2018 |
40,83% |
233,99% |
185,90% |
|
2018/2019 |
41,85% |
236,76% |
184,77% |
|
Variaz. punti percentuali |
+1,37 |
+23,97 |
+31,13 |
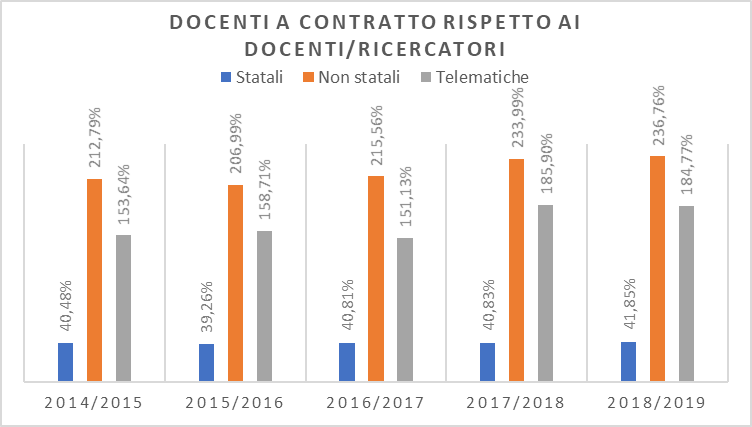
Figura 154 . Docenti a contratto negli atenei statali, non statali e telematici. Anni accademici 2014/2015-2018/2019. Valori percentuali rispetto al numero dei docenti/ricercatori. Fonte: ns. elaborazione dati USTAT-Miur.
Iniziamo l’esame dagli atenei statali, confrontando il numero dei docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato con quello dei docenti a contratto. Nelle università statali i docenti/ricercatori sono, nel periodo in esame, in media 2,46 per ogni docente a contratto . Il numero dei docenti a contratto nelle università statali è in media il 40,65% del numero dei docenti/ricercatori nella stessa tipologia di atenei.
Tabella 273 . UNIVERSITÀ STATALI. Rapporto fra docenti a contratto e docenti/ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato. Anni accademici 2014/2015 – 2018/2019. Valori assoluti, variazioni percentuali e percentuali di contrattisti sul totale della docenza (docenti/ricercatori + docenti a contratto). Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca e USTAT-Miur.
|
Docenti/ricercatori |
Docenti a contratto |
Docenti/ricercatori per contrattista |
Percentuale contrattisti sul totale della docenza |
|
|
2014/2015 |
52165 |
21118 |
2,47 |
28,82% |
|
2015/2016 |
51077 |
20054 |
2,55 |
28,19% |
|
2016/2017 |
50882 |
20763 |
2,45 |
28,98% |
|
2017/2018 |
50427 |
20591 |
2,45 |
28,99% |
|
2018/2019 |
50850 |
21279 |
2,39 |
29,50% |
|
Variaz. % 2014-2018 |
-2,52% |
+0,76% |
-3,24% |
Rispetto alla Tabella 235 , possiamo notare nelle università statali una minore incidenza della docenza a contratto rispetto alle medie nazionali. Nel periodo in esame, la percentuale media di docenti a contratto sul totale della docenza nelle università statali è del 28,90%, rispetto al 34,25% registrato a livello nazionale sul totale delle università.
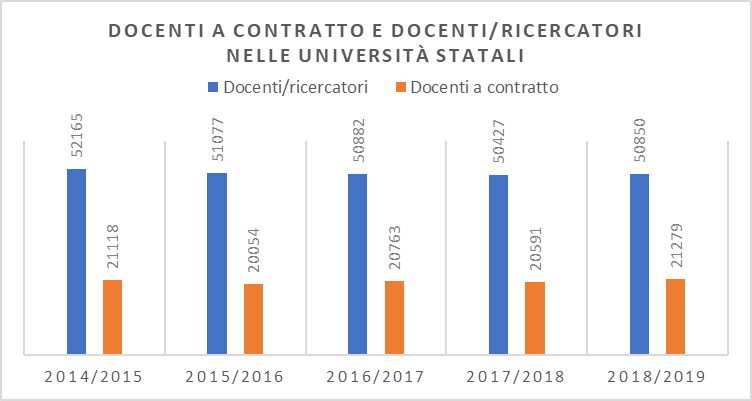
Figura 155 . UNIVERSITÀ STATALI. Comparazione tra docenti/ricercatori e docenti a contratto. Anni accademici 2014/2015 – 2018/2019. Valori assoluti. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca e USTAT-Miur.
Confrontiamo ora il numero degli iscritti nelle università statali con quello del totale della docenza – calcolato dalla somma dei docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato e dei docenti a contratto nelle università statali – e poi con il numero dei soli docenti/ricercatori nello stesso tipo di università. Dal numero dei docenti sono stati sottratti, come di consueto, quelli delle Scuole Superiori.
Tabella 274 . UNIVERSITÀ STATALI. Iscritti, docenti/ricercatori e docenti a contratto. Anni accademici 2014/2015 – 2018/2019. Valori assoluti, variazioni percentuali e rapporto tra iscritti e totale della docenza e tra iscritti e docenti/ricercatori. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca e USTAT-Miur.
|
Anno Accademico |
Iscritti |
Docenti/ricercatori |
Docenti a contratto |
Iscritti per docente |
Iscritti per docente/ricercatore |
|
2014/2015 |
1511669 |
51846 |
20812 |
20,81 |
29,16 |
|
2015/2016 |
1486696 |
50762 |
19816 |
21,06 |
29,29 |
|
2016/2017 |
1488052 |
50549 |
20504 |
20,94 |
29,44 |
|
2017/2018 |
1495461 |
50076 |
20399 |
21,22 |
29,86 |
|
2018/2019 |
1498654 |
50468 |
21090 |
20,94 |
29,70 |
|
Variaz. % 2014-2018 |
-0,86% |
-2,66% |
+1,34% |
+0,66% |
+1,85% |
Nel periodo preso in esame, nelle università statali abbiamo una diminuzione di iscritti (-0,86%), un calo dei docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato (-2,66%) e una crescita di docenti a contratto (+1,34%). Il numero medio di iscritti per docente è 21 ma, se scorporiamo i docenti a contratto, la media diventa 29,49.
Esaminiamo ora la situazione del sistema statale nella sua articolazione. La situazione presenta rilevanti differenze al suo interno. Le differenze sono legate alle diverse dimensioni degli atenei ma, evidentemente, anche alla loro collocazione geografica, che qui non prendiamo in considerazione, e alla diversa funzione e specializzazione (nel caso di Politecnici e Scuole Superiori). Partiamo dai valori assoluti e dalle variazioni percentuali dei docenti a contratto dal 2014/2015 al 2018/2019.
Tabella 275 . UNIVERSITÀ STATALI. Numerosità dei docenti a contratto negli atenei di diversa grandezza e tipologia. Anni accademici 2014/2015 – 2018/2019. Valori assoluti e variazioni percentuali. Fonte: ns. elaborazione dati USTAT-Miur.
|
Anno accademico |
Mega |
Grandi |
Medie |
Piccole |
Politecnici |
Scuole Superiori |
Totale |
|
2014/2015 |
7682 |
5229 |
4661 |
1571 |
1669 |
306 |
21118 |
|
2015/2016 |
6969 |
4908 |
4902 |
1451 |
1586 |
238 |
20054 |
|
2016/2017 |
7431 |
5157 |
5000 |
1487 |
1429 |
259 |
20763 |
|
2017/2018 |
7128 |
5522 |
4816 |
1493 |
1440 |
192 |
20591 |
|
2018/2019 |
7351 |
5831 |
4750 |
1647 |
1511 |
189 |
21279 |
|
Variaz. % 2014-2018 |
-4,31% |
+11,51% |
+1,91% |
+4,84% |
-9,47% |
-38,24% |
+0,76% |
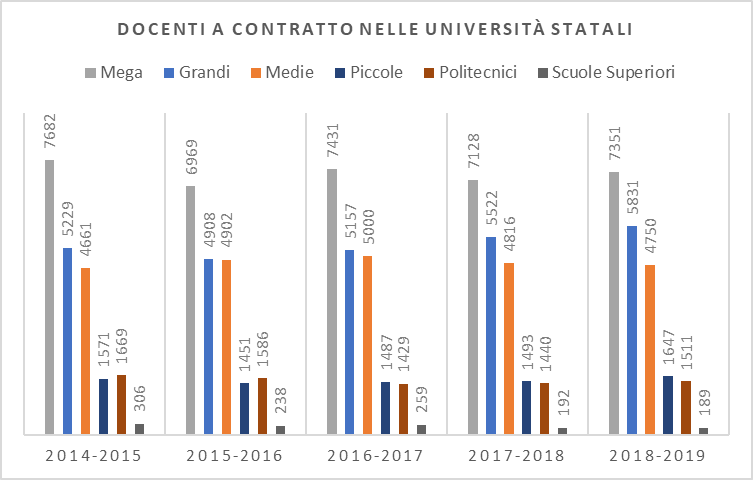
Figura 156 . UNIVERSITÀ STATALI. Numerosità dei docenti a contratto negli atenei di diversa grandezza e tipologia. Anni accademici 2014/2015 – 2018/2019. Valori assoluti. Fonte: ns. elaborazione dati USTAT-Miur.
Nel grafico seguente compendiamo le percentuali dei docenti a contratto rispetto al numero dei docenti/ricercatori in tutte le grandezze e tipologie di università statali.
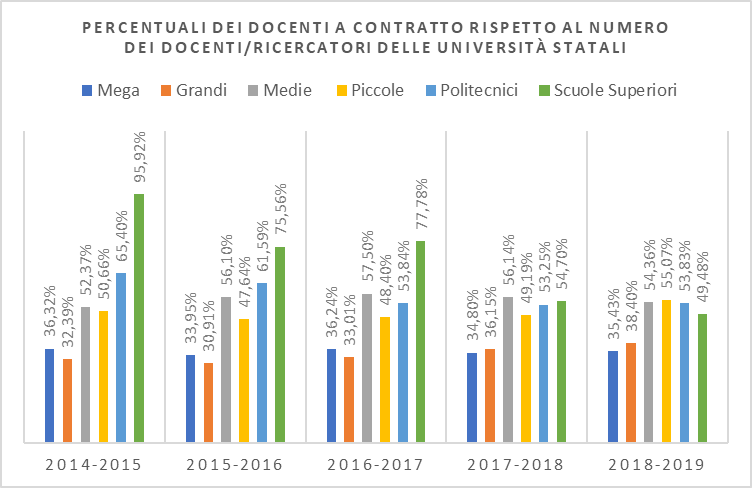
Figura 157 . UNIVERSITÀ STATALI. Percentuali dei docenti a contratto rispetto al numero dei docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato. Anni accademici 2014/2015 – 2018/2019. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca e USTAT-Miur.
Passiamo ora all’esame degli atenei non statali, confrontando il numero dei docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato con quello dei docenti a contratto. Nelle università non statali i docenti/ricercatori sono, nel periodo in esame, in media 0,45 per ogni docente a contratto. I docenti a contratto nelle università statali sono in media il 221,22% del numero dei docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Tabella 276 . UNIVERSITÀ NON STATALI. Rapporto fra docenti a contratto e docenti/ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato. Anni accademici 2014/2015 – 2018/2019. Valori assoluti, variazioni percentuali e percentuali di contrattisti sul totale della docenza (docenti/ricercatori + docenti a contratto). Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca e USTAT-Miur.
|
Docenti/ricercatori |
Docenti a contratto |
Docenti/ricercatori per contrattista |
Percentuale contrattisti sul totale della docenza |
|
|
2014/2015 |
2878 |
6124 |
0,47 |
68,03% |
|
2015/2016 |
3006 |
6222 |
0,48 |
67,43% |
|
2016/2017 |
3001 |
6469 |
0,46 |
68,31% |
|
2017/2018 |
3030 |
7090 |
0,43 |
70,06% |
|
2018/2019 |
3096 |
7330 |
0,42 |
70,31% |
|
Variaz. % 2014-2018 |
+7,57% |
+19,69% |
-10,12 |
Rispetto alla Tabella 235 , possiamo notare nelle università non statali una incidenza della docenza a contratto pressoché doppia rispetto alle medie nazionali. Nel periodo in esame, la percentuale media di docenti a contratto sul totale della docenza nelle università non statali è del 68,83%, rispetto al 34,25% registrato a livello nazionale sul totale delle università.
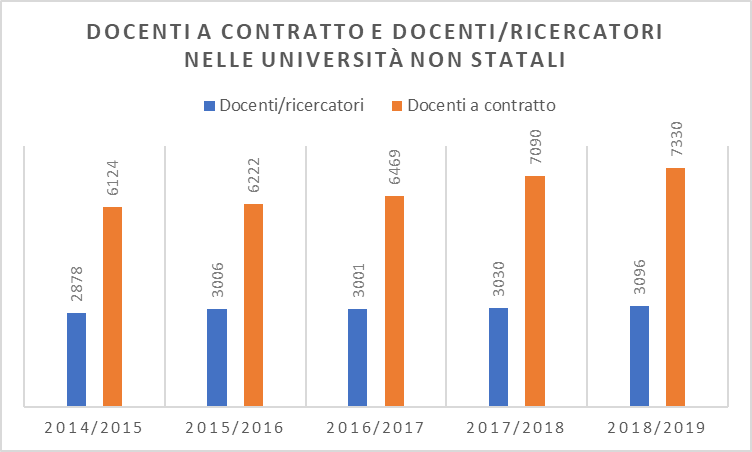
Figura 158 . UNIVERSITÀ NON STATALI. Comparazione tra docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato e docenti a contratto. Anni accademici 2014/2015 – 2018/2019. Valori assoluti. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca e USTAT-Miur.
Confrontiamo ora il numero degli iscritti nelle università non statali con quello del totale della docenza – calcolato dalla somma dei docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato e dei docenti a contratto nelle università non statali – e poi con il numero dei soli docenti/ricercatori nello stesso tipo di università.
Tabella 277 . UNIVERSITÀ NON STATALI. Iscritti, docenti/ricercatori e docenti a contratto. Anni accademici 2014/2015 – 2018/2019. Valori assoluti e variazioni percentuali e rapporto tra iscritti e totale della docenza e tra iscritti e docenti/ricercatori. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca e USTAT-Miur.
|
Anno Accademico |
Iscritti |
Docenti/ricercatori |
Docenti a contratto |
Iscritti per docente |
Iscritti per docente/ricercatore |
|
2014/2015 |
97105 |
2878 |
6124 |
10,79 |
33,74 |
|
2015/2016 |
99146 |
3006 |
6222 |
10,74 |
32,98 |
|
2016/2017 |
101214 |
3001 |
6469 |
10,69 |
33,73 |
|
2017/2018 |
104591 |
3030 |
7090 |
10,34 |
34,52 |
|
2018/2019 |
107807 |
3096 |
7330 |
10,34 |
34,82 |
|
Variaz. % 2014-2018 |
+11,02% |
+7,57% |
+19,69% |
-6,57% |
+3,20% |
Nel periodo preso in esame, nelle università non statali abbiamo una crescita di iscritti (+11,02%), una crescita di docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato (+7,57%) e una crescita di docenti a contratto (+19,69%). Il numero medio di iscritti per docente è 10,58 ma, se scorporiamo i docenti a contratto, la media diventa 33,96.
Esaminiamo ora il sistema delle università non statali nelle diverse grandezze di università.
Tabella 278 . UNIVERSITÀ NON STATALI. Numerosità dei docenti a contratto negli atenei di diversa grandezza. Anni accademici 2014/2016 – 2018/2019. Valori assoluti e variazioni percentuali. Fonte: ns. elaborazione dati USTAT-Miur.
|
Anno accademico |
Grandi non statali |
Medie non statali |
Piccole non statali |
Totale |
|
2014/2015 |
2675 |
2116 |
1333 |
6124 |
|
2015/2016 |
3153 |
1809 |
1260 |
6222 |
|
2016/2017 |
2912 |
1960 |
1597 |
6469 |
|
2017/2018 |
3171 |
2165 |
1754 |
7090 |
|
2018/2019 |
3059 |
2444 |
1827 |
7330 |
|
Variaz. % 2014-2018 |
+14,36% |
+15,50% |
+37,06% |
+19,69% |
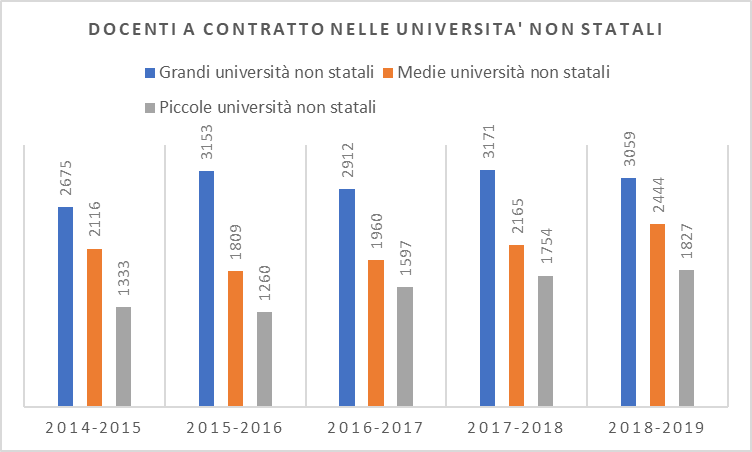
Figura 159 . UNIVERSITÀ NON STATALI. Numerosità dei docenti a contratto negli atenei di diversa grandezza. Anni accademici 2014/2015 – 2018/2019. Valori assoluti. Fonte: ns. elaborazione dati USTAT-Miur.
Nel grafico seguente compendiamo le percentuali dei docenti a contratto rispetto al numero dei docenti/ricercatori in tutte le grandezze di università non statali.
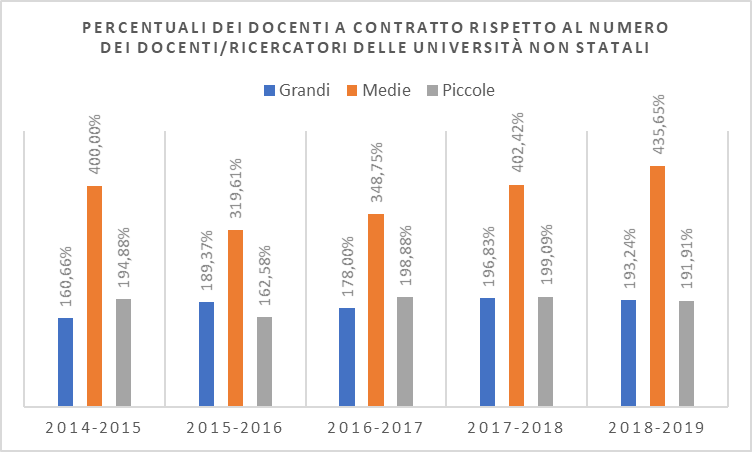
Figura 160 . UNIVERSITÀ NON STATALI. Percentuali dei docenti a contratto rispetto al numero dei docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato. Anni accademici 2014/2015 – 2018/2019. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca e USTAT-Miur.
Detto in altri termini, dal 2014/2015 al 2018/2019 i docenti a contratto sono in media il 64,66% del totale della docenza delle Grandi Università non statali; il 79,06% del totale della docenza delle Medie Università non statali; il 65,37% del totale della docenza delle Piccole Università non statali.
Osserviamo ora il rapporto tra docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato e docenti a contratto nelle università telematiche.
Nelle università telematiche i docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato sono, nel periodo in esame, in media 0,6 per ogni docente a contratto. I docenti a contratto sono in media il 166,83% del numero dei docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Tabella 279 . UNIVERSITÀ TELEMATICHE. Rapporto fra docenti a contratto e docenti/ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato. Anni accademici 2014/2015-2018/2019. Valori assoluti, variazioni percentuali e percentuali di contrattisti sul totale della docenza (docenti/ricercatori + docenti a contratto). Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca e USTAT-Miur.
|
Anno Accademico |
Docenti/ricercatori |
Docenti a contratto |
Docenti/ricercatori per contrattista |
Percentuale contrattisti sul totale della docenza |
|
2014/2015 |
563 |
865 |
0,65 |
60,57% |
|
2015/2016 |
683 |
1084 |
0,63 |
61,35% |
|
2016/2017 |
665 |
1005 |
0,66 |
60,18% |
|
2017/2018 |
695 |
1292 |
0,54 |
65,02% |
|
2018/2019 |
729 |
1347 |
0,54 |
64,88% |
|
Variaz. % 2014-2018 |
+29,48% |
+55,72% |
-16,85% |
Rispetto alla Tabella 235 , possiamo notare nelle università telematiche una incidenza della docenza a contratto molto più alta alle medie nazionali, benché inferiore a quella che abbiamo riscontrato nelle altre università non statali. Nel periodo in esame, la percentuale media di docenti a contratto sul totale della docenza nelle università telematiche è del 62,40%, rispetto al 34,25% registrato a livello nazionale sul totale delle università.
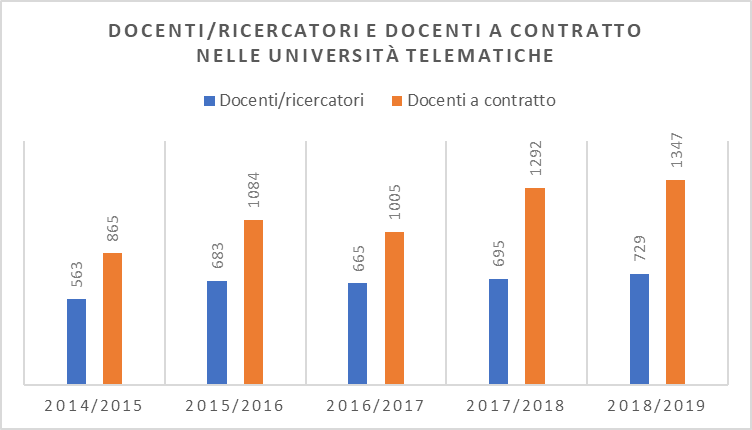
Figura 161 . UNIVERSITÀ TELEMATICHE. Comparazione tra docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato e docenti a contratto. Anni accademici 2014/2016 – 2018/2019. Valori assoluti. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca e USTAT-Miur.
Confrontiamo ora il numero degli iscritti nelle università telematiche con quello del totale della docenza e poi con il numero dei docenti a contratto nella stessa tipologia di università.
Tabella 280 . UNIVERSITÀ TELEMATICHE. Iscritti, docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato e docenti a contratto. Anni accademici 2014/2015 – 2018/2019. Valori assoluti e rapporto tra iscritti e totale della docenza e tra iscritti e docenti/ricercatori. Fonte: ns. elaborazione dati Miur-Cineca e USTAT-Miur.
|
Anno Accademico |
Iscritti |
Docenti/ricercatori |
Docenti a contratto |
Iscritti per docente |
Iscritti per docente/ricercatore |
|
2014/2015 |
54551 |
563 |
865 |
38,20 |
96,89 |
|
2015/2016 |
62532 |
683 |
1084 |
35,39 |
91,55 |
|
2016/2017 |
76283 |
665 |
1005 |
45,68 |
114,71 |
|
2017/2018 |
92516 |
695 |
1292 |
46,56 |
133,12 |
|
2018/2019 |
114213 |
729 |
1347 |
55,02 |
156,67 |
|
Variaz. % 2014-2018 |
+109,37% |
+29,48% |
+55,72% |
+44,02% |
+61,69% |
Nel periodo preso in esame, università telematiche abbiamo un incremento di iscritti (+109,37%), di docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato (+29,48%) e di docenti a contratto (+55,72%). Il numero medio di iscritti per docente è 44,17 ma, se scorporiamo i docenti a contratto, la media diventa 118,59.
Questi andamenti sembrano smentire l’ipotesi che mette meccanicamente in rapporto diretto la decrescita dei docenti e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato e la crescita della docenza a contratto.
Come abbiamo visto nelle regioni del Sud e nelle Isole, un andamento pesantemente negativo degli iscritti è spesso in relazione con decrescite dei docenti a contratto anche in presenza di decrescita di docenti ricercatori. Viceversa, si può avere crescita di docenti a contratto anche in presenza di crescita dei docenti/ricercatori, andamento che abbiamo riscontrato ad esempio nelle Piccole Università non statali e nelle telematiche ma anche nelle università del Nord prese nel loro complesso. Vi sono poi andamenti, come quello dell’Emilia Romagna, in cui una crescita di iscritti si accompagna alla decrescita di docenti/ricercatori e di docenti a contratto. In breve, queste dinamiche – che nel loro insieme rimandano a una precarizzazione della docenza – sono legate a meccanismi complessi, che andrebbero indagati più in profondità caso per caso.
Il Dottorato di Ricerca è il terzo livello degli studi universitari, durante il quale il dottorando segue dei corsi ed è seguito da un docente tutor che lo guida nelle attività formative e di ricerca. L’ammissione ai corsi si ottiene mediante concorso indetto dalle singole università italiane. I requisiti di ammissione al concorso e le modalità dello stesso sono stabiliti autonomamente dalle università, come pure denominazioni e contenuti dei corsi stessi. La durata del corso di dottorato di ricerca è generalmente di tre anni accademici, durante i quali il dottorando percepisce un assegno mensile come borsa di dottorato. Vengono tuttavia banditi ogni anno un certo numero di posti di dottorato “senza borsa”. Il corso si conclude con un esame finale che consiste nella presentazione e discussione di una tesi.
Tecnicamente, quindi, i dottorandi sono degli studenti. Tuttavia, essi devono dimostrare una certa autonomia nella gestione dei fondi assegnati, del proprio progetto di ricerca e delle proprie pubblicazioni. Inoltre, i dottorandi collaborano attivamente alle attività di ricerca dei docenti e talvolta svolgono attività di docenza a titolo gratuito. [93] Se, quindi, formalmente non è corretto comprenderli fra i “precari” della ricerca, è probabilmente giusto considerarli come collaboratori in alcuni segmenti di attività dei docenti/ricercatori.
Osserviamo la numerosità dei dottorandi nelle università italiane elaborando i dati del Portale dei dati dell’istruzione superiore USTAT-Miur sugli iscritti ai corsi di dottorato dall’anno accademico 2000/2001 all’anno accademico 2019/2020. [94]
Iniziamo con i valori assoluti e la composizione di genere.
Tabella 281 . Numerosità dei dottorandi. Genere e totali. Anni accademici 2000/2001-2019/2020. Valori assoluti e variazioni percentuali. Fonte: ns. elaborazione dati USTAT-Miur.
|
Anno Accademico |
Dottorande |
Dottorandi |
Totale |
Variazioni percentuali dall’anno precedente |
|
2000/2001 |
10788 |
10340 |
21128 |
|
|
2001/2002 |
13553 |
12751 |
26304 |
24,50% |
|
2002/2003 |
15252 |
14693 |
29945 |
13,84% |
|
2003/2004 |
18047 |
17339 |
35386 |
18,17% |
|
2004/2005 |
19211 |
18309 |
37520 |
6,03% |
|
2005/2006 |
19768 |
18488 |
38256 |
1,96% |
|
2006/2007 |
20941 |
19180 |
40121 |
4,88% |
|
2007/2008 |
20660 |
18578 |
39238 |
-2,20% |
|
2008/2009 |
20734 |
18547 |
39281 |
0,11% |
|
2009/2010 |
20188 |
18156 |
38344 |
-2,39% |
|
2010/2011 |
19075 |
17317 |
36392 |
-5,09% |
|
2011/2012 |
18056 |
16821 |
34877 |
-4,16% |
|
2012/2013 |
18009 |
16912 |
34921 |
0,13% |
|
2013/2014 |
17227 |
16281 |
33508 |
-4,05% |
|
2014/2015 |
16682 |
16089 |
32771 |
-2,20% |
|
2015/2016 |
15261 |
14751 |
30012 |
-8,42% |
|
2016/2017 |
14025 |
13798 |
27823 |
-7,29% |
|
2017/2018 |
14229 |
14225 |
28454 |
2,27% |
|
2018/2019 |
14522 |
14957 |
29479 |
3,60% |
|
2019/2020 |
14457 |
15194 |
29651 |
0,58% |
|
Variaz. % 2000/2001 – 2019/2020 |
+34,01% |
+46,94% |
+40,34% |
|
|
Variaz. % 2008/2009 – 2019/2020 |
-30,27% |
-18,07% |
-24,52% |
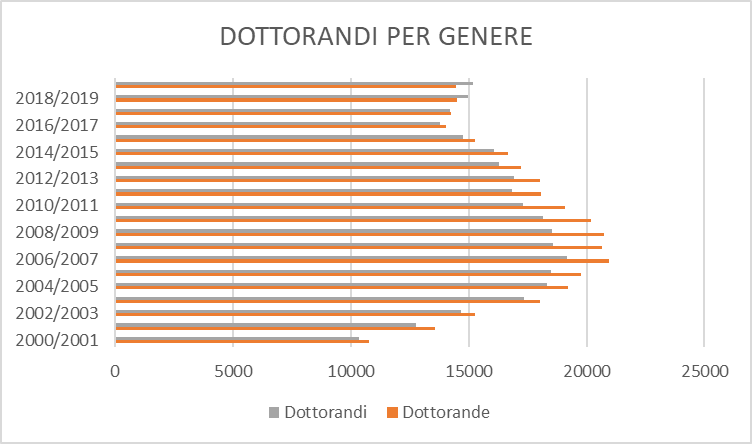
Figura 162 . Numerosità dei dottorandi per genere. Anni accademici 2000/2001-2019/2020. Valori assoluti. Fonte: ns. elaborazione dati USTAT-Miur.
Dall’anno accademico 2000/2001 a quello 2006/2007 il numero degli iscritti ai corsi di dottorato aumenta dell’89,89% (le donne crescono del 94,11%; gli uomini dell’85,49%). Dal 2006/2007 al 2016/2017 gli iscritti ai corsi di dottorato decrescono del 30,65% (-33,03% le donne; -28,06% gli uomini); dal 2016/2017 al 2019/2020 riprendono un trend positivo (+6,57%; +3,08% le donne, +10,12% gli uomini). Dunque, dall’anno accademico dal quale partono i dati al 2019/2020 la crescita complessiva è stata del 34,01%. Se, tuttavia, ci limitiamo unicamente al periodo preso in esame in questo rapporto – vale a dire 2008-2020 – riscontriamo una decrescita del 24,52% (-30,27% le dottorande; -18,07% i dottorandi).
A questo proposito va ricordato che nel 2013 il d.m. dell’8 febbraio, n. 45 , ha profondamente modificato le procedure di accreditamento dei corsi di dottorato. Ne è conseguita una riduzione del «numero dei corsi del 41% tra il 2012 e il 2013 e di un ulteriore 2,4% nell’anno successivo. Dal 2015 in poi, l’offerta di corsi torna nuovamente a crescere con alcune differenze a livello geografico: tra il 2014 e il 2017, il numero dei corsi aumenta dell’11,3% al Mezzogiorno, passando da 221 a 246 corsi, del 5,1% al Centro e del 3,2% al Nord» (cfr. ANVUR 2018 : 205 ; cfr. anche Viesti 2018 : 112-144). Questa ripresa dei corsi – cui ha corrisposto un incremento degli iscritti a partire dal 2017/2018 – non ha ancora riportato il numero delle studentesse e degli studenti di dottorato ai livelli precedenti ai primi decrementi, risalenti al 2007/2008.
Vediamo ora le percentuali di dottorande e dottorandi sul totale degli iscritti.
Tabella 282 . Numerosità dei dottorandi per genere. Anni accademici 2000/2001-2019/2020. Valori percentuali. Fonte: ns. elaborazione dati USTAT-Miur.
|
Anno Accademico |
Donne |
Uomini |
|
2000/2001 |
51,06% |
48,94% |
|
2001/2002 |
51,52% |
48,48% |
|
2002/2003 |
50,93% |
49,07% |
|
2003/2004 |
51,00% |
49,00% |
|
2004/2005 |
51,20% |
48,80% |
|
2005/2006 |
51,67% |
48,33% |
|
2006/2007 |
52,19% |
47,81% |
|
2007/2008 |
52,65% |
47,35% |
|
2008/2009 |
52,78% |
47,22% |
|
2009/2010 |
52,65% |
47,35% |
|
2010/2011 |
52,42% |
47,58% |
|
2011/2012 |
51,77% |
48,23% |
|
2012/2013 |
51,57% |
48,43% |
|
2013/2014 |
51,41% |
48,59% |
|
2014/2015 |
50,90% |
49,10% |
|
2015/2016 |
50,85% |
49,15% |
|
2016/2017 |
50,41% |
49,59% |
|
2017/2018 |
50,01% |
49,99% |
|
2018/2019 |
49,26% |
50,74% |
|
2019/2020 |
48,76% |
51,24% |
Da un’iniziale prevalenza femminile, che nell’anno accademico 2008/2009 ha sfiorato il 53%, le donne hanno iniziato a decrescere fino a diventare minoritarie.
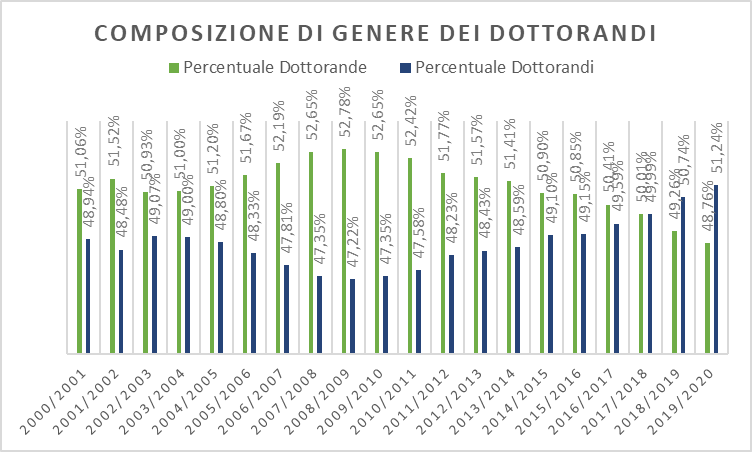
Figura 163 . Dottorandi per genere. Anni accademici 2000/2001-2019/2020. Valori percentuali. Fonte: ns. elaborazione dati USTAT-Miur.
Veniamo ora alla distribuzione geografica nelle tre macro-aree del Paese. Nella tabella seguente presentiamo i valori assoluti e le variazioni percentuali.
Tabella 283 . Numerosità dei dottorandi per area geografica. Anni accademici 2000/2001-2019/2020. Valori assoluti e variazioni percentuali. Fonte: ns. elaborazione dati USTAT-Miur.
|
Anno Accademico |
Nord |
Centro |
Sud e Isole |
|
2000/2001 |
8872 |
4720 |
7536 |
|
2001/2002 |
10713 |
6073 |
9518 |
|
2002/2003 |
12537 |
6997 |
10411 |
|
2003/2004 |
13626 |
10499 |
11261 |
|
2004/2005 |
14474 |
10805 |
12241 |
|
2005/2006 |
15188 |
10909 |
12159 |
|
2006/2007 |
15949 |
12051 |
12121 |
|
2007/2008 |
15894 |
11011 |
11724 |
|
2008/2009 |
16086 |
11627 |
11288 |
|
2009/2010 |
15849 |
11468 |
11027 |
|
2010/2011 |
15746 |
10833 |
9799 |
|
2011/2012 |
15628 |
10028 |
9221 |
|
2012/2013 |
15323 |
10592 |
9006 |
|
2013/2014 |
15156 |
10345 |
8007 |
|
2014/2015 |
14742 |
10627 |
7402 |
|
2015/2016 |
13722 |
9917 |
6373 |
|
2016/2017 |
12784 |
9062 |
5977 |
|
2017/2018 |
13128 |
8995 |
6331 |
|
2018/2019 |
13824 |
9014 |
6641 |
|
2019/2020 |
14040 |
9072 |
6539 |
|
Variaz. % 2000/2001 – 2019/2020 |
+58,25% |
+92,20% |
-13,23% |
|
Variaz. % 2008/2009 – 2019/2020 |
-12,72% |
-21,97% |
-42,07% |
Dal 2000/2001 al 2019/2020 le iscrizioni ai corsi di dottorato sono molto aumentate al Nord, quasi raddoppiate al Centro e diminuite al Sud e nelle Isole. Tuttavia, nel periodo preso in esame in questa trattazione abbiamo una decrescita generalizzata, seppur diversamente incidente nelle tre macro-aree del Paese. In valori assoluti, il Nord raggiunge il massimo degli iscritti nell’anno accademico 2008/2009 (+81,31% rispetto al 2000/2001); perde il 20,53% dal 2008/2009 al 2016/2017, guadagna il 9,82% dal 2016/2017 al 2019/2020. Il Centro raggiunge il massimo degli iscritti nel 2006/2007 (+155,32%), perde il 25,36% degli iscritti dal 2006/2007 al 2017/2018, ne guadagna lo 0,86% dal 2017/2018 al 2019/2020.
Nel Sud e nelle Isole il trend positivo dura fino al 2004/2005 (+62,43% dal 2000/2001). Dal 2004/2005 al 2016/2017 gli iscritti decrescono del 51,17%, e risalgono del 9,4% dal 2016/2017 al 2019/2020.
Veniamo ora all’incidenza percentuale delle tre macro-aree sui totali.
Tabella 284 . Dottorandi per area geografica. Anni accademici 2000/2001-2019/2020. Valori percentuali sui totali. Fonte: ns. elaborazione dati USTAT-Miur.
|
Anno Accademico |
Nord |
Centro |
Sud e Isole |
|
2000/2001 |
41,99% |
22,34% |
35,67% |
|
2001/2002 |
40,73% |
23,09% |
36,18% |
|
2002/2003 |
41,87% |
23,37% |
34,77% |
|
2003/2004 |
38,51% |
29,67% |
31,82% |
|
2004/2005 |
38,58% |
28,80% |
32,63% |
|
2005/2006 |
39,70% |
28,52% |
31,78% |
|
2006/2007 |
39,75% |
30,04% |
30,21% |
|
2007/2008 |
40,51% |
28,06% |
29,88% |
|
2008/2009 |
40,95% |
29,60% |
28,74% |
|
2009/2010 |
41,33% |
29,91% |
28,76% |
|
2010/2011 |
43,27% |
29,77% |
26,93% |
|
2011/2012 |
44,81% |
28,75% |
26,44% |
|
2012/2013 |
43,88% |
30,33% |
25,79% |
|
2013/2014 |
45,23% |
30,87% |
23,90% |
|
2014/2015 |
44,98% |
32,43% |
22,59% |
|
2015/2016 |
45,72% |
33,04% |
21,23% |
|
2016/2017 |
45,95% |
32,57% |
21,48% |
|
2017/2018 |
46,14% |
31,61% |
22,25% |
|
2018/2019 |
46,89% |
30,58% |
22,53% |
|
2019/2020 |
47,35% |
30,60% |
22,05% |
Come la tabella mostra chiaramente, gli iscritti si concentrano principalmente al Nord, ma la crescita percentuale è più sostenuta al Centro, mentre il numero percentuale di iscritti nel Sud e nelle Isole si contrae progressivamente.
Veniamo ora alla composizione di genere nelle tre aree, ancora una volta in valori assoluti e in percentuale sul totale dell’area.
Tabella 285 . Numerosità dei dottorandi per area geografica e per genere. Anni accademici 2000/2001-2019/2020. Valori assoluti e variazioni percentuali. Fonte: ns. elaborazione dati USTAT-Miur.
|
Anno Accademico |
Dottorande Nord |
Dottorandi Nord |
Dottorande Centro |
Dottorandi Centro |
Dottorande Sud e Isole |
Dottorandi Sud e Isole |
|
2000/2001 |
4403 |
4469 |
2320 |
2400 |
4065 |
3471 |
|
2001/2002 |
5357 |
5356 |
3035 |
3038 |
5161 |
4357 |
|
2002/2003 |
6231 |
6306 |
3469 |
3528 |
5552 |
4859 |
|
2003/2004 |
6761 |
6865 |
5262 |
5237 |
6024 |
5237 |
|
2004/2005 |
7261 |
7213 |
5385 |
5420 |
6565 |
5676 |
|
2005/2006 |
7700 |
7488 |
5520 |
5389 |
6548 |
5611 |
|
2006/2007 |
8099 |
7850 |
6249 |
5802 |
6593 |
5528 |
|
2007/2008 |
8163 |
7731 |
5771 |
5240 |
6357 |
5367 |
|
2008/2009 |
8307 |
7779 |
6053 |
5574 |
6223 |
5065 |
|
2009/2010 |
8150 |
7699 |
5943 |
5525 |
6095 |
4932 |
|
2010/2011 |
8034 |
7712 |
5562 |
5271 |
5466 |
4333 |
|
2011/2012 |
7840 |
7788 |
5121 |
4907 |
5095 |
4126 |
|
2012/2013 |
7677 |
7646 |
5348 |
5244 |
4984 |
4022 |
|
2013/2014 |
7491 |
7665 |
5313 |
5032 |
4423 |
3584 |
|
2014/2015 |
7159 |
7583 |
5426 |
5201 |
4097 |
3305 |
|
2015/2016 |
6598 |
7124 |
5135 |
4782 |
3528 |
2845 |
|
2016/2017 |
6059 |
6725 |
4661 |
4401 |
3305 |
2672 |
|
2017/2018 |
6183 |
6945 |
4619 |
4376 |
3427 |
2904 |
|
2018/2019 |
6474 |
7350 |
4565 |
4449 |
3483 |
3158 |
|
2019/2020 |
6527 |
7513 |
4555 |
4517 |
3375 |
3164 |
|
Variaz. % 2000/2001 – 2019/2020 |
+48,24% |
+68,11% |
+96,34% |
+88,21% |
-16,97% |
-8,84% |
|
Variaz. % 2008/2009 – 2019/2020 |
-21,43% |
-3,42% |
-24,75% |
-18,96% |
-45,77% |
-37,53% |
Osserviamo la costante di una minor crescita e di una maggior decrescita delle dottorande rispetto ai dottorandi.
Vediamo ora l’incidenza percentuale dei generi nelle tre macro-aree sui totali delle aree stesse.
Tabella 286 . Dottorandi per genere e per area geografica. Anni accademici 2000/2001-2019/2020. Valori percentuali sui totali delle aree. Fonte: ns. elaborazione dati USTAT-Miur.
|
Anno Accademico |
Dottorande Nord |
Dottorandi Nord |
Dottorande Centro |
Dottorandi Centro |
Dottorande Sud e Isole |
Dottorandi Sud e Isole |
|
2000/2001 |
49,63% |
50,37% |
49,15% |
50,85% |
53,94% |
46,06% |
|
2001/2002 |
50,00% |
50,00% |
49,98% |
50,02% |
54,22% |
45,78% |
|
2002/2003 |
49,70% |
50,30% |
49,58% |
50,42% |
53,33% |
46,67% |
|
2003/2004 |
49,62% |
50,38% |
50,12% |
49,88% |
53,49% |
46,51% |
|
2004/2005 |
50,17% |
49,83% |
49,84% |
50,16% |
53,63% |
46,37% |
|
2005/2006 |
50,70% |
49,30% |
50,60% |
49,40% |
53,85% |
46,15% |
|
2006/2007 |
50,78% |
49,22% |
51,85% |
48,15% |
54,39% |
45,61% |
|
2007/2008 |
51,36% |
48,64% |
52,41% |
47,59% |
54,22% |
45,78% |
|
2008/2009 |
51,64% |
48,36% |
52,06% |
47,94% |
55,13% |
44,87% |
|
2009/2010 |
51,42% |
48,58% |
51,82% |
48,18% |
55,27% |
44,73% |
|
2010/2011 |
51,02% |
48,98% |
51,34% |
48,66% |
55,78% |
44,22% |
|
2011/2012 |
50,17% |
49,83% |
51,07% |
48,93% |
55,25% |
44,75% |
|
2012/2013 |
50,10% |
49,90% |
50,49% |
49,51% |
55,34% |
44,66% |
|
2013/2014 |
49,43% |
50,57% |
51,36% |
48,64% |
55,24% |
44,76% |
|
2014/2015 |
48,56% |
51,44% |
51,06% |
48,94% |
55,35% |
44,65% |
|
2015/2016 |
48,08% |
51,92% |
51,78% |
48,22% |
55,36% |
44,64% |
|
2016/2017 |
47,40% |
52,60% |
51,43% |
48,57% |
55,30% |
44,70% |
|
2017/2018 |
47,10% |
52,90% |
51,35% |
48,65% |
54,13% |
45,87% |
|
2018/2019 |
46,83% |
53,17% |
50,64% |
49,36% |
52,45% |
47,55% |
|
2019/2020 |
46,49% |
53,51% |
50,21% |
49,79% |
51,61% |
48,39% |
|
Media |
49,51% |
50,49% |
50,91% |
49,09% |
54,36% |
45,64% |
Osserviamo il maggior peso percentuale della componente femminile al Sud e nelle Isole (55,78% nel 2010/2011; media dell’intero periodo 54,36%, contro il 49,51% del Nord e il 50,91% del Centro).
Guardiamo ora alla distribuzione geografica regione per regione nelle aree del Nord, del Centro e del Sud e Isole.
Cominciamo col presentare le tabelle del Nord. La seguente espone i valori assoluti e le variazioni percentuali nelle singole regioni.
Tabella 287 . NORD. Numerosità dei dottorandi per regione. Anni accademici 2000/2001-2019/2020. Valori assoluti e variazioni percentuali. Fonte: ns. elaborazione dati USTAT-Miur.
|
Anno Accademico |
Valle d’Aosta |
Piemonte |
Liguria |
Emilia Romagna |
Lombardia |
Veneto |
Friuli |
Trentino Alto Adige |
Totale |
|
2000/2001 |
0 |
1025 |
733 |
2140 |
2760 |
1275 |
718 |
221 |
8872 |
|
2001/2002 |
0 |
1418 |
788 |
2667 |
3104 |
1611 |
841 |
284 |
10713 |
|
2002/2003 |
0 |
1731 |
803 |
2871 |
3824 |
1980 |
968 |
360 |
12537 |
|
2003/2004 |
0 |
1788 |
718 |
3116 |
4305 |
2254 |
1030 |
415 |
13626 |
|
2004/2005 |
0 |
2007 |
739 |
3073 |
4743 |
2364 |
1077 |
471 |
14474 |
|
2005/2006 |
0 |
2075 |
801 |
3196 |
5109 |
2431 |
1132 |
444 |
15188 |
|
2006/2007 |
0 |
2173 |
923 |
3272 |
5305 |
2565 |
1200 |
511 |
15949 |
|
2007/2008 |
0 |
2178 |
994 |
3262 |
5244 |
2616 |
1099 |
501 |
15894 |
|
2008/2009 |
0 |
2215 |
1031 |
3154 |
5377 |
2636 |
1126 |
547 |
16086 |
|
2009/2010 |
0 |
2217 |
1025 |
3031 |
5417 |
2490 |
1077 |
592 |
15849 |
|
2010/2011 |
0 |
2099 |
1067 |
2903 |
5382 |
2632 |
1040 |
623 |
15746 |
|
2011/2012 |
0 |
1958 |
1092 |
2868 |
5441 |
2573 |
1034 |
662 |
15628 |
|
2012/2013 |
0 |
1911 |
1093 |
2823 |
5448 |
2350 |
1025 |
673 |
15323 |
|
2013/2014 |
0 |
1923 |
1078 |
2884 |
5363 |
2280 |
920 |
708 |
15156 |
|
2014/2015 |
0 |
1776 |
1043 |
2671 |
5295 |
2321 |
936 |
700 |
14742 |
|
2015/2016 |
0 |
1691 |
983 |
2413 |
4902 |
2088 |
913 |
732 |
13722 |
|
2016/2017 |
0 |
1533 |
986 |
2290 |
4387 |
1980 |
898 |
710 |
12784 |
|
2017/2018 |
0 |
1618 |
1016 |
2374 |
4459 |
2039 |
885 |
737 |
13128 |
|
2018/2019 |
0 |
1726 |
1036 |
2602 |
4650 |
2113 |
887 |
810 |
13824 |
|
2019/2020 |
0 |
1347 |
988 |
2828 |
4925 |
2184 |
862 |
906 |
14040 |
|
Variaz. % 2000/2001 – 2019/2020 |
+31,41% |
+34,79% |
+32,15% |
+78,44% |
+71,29% |
+20,06% |
+309,95% |
+58,25% |
|
|
Variaz. % 2008/2009 – 2019/2020 |
-39,19% |
-4,17% |
-10,34% |
-8,41% |
-17,15% |
-23,45% |
65,63% |
-12,72% |
Spicca la performance del Trentino Alto Adige, ma anche quella della Lombardia. Dopo aver registrato la quasi totale assenza di RTD-B in Valle d’Aosta, dobbiamo constatare anche l’assenza di dottorandi in questa regione piccola e poco popolata, in cui c’è una sola Piccola università non statale.
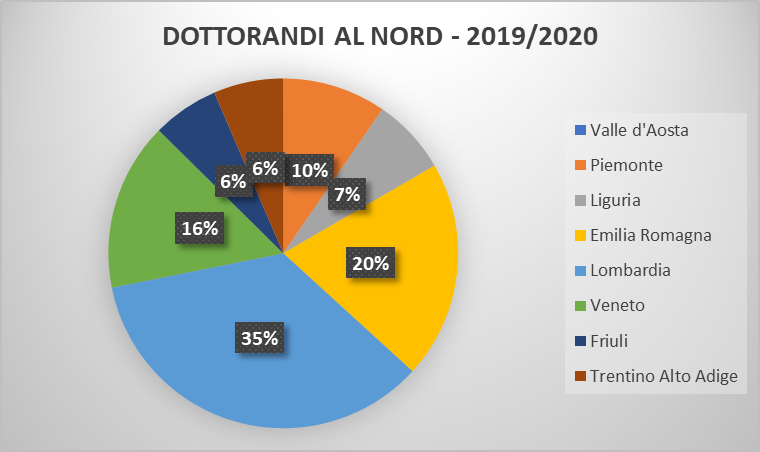
Figura 164 . NORD. Numerosità dei dottorandi per regione. Anno accademico 2019/2020. Valori percentuali sul totale dell’area. Fonte: ns. elaborazione dati USTAT-Miur.
Vediamo ora l’incidenza percentuale dei dottorandi delle regioni del Nord rispetto al totale nazionale.
Tabella 288 . NORD. Dottorandi per regione. Anni accademici 2000/2001-2019/2020. Valori percentuali sul totale nazionale. Fonte: ns. elaborazione dati USTAT-Miur.
|
Anno Accademico |
Valle d’Aosta |
Piemonte |
Liguria |
Emilia Romagna |
Lombardia |
Veneto |
Friuli |
Trentino Alto Adige |
|
2000/2001 |
4,85% |
3,47% |
10,13% |
13,06% |
6,03% |
3,40% |
1,05% |
|
|
2001/2002 |
5,39% |
3,00% |
10,14% |
11,80% |
6,12% |
3,20% |
1,08% |
|
|
2002/2003 |
5,78% |
2,68% |
9,59% |
12,77% |
6,61% |
3,23% |
1,20% |
|
|
2003/2004 |
5,05% |
2,03% |
8,81% |
12,17% |
6,37% |
2,91% |
1,17% |
|
|
2004/2005 |
5,35% |
1,97% |
8,19% |
12,64% |
6,30% |
2,87% |
1,26% |
|
|
2005/2006 |
5,42% |
2,09% |
8,35% |
13,35% |
6,35% |
2,96% |
1,16% |
|
|
2006/2007 |
5,42% |
2,30% |
8,16% |
13,22% |
6,39% |
2,99% |
1,27% |
|
|
2007/2008 |
5,55% |
2,53% |
8,31% |
13,36% |
6,67% |
2,80% |
1,28% |
|
|
2008/2009 |
5,64% |
2,62% |
8,03% |
13,69% |
6,71% |
2,87% |
1,39% |
|
|
2009/2010 |
5,78% |
2,67% |
7,90% |
14,13% |
6,49% |
2,81% |
1,54% |
|
|
2010/2011 |
5,77% |
2,93% |
7,98% |
14,79% |
7,23% |
2,86% |
1,71% |
|
|
2011/2012 |
5,61% |
3,13% |
8,22% |
15,60% |
7,38% |
2,96% |
1,90% |
|
|
2012/2013 |
5,47% |
3,13% |
8,08% |
15,60% |
6,73% |
2,94% |
1,93% |
|
|
2013/2014 |
5,74% |
3,22% |
8,61% |
16,01% |
6,80% |
2,75% |
2,11% |
|
|
2014/2015 |
5,42% |
3,18% |
8,15% |
16,16% |
7,08% |
2,86% |
2,14% |
|
|
2015/2016 |
5,63% |
3,28% |
8,04% |
16,33% |
6,96% |
3,04% |
2,44% |
|
|
2016/2017 |
5,51% |
3,54% |
8,23% |
15,77% |
7,12% |
3,23% |
2,55% |
|
|
2017/2018 |
5,69% |
3,57% |
8,34% |
15,67% |
7,17% |
3,11% |
2,59% |
|
|
2018/2019 |
5,86% |
3,51% |
8,83% |
15,77% |
7,17% |
3,01% |
2,75% |
|
|
2019/2020 |
4,54% |
3,33% |
9,54% |
16,61% |
7,37% |
2,91% |
3,06% |
Anche in questo caso segnaliamo la crescita percentuale del Trentino Alto Adige.
Veniamo ora al Centro. La tabella seguente espone i valori assoluti e le variazioni percentuali nelle singole regioni.
Tabella 289 . CENTRO. Numerosità dei dottorandi per regione. Anni accademici 2000/2001-2019/2020. Valori assoluti e variazioni percentuali. Fonte: ns. elaborazione dati USTAT-Miur.
|
Anno Accademico |
Lazio |
Marche |
Toscana |
Umbria |
Totale |
|
2000/2001 |
1016 |
488 |
2812 |
404 |
4720 |
|
2001/2002 |
1436 |
696 |
3507 |
434 |
6073 |
|
2002/2003 |
1730 |
960 |
3802 |
505 |
6997 |
|
2003/2004 |
4516 |
1118 |
4282 |
583 |
10499 |
|
2004/2005 |
5098 |
1008 |
4055 |
644 |
10805 |
|
2005/2006 |
4871 |
1115 |
4255 |
668 |
10909 |
|
2006/2007 |
5639 |
1117 |
4551 |
744 |
12051 |
|
2007/2008 |
4748 |
1146 |
4410 |
707 |
11011 |
|
2008/2009 |
5638 |
1117 |
4175 |
697 |
11627 |
|
2009/2010 |
5815 |
1106 |
3981 |
566 |
11468 |
|
2010/2011 |
5934 |
1041 |
3384 |
474 |
10833 |
|
2011/2012 |
6191 |
733 |
2750 |
354 |
10028 |
|
2012/2013 |
6311 |
950 |
2941 |
390 |
10592 |
|
2013/2014 |
6553 |
967 |
2368 |
457 |
10345 |
|
2014/2015 |
6157 |
1008 |
2970 |
492 |
10627 |
|
2015/2016 |
5909 |
878 |
2690 |
440 |
9917 |
|
2016/2017 |
5284 |
808 |
2594 |
376 |
9062 |
|
2017/2018 |
5169 |
756 |
2713 |
357 |
8995 |
|
2018/2019 |
5066 |
729 |
2815 |
404 |
9014 |
|
2019/2020 |
5021 |
723 |
2907 |
421 |
9072 |
|
Variaz. % 2000/2001 – 2019/2020 |
+394,19% |
+48,16% |
+3,38% |
+4,21% |
+92,20% |
|
Variaz. % 2008/2009 – 2019/2020 |
-10,94% |
-35,27% |
-30,37% |
-39,60% |
-21,97% |
In questo caso spicca la performance del Lazio ma, anche e in senso negativo, quella della Toscana, in cui sono tra l’altro tre delle Scuole Superiori ad ordinamento speciale.
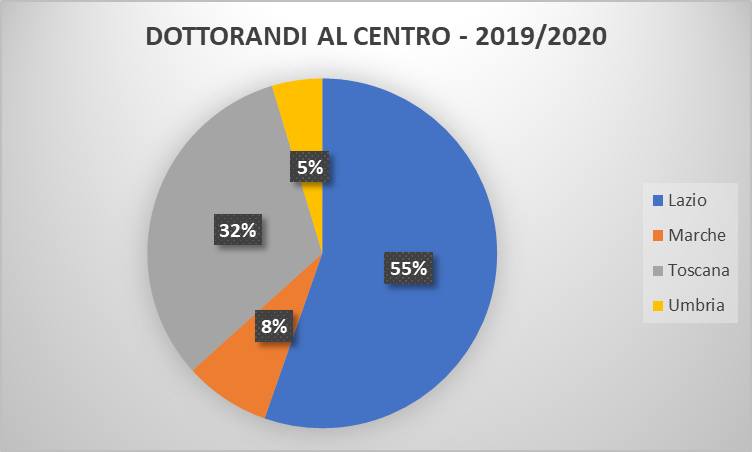
Figura 165 . CENTRO. Numerosità dei dottorandi per regione. Anno accademico 2019/2020. Valori percentuali sul totale dell’area. Fonte: ns. elaborazione dati USTAT-Miur.
Veniamo ora all’incidenza percentuale dei dottorandi delle regioni del Centro rispetto al totale nazionale.
Tabella 290 . CENTRO. Dottorandi per regione. Anni accademici 2000/2001-2019/2020. Valori percentuali sul totale nazionale. Fonte: ns. elaborazione dati USTAT-Miur.
|
Anno Accademico |
Lazio |
Marche |
Toscana |
Umbria |
|
2000/2001 |
4,81% |
2,31% |
13,31% |
1,91% |
|
2001/2002 |
5,46% |
2,65% |
13,33% |
1,65% |
|
2002/2003 |
5,78% |
3,21% |
12,70% |
1,69% |
|
2003/2004 |
12,76% |
3,16% |
12,10% |
1,65% |
|
2004/2005 |
13,59% |
2,69% |
10,81% |
1,72% |
|
2005/2006 |
12,73% |
2,91% |
11,12% |
1,75% |
|
2006/2007 |
14,05% |
2,78% |
11,34% |
1,85% |
|
2007/2008 |
12,10% |
2,92% |
11,24% |
1,80% |
|
2008/2009 |
14,35% |
2,84% |
10,63% |
1,77% |
|
2009/2010 |
15,17% |
2,88% |
10,38% |
1,48% |
|
2010/2011 |
16,31% |
2,86% |
9,30% |
1,30% |
|
2011/2012 |
17,75% |
2,10% |
7,88% |
1,01% |
|
2012/2013 |
18,07% |
2,72% |
8,42% |
1,12% |
|
2013/2014 |
19,56% |
2,89% |
7,07% |
1,36% |
|
2014/2015 |
18,79% |
3,08% |
9,06% |
1,50% |
|
2015/2016 |
19,69% |
2,93% |
8,96% |
1,47% |
|
2016/2017 |
18,99% |
2,90% |
9,32% |
1,35% |
|
2017/2018 |
18,17% |
2,66% |
9,53% |
1,25% |
|
2018/2019 |
17,19% |
2,47% |
9,55% |
1,37% |
|
2019/2020 |
16,93% |
2,44% |
9,80% |
1,42% |
|
Media 2000/2001 – 2019/2020 |
14,61% |
2,77% |
10,29% |
1,52% |
|
Media 2008/2009 – 2019/2020 |
17,58% |
2,73% |
9,16% |
1,37% |
Notiamo che il Lazio ha una incidenza media superiore a quella della Lombardia, mentre la Toscana si colloca come terza per peso percentuale medio del numero di iscritti alle sue Scuole di Dottorato sul totale nazionale.
Veniamo ora al Sud e alle Isole. La tabella seguente espone i valori assoluti e le variazioni percentuali nelle singole regioni.
Tabella 291 .SUD e ISOLE. Numerosità dei dottorandi per regione. Anni accademici 2000/2001-2019/2020. Valori assoluti e variazioni percentuali. Fonte: ns. elaborazione dati USTAT-Miur.
|
Anno Accademico |
Abruzzo |
Molise |
Basilicata |
Campania |
Calabria |
Puglia |
Sardegna |
Sicilia |
Totale |
|
2000/2001 |
495 |
82 |
121 |
2406 |
379 |
1334 |
434 |
2285 |
7536 |
|
2001/2002 |
619 |
119 |
152 |
3508 |
468 |
1786 |
400 |
2466 |
9518 |
|
2002/2003 |
747 |
141 |
187 |
3432 |
718 |
2141 |
468 |
2577 |
10411 |
|
2003/2004 |
842 |
151 |
182 |
3565 |
883 |
2281 |
608 |
2749 |
11261 |
|
2004/2005 |
910 |
151 |
189 |
3669 |
952 |
2583 |
864 |
2923 |
12241 |
|
2005/2006 |
1003 |
172 |
184 |
3688 |
815 |
2508 |
717 |
3072 |
12159 |
|
2006/2007 |
929 |
167 |
194 |
3455 |
860 |
2585 |
758 |
3173 |
12121 |
|
2007/2008 |
814 |
104 |
204 |
3330 |
723 |
2115 |
916 |
3518 |
11724 |
|
2008/2009 |
841 |
75 |
192 |
3247 |
770 |
1752 |
846 |
3565 |
11288 |
|
2009/2010 |
894 |
91 |
186 |
3210 |
837 |
2051 |
786 |
2972 |
11027 |
|
2010/2011 |
927 |
62 |
162 |
2986 |
832 |
1598 |
840 |
2392 |
9799 |
|
2011/2012 |
1016 |
104 |
182 |
2883 |
756 |
1526 |
930 |
1824 |
9221 |
|
2012/2013 |
880 |
86 |
180 |
2930 |
714 |
1340 |
1073 |
1803 |
9006 |
|
2013/2014 |
817 |
124 |
180 |
2520 |
681 |
1236 |
949 |
1500 |
8007 |
|
2014/2015 |
771 |
109 |
143 |
2614 |
600 |
1028 |
825 |
1312 |
7402 |
|
2015/2016 |
578 |
110 |
134 |
2323 |
555 |
817 |
657 |
1199 |
6373 |
|
2016/2017 |
582 |
96 |
117 |
2134 |
521 |
842 |
543 |
1142 |
5977 |
|
2017/2018 |
680 |
99 |
118 |
2201 |
570 |
971 |
571 |
1121 |
6331 |
|
2018/2019 |
741 |
102 |
126 |
2339 |
549 |
976 |
563 |
1245 |
6641 |
|
2019/2020 |
749 |
116 |
133 |
2191 |
470 |
974 |
555 |
1351 |
6539 |
|
Variaz. % 2000/2001 – 2019/2020 |
+51,31% |
+41,46% |
+9,92% |
-8,94% |
+24,01% |
-26,99% |
+27,88% |
-40,88% |
-13,23% |
|
Variaz. % 2008/2009 – 2019/2020 |
-10,94% |
+54,67% |
-30,73% |
-32,52% |
-38,96% |
-44,41% |
-34,40% |
-62,10% |
-42,07% |
Fatta eccezione per il Molise, le variazioni percentuali dall’anno accademico 2008/2009 all’anno accademico 2019/2020g assumono le dimensioni di un vero e proprio esodo, che, almeno in parte, partecipa della migrazione intellettuale verso aree – dentro e fuori il nostro Paese – che offrono migliori possibilità di lavoro e di carriera accademica (cfr. Bibliografia tematica par. 4. Sulla mobilità studentesca).
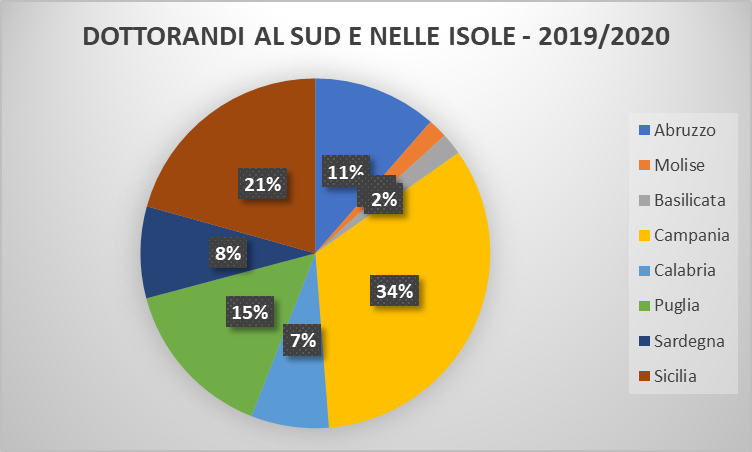
Figura 166 . SUD e ISOLE. Numerosità dei dottorandi per regione. Anno accademico 2019/2020. Valori percentuali sul totale dell’area. Fonte: ns. elaborazione dati USTAT-Miur.
Vediamo ora l’incidenza percentuale dei dottorandi del Sud e delle Isole nelle regioni sul loro totale nazionale.
Tabella 292 . SUD e ISOLE. Dottorandi per regione. Anni accademici 2000/2001-2019/2020. Valori percentuali sul totale nazionale. Fonte: ns. elaborazione dati USTAT-Miur.
|
Anno Accademico |
Abruzzo |
Molise |
Basilicata |
Campania |
Calabria |
Puglia |
Sardegna |
Sicilia |
|
2000/2001 |
2,34% |
0,39% |
0,57% |
11,39% |
1,79% |
6,31% |
2,05% |
10,82% |
|
2001/2002 |
2,35% |
0,45% |
0,58% |
13,34% |
1,78% |
6,79% |
1,52% |
9,38% |
|
2002/2003 |
2,49% |
0,47% |
0,62% |
11,46% |
2,40% |
7,15% |
1,56% |
8,61% |
|
2003/2004 |
2,38% |
0,43% |
0,51% |
10,07% |
2,50% |
6,45% |
1,72% |
7,77% |
|
2004/2005 |
2,43% |
0,40% |
0,50% |
9,78% |
2,54% |
6,88% |
2,30% |
7,79% |
|
2005/2006 |
2,62% |
0,45% |
0,48% |
9,64% |
2,13% |
6,56% |
1,87% |
8,03% |
|
2006/2007 |
2,32% |
0,42% |
0,48% |
8,61% |
2,14% |
6,44% |
1,89% |
7,91% |
|
2007/2008 |
2,07% |
0,27% |
0,52% |
8,49% |
1,84% |
5,39% |
2,33% |
8,97% |
|
2008/2009 |
2,14% |
0,19% |
0,49% |
8,27% |
1,96% |
4,46% |
2,15% |
9,08% |
|
2009/2010 |
2,33% |
0,24% |
0,49% |
8,37% |
2,18% |
5,35% |
2,05% |
7,75% |
|
2010/2011 |
2,55% |
0,17% |
0,45% |
8,21% |
2,29% |
4,39% |
2,31% |
6,57% |
|
2011/2012 |
2,91% |
0,30% |
0,52% |
8,27% |
2,17% |
4,38% |
2,67% |
5,23% |
|
2012/2013 |
2,52% |
0,25% |
0,52% |
8,39% |
2,04% |
3,84% |
3,07% |
5,16% |
|
2013/2014 |
2,44% |
0,37% |
0,54% |
7,52% |
2,03% |
3,69% |
2,83% |
4,48% |
|
2014/2015 |
2,35% |
0,33% |
0,44% |
7,98% |
1,83% |
3,14% |
2,52% |
4,00% |
|
2015/2016 |
1,93% |
0,37% |
0,45% |
7,74% |
1,85% |
2,72% |
2,19% |
4,00% |
|
2016/2017 |
2,09% |
0,35% |
0,42% |
7,67% |
1,87% |
3,03% |
1,95% |
4,10% |
|
2017/2018 |
2,39% |
0,35% |
0,41% |
7,74% |
2,00% |
3,41% |
2,01% |
3,94% |
|
2018/2019 |
2,51% |
0,35% |
0,43% |
7,93% |
1,86% |
3,31% |
1,91% |
4,22% |
|
2019/2020 |
2,53% |
0,39% |
0,45% |
7,39% |
1,59% |
3,28% |
1,87% |
4,56% |
|
Media 2000/2001 – 2019/2020 |
2,38% |
0,35% |
0,49% |
8,91% |
2,04% |
4,85% |
2,14% |
6,62% |
|
Media 2008/2009 – 2019/2020 |
2,39% |
0,31% |
0,47% |
7,96% |
1,97% |
3,75% |
2,29% |
5,26% |
Per concludere, esaminiamo la distribuzione dei dottorandi nelle università statali, non statali e telematiche, in percentuale sul totale. La percentuale di crescita dei dottorandi nelle università non statali calcolata sui valori assoluti è – dal 2000/2001 al 2019/2020 – del 159,57%.
Tabella 293 . Dottorandi grandezza e tipologia dell’ateneo. Anni accademici 2000/2001-2019/2020. Valori percentuali sul totale nazionale. Fonte: ns. elaborazione dati USTAT-Miur.
|
Anno Accademico |
Statali |
Non Statali |
Telematiche |
|
2000/2001 |
97,35% |
2,65% |
0,00% |
|
2001/2002 |
97,42% |
2,58% |
0,00% |
|
2002/2003 |
97,23% |
2,77% |
0,00% |
|
2003/2004 |
96,87% |
3,13% |
0,00% |
|
2004/2005 |
96,59% |
3,41% |
0,00% |
|
2005/2006 |
96,42% |
3,58% |
0,00% |
|
2006/2007 |
96,41% |
3,58% |
0,01% |
|
2007/2008 |
94,78% |
3,64% |
0,02% |
|
2008/2009 |
95,45% |
3,81% |
0,03% |
|
2009/2010 |
95,95% |
4,00% |
0,04% |
|
2010/2011 |
95,64% |
4,25% |
0,07% |
|
2011/2012 |
95,36% |
4,47% |
0,18% |
|
2012/2013 |
95,38% |
4,35% |
0,27% |
|
2013/2014 |
95,06% |
4,63% |
0,30% |
|
2014/2015 |
95,36% |
4,27% |
0,38% |
|
2015/2016 |
95,47% |
4,45% |
0,08% |
|
2016/2017 |
95,53% |
4,45% |
0,02% |
|
2017/2018 |
95,04% |
4,64% |
0,32% |
|
2018/2019 |
94,80% |
4,87% |
0,33% |
|
2019/2020 |
94,60% |
4,89% |
0,50% |
Tabella 294 . Università Statali . Distribuzione dei dottorandi per grandezza e tipologia dell’ateneo. Anni accademici 2000/2001-2019/2020. Valori percentuali sul totale nazionale. Fonte: ns. elaborazione dati USTAT-Miur.
|
Anno Accademico |
Mega |
Grandi |
Medie |
Piccole |
Politecnici |
Scuole Superiori |
|
2000/2001 |
42,17% |
28,72% |
15,45% |
3,67% |
5,12% |
2,23% |
|
2001/2002 |
41,92% |
27,57% |
16,52% |
4,13% |
4,98% |
2,31% |
|
2002/2003 |
39,86% |
27,44% |
18,12% |
4,75% |
5,40% |
1,65% |
|
2003/2004 |
43,08% |
26,46% |
16,56% |
4,68% |
4,69% |
1,41% |
|
2004/2005 |
41,52% |
27,02% |
16,93% |
4,85% |
4,73% |
1,54% |
|
2005/2006 |
41,22% |
26,74% |
16,53% |
5,25% |
4,82% |
1,85% |
|
2006/2007 |
40,67% |
26,77% |
17,48% |
4,93% |
4,67% |
1,90% |
|
2007/2008 |
40,76% |
25,88% |
16,03% |
5,06% |
4,73% |
2,32% |
|
2008/2009 |
39,24% |
28,93% |
15,31% |
4,78% |
4,78% |
2,40% |
|
2009/2010 |
38,66% |
28,25% |
16,41% |
4,97% |
4,85% |
2,81% |
|
2010/2011 |
38,17% |
28,24% |
16,43% |
4,74% |
5,61% |
2,43% |
|
2011/2012 |
37,72% |
28,93% |
16,28% |
4,49% |
6,29% |
1,65% |
|
2012/2013 |
36,80% |
28,91% |
15,94% |
5,24% |
5,56% |
2,94% |
|
2013/2014 |
36,89% |
29,25% |
16,35% |
5,37% |
5,80% |
1,41% |
|
2014/2015 |
37,00% |
27,76% |
16,15% |
4,68% |
6,42% |
3,35% |
|
2015/2016 |
36,89% |
27,63% |
15,43% |
4,82% |
6,88% |
3,82% |
|
2016/2017 |
37,76% |
26,42% |
15,26% |
5,05% |
6,83% |
4,19% |
|
2017/2018 |
37,95% |
25,89% |
15,19% |
4,85% |
7,05% |
4,11% |
|
2018/2019 |
37,56% |
26,16% |
14,99% |
4,72% |
7,27% |
4,10% |
|
2019/2020 |
37,65% |
26,70% |
15,45% |
4,64% |
6,34% |
3,82% |
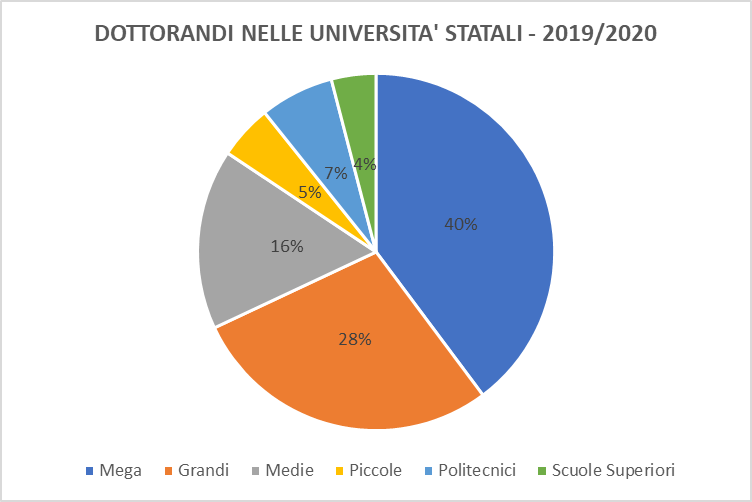
Figura 167 . Università Statali . Distribuzione dei dottorandi per grandezza e tipologia dell’ateneo. Anno accademico 2019/2020. Valori percentuali sul totale del sistema statale. Fonte: ns. elaborazione dati USTAT-Miur.
Tabella 295 . Università non Statali . Distribuzione dei dottorandi grandezza e tipologia dell’ateneo. Anni accademici 2000/2001-2019/2020. Valori percentuali sul totale nazionale. Fonte: ns. elaborazione dati USTAT-Miur.
|
Anno Accademico |
Non statali Grandi |
Non statali Medie |
Non statali Piccole |
|
2000/2001 |
2,31% |
0,28% |
0,05% |
|
2001/2002 |
1,96% |
0,56% |
0,06% |
|
2002/2003 |
2,15% |
0,45% |
0,17% |
|
2003/2004 |
2,17% |
0,70% |
0,25% |
|
2004/2005 |
2,26% |
0,81% |
0,34% |
|
2005/2006 |
2,34% |
0,80% |
0,44% |
|
2006/2007 |
2,24% |
0,76% |
0,58% |
|
2007/2008 |
2,24% |
0,75% |
0,65% |
|
2008/2009 |
2,20% |
0,81% |
0,79% |
|
2009/2010 |
2,12% |
0,89% |
0,99% |
|
2010/2011 |
2,15% |
0,95% |
1,14% |
|
2011/2012 |
2,21% |
0,92% |
1,33% |
|
2012/2013 |
2,10% |
0,87% |
1,38% |
|
2013/2014 |
2,29% |
0,98% |
1,36% |
|
2014/2015 |
2,24% |
0,88% |
1,14% |
|
2015/2016 |
2,47% |
0,81% |
1,18% |
|
2016/2017 |
2,33% |
0,91% |
1,21% |
|
2017/2018 |
2,27% |
0,89% |
1,48% |
|
2018/2019 |
2,27% |
0,89% |
1,72% |
|
2019/2020 |
2,27% |
0,93% |
1,70% |
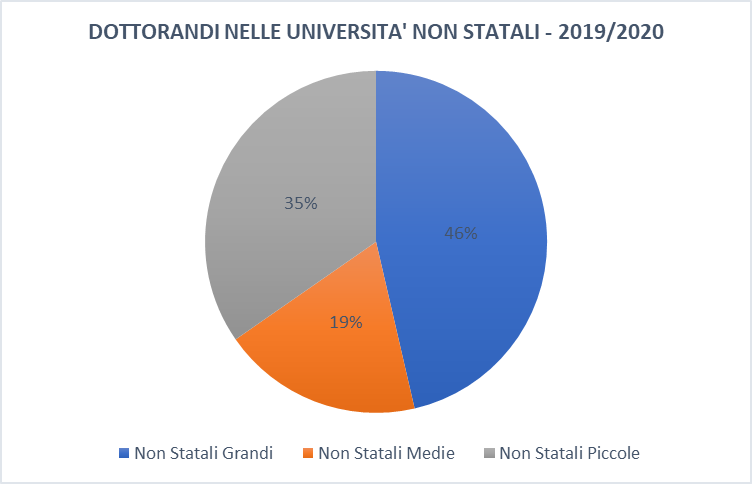
Figura 168 . Università non Statali . Distribuzione dei dottorandi per grandezza e tipologia dell’ateneo. Anno accademico 2019/2020. Valori percentuali sul totale del sistema non statale. Fonte: ns. elaborazione dati USTAT-Miur.
[69] Per gli RTD-B questa quasi-certezza è prevista dalla legge 240/2010; per i ricercatori a tempo indeterminato la cosa è più aleatoria e soggetta alle risorse e ai punti organico (e dunque, in ultima analisi, alle volontà della politica).
[70] Per la legge 120/2020: art. 19, co. 1, lett. f , l’università che abbia le necessarie risorse nella propria programmazione, nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per l’inquadramento nella qualifica di professore associato, ha facoltà di anticipare l’inquadramento dopo il primo anno del contratto, previo esito positivo della valutazione dell’ateneo. In tali casi la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell’ambito del settore scientifico-disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.
[71] A parte il caso già citato dei ricercatori assunti nel 2010 in Lombardia, che riguarda l’Area 13 – Scienze economiche e statistiche, le aree in cui il reclutamento inizia con un 100% di uomini sono Area 12 – Scienze giuridiche (nel 2011), Area 02 – Scienze fisiche (nel 2012), Area 05 – Scienze biologiche (nel 2012), Area 06 – Scienze mediche (nel 2012), Area 08 – Ingegneria civile e Architettura (nel 2012), Area 04 – Scienze della terra (nel 2013).
[72] Tali dati sono stati forniti da Daniele Livon nel suo intervento “ Le politiche di reclutamento delle Università tra VQR e ASN ” nel convegno L’esperienza della valutazione della ricerca in Italia: un primo bilancio , organizzato dall’Accademia Nazionale dei Lincei e tenutosi sulla piattaforma Zoom, Canale Lincei, il 24 febbraio 2021.
[73] Abbiamo derivato i dati relativi agli RTD-B dalla slide Reclutamento (posizioni interne e assunzioni dall’esterno) 2016-2019 per area CUN e qualifica dell’ intervento citato .
[74] Daniele Livon è, alla data in cui tiene il suo intervento, il direttore e il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca.
[75] Cfr. adunanza dell’8 novembre 2018: https://www.cun.it/uploads/6995/ra_2018_11_08.pdf .
[76] È altamente probabile che vi siano sovrapposizioni fra gli oltre 16.000 abilitati alla prima e alla seconda fascia esterni e gli assegnisti. Questa verifica non è stata fatta. I dati disponibili sugli assegnisti riguardano il solo 2020 e l’appartenenza a questa categoria è per sua natura instabile. La verifica non avrebbe dato, dunque, risultati utili.
[77] Tali dati sono stati forniti da Daniele Livon nel suo intervento “ Le politiche di reclutamento delle Università tra VQR e ASN ” nel convegno L’esperienza della valutazione della ricerca in Italia: un primo bilancio , organizzato dall’Accademia Nazionale dei Lincei e tenutosi sulla piattaforma Zoom, Canale Lincei, il 24 febbraio 2021.
[78] Abbiamo derivato i dati relativi agli RTD-A dalla slide Reclutamento (posizioni interne e assunzioni dall’esterno) 2016-2019 per area CUN e qualifica dell’ intervento citato .
[79] Daniele Livon è, alla data in cui tiene il suo intervento, il direttore e il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca.
[80] Serie Personale Accademico – profilo. Serie storica dal 2012 del personale docente e ricercatore disaggregato per genere, classe di età, ateneo, area geografica e grade (codifica internazionale della qualifica) . Nostre elaborazioni: Pivot 4.
[81] Tali dati sono stati derivati dalla slide Reclutamento (posizioni interne e assunzioni dall’esterno) 2016-2019 per area CUN e qualifica dell’intervento di Daniele Livon (“ Le politiche di reclutamento delle Università tra VQR e ASN ”) nel convegno L’esperienza della valutazione della ricerca in Italia: un primo bilancio , organizzato dall’Accademia Nazionale dei Lincei e tenutosi sulla piattaforma Zoom, Canale Lincei, il 24 febbraio 2021.
[82] Daniele Livon è, alla data in cui tiene il suo intervento, il direttore e il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca.
[83] Tali dati sono stati derivati dalla slide Reclutamento (posizioni interne e assunzioni dall’esterno) 2016-2019 per area CUN e qualifica dell’intervento di Daniele Livon (“ Le politiche di reclutamento delle Università tra VQR e ASN ”), cit.
[84] Nel file c’è anche una categoria di contratti denominata “Altro” (cod.99).
[85] Nostre elaborazioni: Pivot 5.
[86] Fanno eccezione i contratti di formazione specialistica dell’area sanitaria, evidentemente di Area 06.
[87] Fonte: ns. elaborazione del file Dati relativi al personale universitario: 2015-2019 personale docente a contratto per area scientifico-disciplinare , USTAT-Miur, Opendata .
[88] USTAT-Miur, Opendata, Iscritti per ateneo – serie storica a partire dall’anno accademico 2010/11 .
[89] Esclusi i docenti e i ricercatori della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste (SISSA).
[90] Esclusi i docenti dell’Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia (IUSS).
[91] Esclusi i docenti e i ricercatori di: Scuola IMT Alti Studi di Lucca, Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant’Anna di Pisa e Scuola Normale Superiore di Pisa.
[92] Esclusi i docenti e i ricercatori del Gran Sasso Science Institute (GSSI).
[93] Cfr. IX Indagine ADI su Dottorato e Postdoc: https://dottorato.it/content/ix-indagine-adi-su-dottorato-e-postdoc-abolire-lassegno-di-ricerca .
[94] Fonte: USTAT-Miur – Dottorati di ricerca – Iscritti per ateneo: http://dati.ustat.miur.it/dataset/99c3fde2-d329-4e43-9116-9c8917680061/resource/03e1981b-6581-42f6-a99b-9c977131f67e/download/dottorati_iscritti_ateneo.csv . Nostre elaborazioni: Pivot 3.